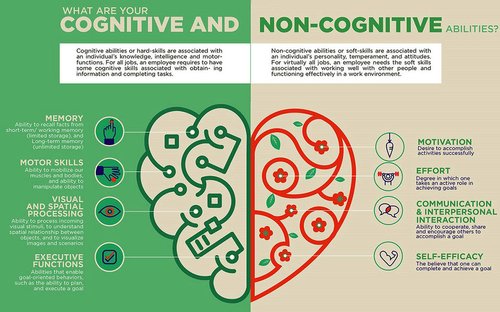Silvestro Lega e altri macchiaioli
5 Agosto 2022


Telemaco Signorini
5 Agosto 2022“La vita agra” di Bianciardi è stato il primo romanzo italiano della contestazione, la prima rilevante testimonianza letteraria di uno stato di profondo malessere politico, sociale ed esistenziale.
Questo libro amaro e divertentissimo, garbato e feroce, suscita interrogativi e squarcia veli su una realtà scomoda, che si nasconde sotto le luci abbaglianti del miracolo economico italiano
L’autore
Luciano Bianciardi nasce a Grosseto nel 1922. Nel 1947 si laurea in filosofia all’Università di Pisa. Bibliotecario e quindi professore di liceo, esordisce come narratore scrivendo, in collaborazione con Carlo Cassola, “I minatori della Maremma” (Bari, 1955). Lascia l’insegnamento e si trasferisce a Milano dove lavora come redattore editoriale e giornalista. Pubblica due romanzi-pamphlet: “Il lavoro culturale” (Milano, 1957), rappresentazione della vita di provincia, e “L’integrazione” (Milano, 1960), rappresentazione del mondo culturale della Milano del “miracolo economico“, prima del suo romanzo più importante, “La vita agra” del 1962, da cui fu tratto un film nel 1964. Dopo questa felice stagione di testi sulla attualità, si rifugiò stancamente nella divulgazione storica, sempre più solo ed emarginato, fino alla sua morte a soli 49 anni non ancora compiuti, per una malattia legata all’alcol.
Introduzione al libro
“La vita agra” di Bianciardi è stato il primo romanzo italiano della contestazione, la prima rilevante testimonianza letteraria di uno stato di profondo malessere politico, sociale ed esistenziale. Questo libro amaro e divertentissimo, garbato e feroce, suscita interrogativi e squarcia veli su una realtà scomoda, che si nasconde sotto le luci abbaglianti del miracolo economico italiano.
Sintesi del romanzo
Milano 1962: il miracolo economico, la febbre dei consumi, la strategia aziendale, la disumanità dei rapporti, le delusioni politiche, il bisogno di denaro (i dané), il tram e la televisione, gli scocciatori telefonici e gli scaldabagni esplosivi, la nebbia e i lavori stradali e gli automobilisti viperini del lunedì e lo sciroppo alla codeina – droga casalinga contro la tosse della nevrosi – a poco a poco stringono in una morsa irresistibile e grottesca l’intellettuale anarchico venuto dalla provincia, col candido proposito di far saltare in aria la sede di una grande società chimico-mineraria. Il poveretto soccombe, prosciugato e strizzato ben bene di tutti i suoi umori, i suoi ideali, i suoi anticonformismi: si rifugia nel sonno, che gli consente, per sei ore, di non esistere.
Incipit del romanzo:
La Biblioteca Nazionale Braidense
Storto d’occhi ma dritto d’animo, il pio Adalgiso (Guercio, da cui il nome popolano del luogo “Braida del Guercio”, cioè Terreno del Cieco) fece dono delle sue case all’ordine degli Umiliati, del quale per la verità so poco: so che in quelle case del Guercio misero la loro prepositura, che poco dopo l’ordine si estinse, e che la Braida passò automaticamente al cardinale arcivescovo monsignor Chiesa. Più tardi un sant’uomo, Carlo Borromeo, destinò là dentro i compagni di Gesù, che vi tennero la loro casa insegnante. Ma intanto la vecchia Braida del Guercio, che nessuno ormai chiamava più così, era diventata un palazzo, e più precisamente un’ala del palazzo odierno, quella che guarda. sulla via Adelantemi. Guarda per modo di dire, perché le finestre sono sbarrate, e le mura massicce di un rosso ferrigno, con un’aria complessiva di fortilizio. Come tutti sanno, nel 1773 i compagni di Gesù si scompagnarono e così quelli della Braida smisero di insegnare, e proprio allora la cattolicissima imperatrice Maria Teresa, saggiamente consigliata dal principe Kautnitz, riunì là dentro il lascito librario del munifico conte Pertusati, la vecchia biblioteca dell’ordine, altre raccolte minori, e aprì alla cittadinanza colta una nuova e doviziosa fonte del sapere.
Capitolo secondo
Dalla sede centrale – appunto la cittadella coi torracchioni lucidi – mandarono l’uomo delle acciaierie, un tipo grosso e cupo, coi baffi e la moglie schizzinosa e scontenta, di vedersi sbattere dalla mattina alla sera in un posto così, senza nemmeno un cinematografo frequentabile e, per compagnia, le mogli dei capiservizio. […]
Gli operai facevano festa, ecco; era la festa dei lavoratori, e lui – lavorava come gli altri, o forse no? – l’aveva passata alla bocca del pozzo nove bis, con l’ingegnere e i muratori. Non era mica andato a spassarsela a Follonica o a sentire il comizio. Due giorni di festa per loro, due giorni di bile per lui. Ma la mattina del tre la festa era finita, e allora sotto a levare lignite. Si erano riposati abbastanza o no, questi pelandroni? Eppure il caposquadra aveva fatto storie: diceva che dopo due giorni senza ventilazione, giù sotto, era pericoloso scendere, bisognava aspettare altre ventiquattr’ore, far tirare l’aspiratore a vuoto, perché si scaricassero i gas di accumulo.
Insomma, pur di non lavorare qualunque pretesto era buono. L’aspiratore nuovo, i gas di accumulo, i fuochi alla discenderia 32 – come se i fuochi non ci fossero sempre, in un banco di lignite. Stavolta era stufo: meno storie, disse ai capisquadra, mandate cinque uomini della squadra antincendi a spegnere i fuochi, ma intanto sotto anche la prima gita. La mattina del giorno dopo, alle sette, la miniera esplose.
4 maggio 1954: 43 operai morti nell’esplosione della miniera di lignite a Ribolla (GR)
Rimasi quattro giorni nella piana sotto Montemassi, dallo scoppio fino ai funerali, e li vidi tirare su quarantatré morti, tanti fagotti dentro una coperta militare. Li portavano all’autorimessa per ricomporli e incassarli, mentre il procuratore della repubblica accertava che fossero morti davvero, in caso di contestazione, poi, da parte della sede centrale. Alla sala del cinema, ora per ora, cresceva la fila delle bare sotto il palcoscenico, ciascuna con sopra l’elmetto di materia plastica, e in fondo le bandiere rosse. Venivano a vederli da tutte le parti d’Italia, giornalisti con la camicia a scacchi, il berrettino e la pipetta, critici d’arte, sindacalisti, monsignor vescovo, un paio di ministri che però furono buttati fuori in malo modo.
Passaggio dal secondo al terzo capitolo
Nella bacheca al cancello stava scritto che alle famiglie delle vittime il ministero offriva contribuzioni straordinarie e immediate varianti dalle 60 alle 100 mila lire, oltre il normale trattamento previdenziale previsto dall’Inail. La direzione offriva assegni assistenziali di 500 mila lire e di un milione, secondo i relativi carichi familiari. A conti fatti ci scapitava una ventina di milioni. Ma in compenso poteva chiudere subito la miniera.
Ora appunto io venivo ogni giorno a guardare il torracchione di vetro e di cemento, chiedendomi a quale finestra, in quale stanza, in quale cassetto, potevano aver messo la pratica degli assegni assistenziali, dove la cartella personale di Femia, di Calabrò, di tutti e quarantatré i morti del quattro maggio.
Chiedendomi dove, in che cantone, in che angolo, inserire un tubo flessibile ma resistente per farci poi affluire il metano, tanto metano da saturare tutto il torracchione; metano miscelato con aria in proporzioni fra il sei e il sedici per cento. Tanto ce ne vuole perché diventi grisù, un miscuglio gassoso esplosivo se lo inneschi a contatto con qualsiasi sorgente di calore superiore ai seicento gradi centigradi. La missione mia, di cui dicevo pocanzi, era questa: far saltare tutti e quattro i palazzi e, in ipotesi secondaria, occuparli, sbattere fuori le circa duemila persone che ci lavoravano, chine sul fatturato, sui disegni tecnici e sui testi delle umane relazioni, e poi tenerli a disposizione di altra gente.
Settimo capitolo
Ogni giorno io trascorrevo in tram almeno un’ora e mezzo. Bene, chi non sa può forse credere che, viaggiando su quel mezzo pubblico quarantacinque ore ogni mese, in capo all’anno uno debba avere fatto centinaia di conoscenze, decine di amicizie.
Per esempio, quelli che per ragioni di lavoro prendono ogni giorno l’accelerato fra Follonica e il paese mio, li vedrete salutare dal finestrino casellanti e capistazione, preoccuparsi se a Giuncarico non sale, come ogni mattina, il Marraccini, e poi domandare perché e come sta, ai conoscenti. Il conduttore nemmeno chiede più il biglietto, caso mai si ferma un momento, ti si siede accanto, accetta una sigaretta, s’informa se andrai anche tu a ballare a Braccagni, il sabato.
Qui no. Ogni mattina la gita in tram è un viaggio in compagnia di estranei che non si parlano, anzi di nemici che si odiano. C’è anche un cartello che vieta le discussioni col personale, e minaccia l’articolo 344 del codice, contro l’ingiuria nei suoi confronti. Così la gente subisce spaurita e silenziosa i rabbuffi gutturali del bigliettaio, che sollecita continuo e insistente di andare avanti, come facevano un tempo le zie dei casini, e dosa parsimoniosamente l’apertura delle porte automatiche, e si richiama quando necessario al regolamento. “Siamo passibili di sanzioni disciplinari” precisa. […]
Settimo capitolo
Il contadino appartiene alle attività primarie, e l’operaio alle secondarie. L’uno produce dal nulla, l’altro trasforma una cosa in un’altra. Il metro di valutazione, per l’operaio e per il contadino, è facile, quantitativo: se la fabbrica sforna tanti pezzi all’ora, se il podere rende. Nei nostri mestieri, è diverso, non ci sono metri di valutazione quantitativa. Come si misura la bravura di un prete o di un pubblicitario? Costoro né producono dal nulla, né trasformano. Non sono né primari né secondari. Terziari sono e anzi oserei dire, addirittura quartari. Non sono strumenti di produzione, e nemmeno cinghie di trasmissione. Sono lubrificante, al massimo, sono vaselina pura. Come si può valutare un prete o un pubblicitario? Come si fa a calcolare la quantità di fede, di desiderio, di acquisto, di simpatia che costoro saranno riusciti a far sorgere? No, non abbiamo altro metro se non la capacità di ciascuno di restare a galla, e di salire più su, insomma di diventare vescovo. In altre parole, a chi scelga una professione terziaria o quartaria occorrono doti e attitudini di tipo politico. La politica, come tutti sanno, ha cessato da molto tempo di essere scienza del buon governo, ed è diventata invece arte della conquista e della conservazione del potere. Così la bontà di un uomo politico non si misura sul bene che egli riesce a fare agli altri, ma sulla rapidità con cui arriva al vertice e sul tempo che vi si mantiene. E la lotta politica, cioè la lotta per la conquista e la conservazione del potere, non è ormai più – apparenze a parte – fra stato e stato, tra fazione e fazione, ma interna allo stato, interna alla fazione. Allo stesso modo, nelle professioni terziarie e quartarie, non esistendo alcuna visibile produzione di beni che funga da metro, il criterio sarà quello. […] La concorrenza […] L’importante è fare le scarpe al capufficio, al collega, a chi ti lavora accanto.
Ottavo capitolo
Insomma devi farli godere, e impegnarti a tutelare e favorire il loro godimento […]
Explicit: finale del libro all’undicesimo cap.
È meglio starsene a casa. […] e lo sciroppetto al faggio o al pino giovane, corretto con la codeina che blocca i centri nervosi della tosse (mentre il faggio e il pino, balsamici, favoriscono l’espettorazione) io me lo prendo sempre prima di dormire. Lo sciroppetto, o anche le perline, poi mi verso un altro bicchierino, lo metto sul tavolo basso fra i due letti gemelli, con accanto il pacchetto delle sigarette belghe e i cerini, vado a scegliere un libro, mi spoglio e leggo un po’. Legge anche Anna, di solito sceglie autori dell’Ottocento francese, ma nel testo originale, così fa anche pratica, e ogni tanto me ne traduce qualche riga, e commenta. La codeina non blocca soltanto i centri della tosse; credo che li blocchi un po’ tutti, infatti sento che presto arriverà il sonno. […]
Io resto lì mezzo coricato, coi pensieri sempre più nebbiosi. […] Poi il sonno è già arrivato e per sei ore io non ci sono più. Milano, inverno ’61-62