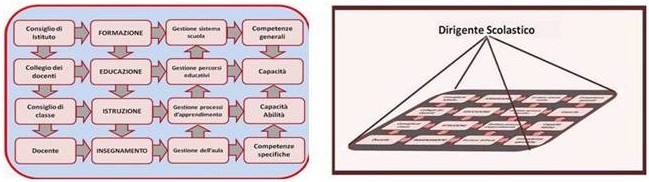Giovanna Megna
27 Gennaio 2019
Rosanna Mutinelli
27 Gennaio 2019Prof.ssa Giovanna Megna
Presso le comunità preistoriche la pena di morte era sicuramente comminata abbondantemente, ma non sono rimaste testimonianze di codici penali scritti. Infatti, le leggi erano tramandate oralmente, ed erano applicate in modo generalmente abbastanza soggettivo e arbitrario da parte dei capi o di altri incaricati.
La pena capitale era applicata principalmente per crimini come omicidio e furto, e probabilmente anche per delitti di lesa maestà e sacrilegi.
Presso i Babilonesi la pena di morte era ancora largamente utilizzata, ma ci fu una novità molto importante: la comparsa del primo codice scritto, il Codice di Hammurabi. In questo codice la pena capitale è largamente prevista, per crimini come furto, omicidio e mancanze commesse nell’esecuzione del proprio lavoro (es.: Posto che un costruttore a un uomo abbia edificato una casa, ma la sua opera non abbia fatto salda e la casa che edificò sia crollata ed abbia ucciso il padrone della casa, questo costruttore sarà ucciso). Non è un codice equo, in quanto la gravità della colpa e della pena comminata dipende dalla classe sociale a cui appartengono il colpevole e la vittima: lo schiavo ha minor valore del nobile ed è soggetto a pene più dure per i medesimi reati.
Esso è pur sempre però una grande conquista, perché elimina arbitrarietà e soggettività dai giudizi, essendoci leggi scritte. Il suo limite è quello di essere troppo particolareggiato: infatti non prende in considerazione un campo di delitti simili, ma li elenca in modo molto preciso.
Presso gli Egizi, la pena capitale era applicata per coloro che infrangevano Maat, la Regola universale rigorosamente osservata in Egitto. Questa legge comprende crimini come omicidio, furto, sacrilegio, attentato contro il Faraone (visto come un garante della Regola), spionaggio, infrazioni fiscali; oppure per i medici che, non utilizzando terapie tradizionali, non riuscivano a salvare la vita dei pazienti. Non esisteva arbitrarietà, e le sentenze erano uguali per tutti, ricchi e poveri, nobili e umili; o almeno in teoria così avrebbe dovuto essere.
La pena di morte era applicata tramite la decapitazione, il sacrificio, o l’annegamento nel Nilo all’interno di un sacco chiuso.
Presso le civiltà precolombiane non esistevano le carceri; il furto veniva punito con la schiavitù e l’omicidio con la morte, se il colpevole non fosse riuscito a procurare un risarcimento alle vittime; il codice morale non distingueva tra omicidio colposo e volontario. Anche l’adulterio, considerato come un reato contro la proprietà, era ugualmente punito con la morte: il colpevole veniva consegnato al marito offeso, che lo uccideva lasciandogli cadere sul capo, dall’alto, una grande pietra.
Nella polis greca la permanenza della pena di morte ha subito ripensamenti e attenuazioni, specie nelle vicende politiche e costituzionali di Atene, registrando il graduale superamento del concetto di punizione come vendetta, anche se a lungo le esecuzioni erano state lasciate all’iniziativa dei familiari della vittima.
In alcune opere di Platone vengono considerate da un lato l’utilità delle pene per l’emendazione del colpevole e per la prevenzione di ulteriori mali, dall’altro l’eccezionalità della pena di morte da comminare in casi gravissimi (sacrilegio, omicidio di parenti, crimini contro lo Stato) e nei confronti degli incorreggibili, rifacendosi alla legge del taglione. Ecco cosa dice Platone nelle sue Leggi:
“…se uno è riconosciuto colpevole di siffatto omicidio, avendo ucciso qualcuna delle suddette persone, i servi dei giudici e i magistrati lo uccideranno e lo getteranno nudo in un trivio prestabilito, fuori della città; tutti i magistrati portino una pietra in nome di tutto lo Stato scagliandola sul capo del cadavere, poi lo portino ai confini dello Stato e lo gettino al di là insepolto; questa è la legge”.
In età romana, almeno nei primi secoli, l’autorità pubblica interveniva solo per punire i delitti che in qualche modo avessero violato l’ordine generale e che venivano perciò considerati di pubblico tradimento. E in questi casi interveniva in modo molto duro, spesso con la pena capitale. Per i delitti privati si applicava invece la legge del taglione, che spesso portava all’uccisione del colpevole.
Tuttavia non solo il tradimento della patria, l’intelligenza con il nemico della patria o la rivolta contro l’autorità erano considerati reati gravissimi, ma anche lo spostare un cippo che delimitava il confine di un campo, il rubare il bestiame o il raccolto altrui, l’uccidere, lo stuprare, il violare una promessa, il dare falsa testimonianza, il rubare di notte, l’incendiare una casa o le messi, il rubare al padrone, l’ingannare un cliente.
I modi che ricorrevano per le pene, a quanto risulta dalle Leggi delle XII tavole (V sec. a.C.), erano veramente feroci. I Romani facevano ricorso alla decapitazione, alla fustigazione a morte, all’impiccagione, al taglio di arti, all’annegamento, al fuoco; le vestali colpevoli di infedeltà erano seppellite vive, perché non era permesso versare il loro sangue, il loro seduttore era bastonato fino alla morte; i nemici pubblici, i servi che avessero derubato il padrone, i colpevoli di falsa testimonianza venivano lanciati dalla rupe Tarpeia; agli schiavi, o comunque a coloro che non godevano della cittadinanza romana, era riservata la crocefissione, supplizio particolarmente lungo e doloroso.
Non mancano però esempi anche di altri metodi: il re Tullo Ostilio, per esempio, fece squartare Mettio Fufetio per aver violato i patti stipulati con Roma, legandolo a due carri poi lanciati in opposte direzioni.
Ma non si deve credere che con il passare del tempo i costumi romani si siano ammorbiditi; ancora nel 71 a.C. più di 6.000 uomini che avevano seguito Spartaco nella sua rivolta contro Roma furono crocefissi lungo le strade consolari e nei primi secoli dell’era volgare i cristiani, ritenuti colpevoli di sovvertire l’ordine pubblico, erano dati in pasto alle belve negli anfiteatri.
Il Medioevo in Europa è caratterizzato da una grande confusione e sovrapposizione di poteri, perché il sistema feudale era tale per cui al potere dello Stato, che si identificava con il re o l’imperatore, si affiancava il potere dei feudatari, a cui il re delegava il compito di amministrare la giustizia, e poi il potere dei magistrati cittadini. Erano molti quindi coloro che potevano comminare pene, anche quella capitale, che veniva applicata per crimini come omicidio, furto, sacrilegio e tradimento, a volte sulla base di leggi, spesso in modo arbitrario dal potente di turno. Venivano utilizzati la decapitazione, l’impiccagione, l’annegamento e la tortura fino alla morte.
Ci fu un lungo periodo della storia europea in cui torture ed esecuzioni capitali furono particolarmente frequenti e riservate a reati che noi oggi considereremmo di opinione. La commistione tra potere politico e potere religioso ha portato per secoli alla condanna di chi si discostava dalle posizioni della Chiesa, sia sul piano dogmatico che su quello politico e scientifico, senza contare le innumerevoli donne accusate di essersi date al demonio e bruciate come streghe.
Col passare dei secoli, la pena capitale rimase in vigore in quasi tutti i Paesi, e vennero introdotti sempre nuovi strumenti di morte. Per esempio nella Francia dell’Ancienne Regime essa era eseguita con raffinati supplizi differenziati a seconda del rango sociale del condannato o del tipo di reato commesso: l’impiccagione era riservata ai contadini, la decapitazione ai nobili, la ruota ai delitti più atroci, il rogo ai delitti contro la religione, lo squartamento ai delitti contro lo Stato. Con la Rivoluzione, su proposta di Guillotin, furono abolite le differenze di condanna con l’introduzione della ghigliottina.
La pena di morte comunque restò nella maggior parte degli ordinamenti giuridici fino alla fine del XVIII secolo, quando cominciarono ad essere numerosi e importanti gli sforzi per combatterla e favorirne l’abolizione.
La più famosa denuncia dell’ingiustizia della pena di morte si deve al giurista italiano Cesare Beccaria, che nell’opera Dei Delitti E Delle Pene (1764), sostenendone l’inefficacia come mezzo di prevenzione del crimine e sottolineando la possibilità dell’errore giudiziario, ne propose l’abolizione; l’opera di Beccaria ottenne grande attenzione anche fuori dall’Italia e influenzò in maniera decisiva i movimenti di riforma del diritto penale.
Per Beccaria, la pena di morte deve essere bandita per due motivi: in primo luogo, perché la sua efficacia deterrente è inferiore alla pena del carcere a vita (i cittadini saranno più impressionati dal «lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà» e «divenuto bestia di soma» che non dal «terribile ma passeggero spettacolo della morte»); e in secondo luogo, perché gli uomini sanno in cuor loro che la loro vita non deve essere «in potestà di alcuno» e non può essere consegnata, per decisione contrattuale, nelle mani del sovrano.
L’impressione provocata dall’opera di Beccaria è enorme: emerge una nuova visione del diritto penale e del processo penale, in continuità con la prospettiva già delineata, nel 1748, dall’Esprit des lois di Montesquieu. E non è soltanto la nascente ‘opinione pubblica’ a mostrarsi colpita dalle argomentazioni del Dei delitti e delle pene. Di lì a pochi anni, infatti, sembra realizzarsi l’auspicio di Beccaria, che si attendeva nuove leggi da quei «monarchi benefici, animatori delle pacifiche virtù» che «veggiamo riposti su i troni di Europa». Il monarca benefico atteso da Beccaria si materializza nella persona di Pietro Leopoldo, granduca di Toscana, che provvede ad una coraggiosa riforma del diritto penale: una riforma di cui il granduca traccia le linee principali, vincendo le perplessità dei suoi stessi consiglieri; una riforma che include, oltre al divieto della tortura nel processo, anche l’abolizione della pena di morte. E’ appunto la Leopoldina, pubblicata il 30 novembre del 1786.
Siamo di fronte a una vera e propria frattura storica, a un evento di grande valore simbolico, che sembra incarnare il mito settecentesco della felice collaborazione fra il filosofo illuminato e il sovrano riformatore.
Ma questa conquista” non era unanime. Guardando anche solo al dibattito italiano, se Beccaria aveva lanciato il sasso nello stagno, un altro grande riformatore, Gaetano Filangieri, per tanti aspetti vicino alle proposte dell’illuminista lombardo, non ne sottoscrive la condanna della pena di morte, sostenendo piuttosto che con il delitto il criminale, nello stato di natura come nella società civile, perde il suo diritto alla vita. Né si pensi che la tesi (anti-abolizionista) dell’illuminista napoletano fosse isolata: a favore della pena di morte si era pronunciato Rousseau, appena due anni prima della formulazione dell’eversiva tesi beccariana, e a favore della pena di morte, con diverse argomentazioni, si esprimerà, a fine Settecento, Kant.
Occorre però non dimenticare che la Leopoldina, pur mantenendo intatto il suo valore simbolico, avrebbe avuto una vita assai breve. Sarà lo stesso Pietro Leopoldo a far presto marcia indietro. Vi erano stati disordini in varie zone della Toscana e il granduca, poco tempo dopo aver lasciato la Toscana per Vienna, nel 1790, appena quattro anni dopo il varo della sua riforma, si dichiara costretto a reintrodurre la pena di morte contro coloro «i quali ardiranno di sollevare il popolo, o mettersi alla testa del medesimo per commettere eccessi e disordini». Ed è solo l’inizio di una ‘controriforma’ che reintrodurrà la pena di morte per la sedizione politica e per alcuni reati comuni: è quanto avviene con la riforma del 1795, promulgata dal successore di Pietro Leopoldo, Ferdinando III, e poi ancora con la legge del 1816 (la Legge contro i delitti di furti violenti).
E’ stata dunque inutile, improduttiva di conseguenze, la sfida di Beccaria? Certamente no. Per cogliere l’importanza decisiva dell’abolizionismo di alcuni riformatori settecenteschi suggerirei di ricorrere a questa formula: è a partire da quel momento storico, da quel testo, da quei testi, che la pena di morte, per la prima volta, cessa di essere una rassicurante certezza per divenire un problema. La pena capitale non può essere più presentata come una garanzia indiscutibile perché auto-evidente dell’ordine sociale, come un appannaggio costitutivo della sovranità, ma deve essere sempre di nuovo legittimata, deve guadagnarsi sul campo un ruolo di cui prima godeva senza sforzo.
La pena di morte resta in vigore nella legislazione degli Stati pre-unitari (e anche nello Stato pontificio, dove è ampiamente utilizzata). Nella stessa Toscana la pena di morte è ancora prevista dal pur innovativo codice penale del 1853. Dopo la cacciata del Granduca, tuttavia, il governo provvisorio abolisce nel 1859 la pena capitale, lasciando in eredità al nascente Stato italiano un problema complicato. Si intendeva infatti estendere a tutta la nazione il codice penale sardo-piemontese, che però includeva la pena di morte. Si davano allora due soluzioni: estendere quel codice anche alla Toscana, reintroducendo in essa la pena da morte da poco abolita; oppure al contrario cancellare da tutto il territorio nazionale la pena di morte, riformando su questo punto il codice sardo-piemontese.
E’ intorno a questa secca alternativa che divampa un dibattito che vede mobilitati personaggi di grande spessore intellettuale e morale: si pensi soltanto ai nomi di Francesco Carrara e di Pietro Ellero, e a iniziative di respiro europeo come il «Giornale per l’abolizione della pena di morte». La vicenda si chiude senza vinti e senza vincitori ed è proprio il mancato accordo sull’abolizione della pena di morte che impedisce l’unificazione del paese sul terreno della legislazione penale. A un codice penale unitario si giunge soltanto nel 1890, quando entra in vigore il codice Zanardelli; ed è questo codice che sancisce il bando della pena morte dal sistema delle sanzioni penali. Non siamo però di fronte a un bando definitivo. Con l’avvento del regime fascista e con le leggi del ’26 ‘per la difesa dello Stato’ (e poi con il codice Rocco) la pena di morte viene reintrodotta ed effettivamente applicata (il ‘Tribunale speciale per la difesa dello Stato’ commina, fra il ’26 e il ’43, 42 condanne a morte). Nemmeno la caduta del fascismo, comunque, basta a indurre un’immediata abrogazione della pena di morte. Per arrivare a una solenne sconfessione della pena capitale occorre attendere la costituzione del ’48, che all’art. 27 dispone che «non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra»
Durante questo secolo essa ha continuato ad essere utilizzata da alcuni governi dittatoriali per sbarazzarsi di chi li contrastava, per motivi di ideologia o di colore della pelle, come in Sudafrica durante l’apartheid, in Russia ai tempi di Lenin e Stalin, in Europa ai tempi del nazismo.
-
torna all’indice del Percorso sulla pena di morte prof.ssa Giovanna Megna