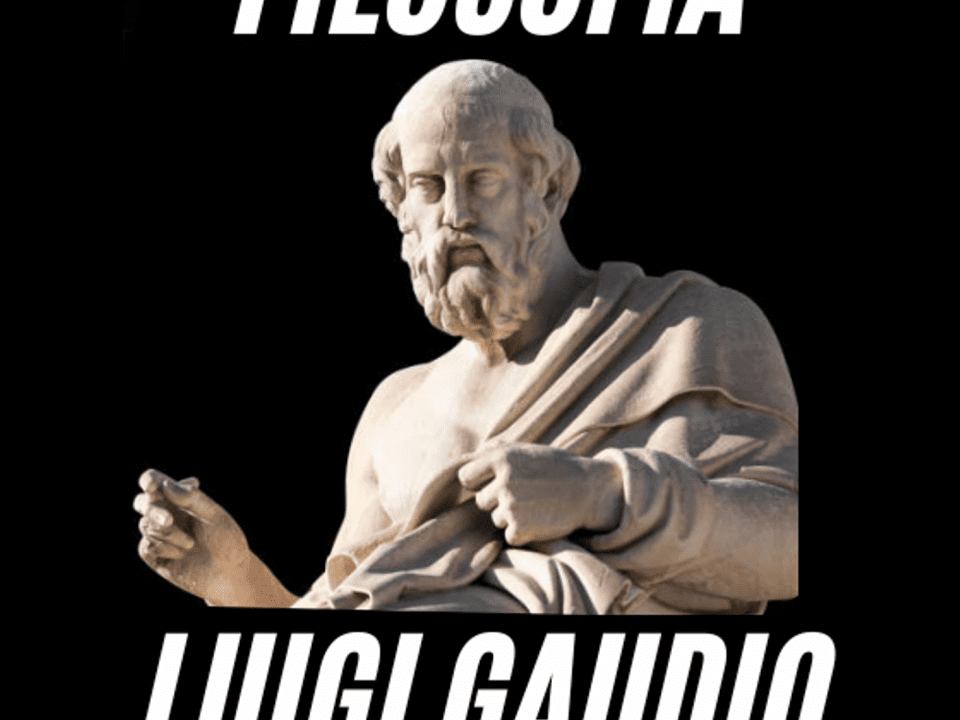Van Gogh
27 Gennaio 2019

Cause del doping
27 Gennaio 2019Il dramma pirandelliano ha come protagonisti uomini che un bel giorno, di colpo, si trovano come dinanzi uno specchio, in cui contemplano l’immagine della propria vita: dal vivere puro e semplice passano al vedersi vivere e prendono coscienza della propria esistenza.
Enrico IV è la recita di una recita. Finzione di una finzione, forse per questo appare così autentica. Enrico, il personaggio della tragedia, mette in scena sul palco il perpetuarsi di una situazione storica imbarazzante: l’umiliazione del ventiseienne imperatore di Baviera, costretto a un’estenuante attesa, nell’inverno del 1077, fuori dalle mura di Canossa, mentre Matilde di Toscana, nel ruolo inevitabilmente ambiguo del negoziatore, si adopera presso il Papa Gregorio VII, per ricucire lo strappo fra Chiesa e Impero. Questo dramma, che nella realtà storica si consumò in due giorni, nella tragedia pirandelliana dura vent’anni. Potenza della nevrosi.
«Circa vent’anni addietro, alcuni giovani signori e signore dell’aristocrazia pensarono di fare per loro diletto, in tempo di carnevale, una cavalcata in costume” in una villa patrizia: ciascuno di quei signori sera scelto un personaggio storico, re o principe, da figurare con la sua dama accanto, regina o principessa, sul cavallo bardato secondo i costumi dell’epoca. Uno di questi signori sera scelto il personaggio di Enrico IV; e per rappresentarlo il meglio possibile, s’era dato la pena e il tormento d’uno studio intensissimo, minuzioso e preciso, che lo aveva per circa un mese ossessionato». Con queste parole Luigi Pirandello, in una lettera del 1921, presentava l’antefatto della nuova tragedia che stava scrivendo al grande Ruggero Ruggeri, l’interprete che desiderava, e che ottenne, nel ruolo principale.
Nel corso della cavalcata Enrico, che monta accanto alla bella ma frivola Matilde, di cui è innamorato, cade da cavallo, rimanendo intrappolato nel personaggio che sta impersonando. Rinchiuso in un esilio dorato dalla sorella, insieme a quattro servitori che si prestano al giuoco nel ruolo di consiglieri segreti, l’uomo porta avanti la bizzarra rappresentazione che, con il tempo, assume i tratti di una normale quotidianità. Passano vent’anni e la sorella di Enrico, che non si è mai capacitata della pazzia del fratello, sul letto di morte richiede che gli amici rappresentino ancora una volta la scena, per mettere il malato, con uno stratagemma, di fronte al tempo trascorso e strapparlo infine alla follia. Questo è il piano che i cinque personaggi hanno in mente quando si portano alla villa dove è rinchiuso Enrico: Matilde, ormai donna matura; sua figlia Frida, immagine vivente della Matilde di un tempo, Carlo Di Nolli, figlio della sorella di Enrico e fidanzato di Frida; Tito Belcredi, allora rivale di Enrico e oggi amante di Matilde e il medico «alienista» che ha ordito il piano.
Nel primo atto, al cospetto di Enrico, Matilde, Belcredi e il medico, travestiti in abiti storici, subiscono la conversazione di Enrico che, pur discorrendo di vicende riguardanti un ambito di 850 anni addietro, li confonde con l’attualità ambigua delle sue affermazioni.
Una parte del secondo atto è passata così dal gruppo a interpretare e cercare contraddizioni e conferme nelle tranquille parole del malato. Ma il fuoco cova sotto la cenere. Congedati temporaneamente i suoi ospiti, il furore di Enrico esplode: «Buffoni! Buffoni! Buffoni!». Il principe svela ai servitori allibiti la verità. «Non capisci? non vedi come li paro, come li concio, come me li faccio comparire davanti? Buffoni spaventati». E con la verità, affiora la sua stramba filosofia: «Dovevate sapervelo fare da voi l’inganno; non per rappresentarlo davanti a me, davanti a chi viene qua in visita di tanto in tanto; ma così, per come siete naturalmente, tutti i giorni, davanti a nessuno, […] Per quanto orrendi i miei casi, e orrendi i fatti; aspre le lotte, dolorose le vicende: già storia, non cangiano più, non possono più cangiare, capite? Fissati per sempre: […] il piacere, il piacere della storia, insomma, che è così grande!».
Nel terzo atto, la resa dei conti.
La grandezza di Pirandello è anche quella di aver messo in scena l’alienazione in un tempo in cui la psicanalisi è ancora scienza in fasce.
Enrico è un alienato, messo al margine della società dei suoi simili, di cui subisce la diversità. La sua colpa è quella di affrontare la vita con troppa serietà e pretendere di essere preso sul serio da chi serio non vuole essere, come testimoniano le parole di Matilde, che nel primo atto afferma: «Risi di lui. Con rimorso, anzi con vero dispetto contro me stessa, poi perché vidi che il mio riso si confondeva con quello degli altri – sciocchi – che si facevano beffe di lui».
L’errore è quello di considerare la «società» come un giuoco cooperativo volto a edificare e a sviluppare opere e civiltà; mentre essa è più spesso un giuoco antagonista, in cui i mediocri, che sono i più, alleano le loro insufficienti forze per ostacolare chi è specchio della loro mediocrità. «Conviene a tutti far credere pazzi certuni, per avere la scusa di tenerli chiusi. Sai perché? Perché non si resiste a sentirli parlare».
La tragedia pirandelliana è stata presa a simbolo della campagna che ha portato, in Italia, alla controversa legge detta «Basaglia», dallo psichiatra che la patrocinò: alla chiusura dei manicomi e alla reintegrazione forzata dei malati psichici nella società.
Il personaggio di Enrico è stato visto per lo più come un personaggio positivo, che sceglie di autoemarginarsi, piuttosto che integrarsi in una società conformista; ma non mancano i critici che vedono in Enrico «la dimensione di rinuncia, di autorepressione, di rifiuto della vita e del sesso, in una parola di pulsione di morte». Il curatore dell’edizione Mondadori del 1993, Roberto Alonge, sembra pensarla così, quando cita: «Enrico è impazzito” non per aver perduto la donna, ma per non dover affrontare il rischio di conquistarla e di averla» (Gioanola).
L’amore di Enrico per Matilde è strumentale. Egli vede il matrimonio come il passaporto, se non per la normalità, almeno per la conformità. Matilde però esita, non perché non lo ricambi o non lo stimi, ma perché non è disposta ad affrontare il rischio di avvallare le «qualità» di lui contro tutti gli altri, che lo chiamavano pazzo anche prima che lo fosse, contro Belcredi, che punse il suo cavallo per farlo imbizzarrire e che nel finale catartico viene punto a sua volta, trafitto (il grido finale di Matilde non lascia adito a dubbi) senza speranza, lui «spadaccino temutissimo» dalla spada acuta e vendicativa della follia, nella quale Enrico si rifugia definitivamente.
- torna all’indice della tesina Il Viaggio metafora della vita tesina esame di stato 2009, di Libera Maria De Padova, Dirigente di comunità