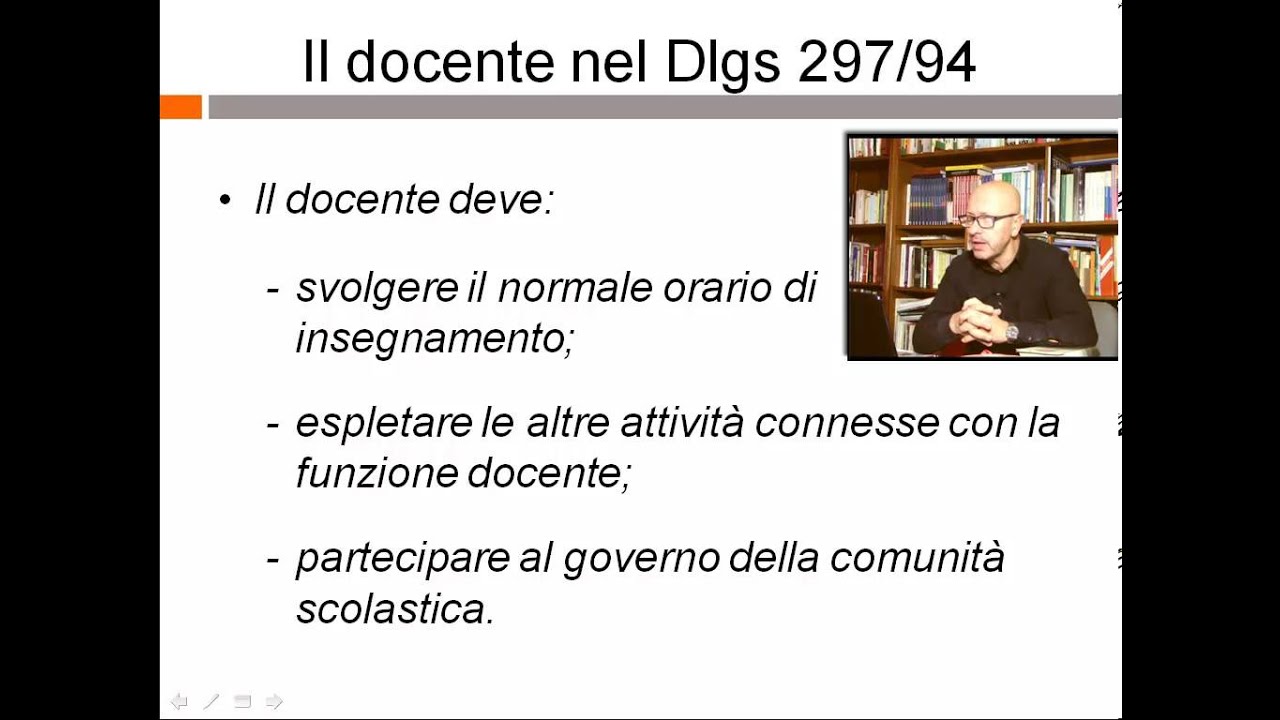Tracce di temi per la Tipologia D: tema di attualità
27 Gennaio 2019
Sara Renda
27 Gennaio 2019L’Epigrafe di Costantino ad Abbiategrasso è un’ iscrizione particolarmente significativa della nostra zona

L’epigrafe riportata su questo cippo costituisce uno spunto didattico particolarmente significativo per i liceali del nostro territorio (Abbiatense-Magentino, prov. di Milano), perché è stata rinvenuta nella nostra zona negli anni Quaranta e si trova tuttora presso l’ingresso del Castello di Abbiategrasso (sede della biblioteca civica), presenza tangibile della civiltà romana, oggetto parlante” una lingua antica che incuriosisce e invita alla lettura per la chiarezza delle lettere in scrittura capitale.
Leggiamo, dunque, e trascriviamo il TESTO, avendo cura di considerare l’impiego, tipico delle iscrizioni, di formule abbreviate (IMP=Imperator; PP=Pater Patriae, ecc.) e, a volte, come nel nostro caso, la necessità di integrare lacune (per abrasione o mutilazione del supporto) ricorrendo all’ausilio del confronto con altre epigrafi:
Trascrizione
(Domino) N(ostro) IMP(eratori) CAES(ari)
(Co)NSTANTINO
MAX(imo) P(io) F(elici) VICTORI
AUG(usto) PONTIF(ici) MAX(imo)
TRIB(unicia) POT(estate) XXIII IMP(eratori)
XXII CONS(uli) VII
P(atri) P(atriae) PROCONS(uli) HV(manarum rerum)
(Optimo Principi)
(Divi Constanti Fil’io)
(Bono Rei Publicae nato)
Traduzione
Al Signore Nostro Imperatore Cesare Costantino
Massimo, Pio, Felice, Vincitore
Augusto, Pontefice Massimo
Per 23 volte investito del potere tribunizio
Imperatore per 23 anni
Console per 7 volte
Padre della patria Proconsole
Delle questioni umane Ottimo Capo
Figlio del divino Costante
Nato per il bene dello Stato
Si tratta di un’epigrafe onoraria per l’imperatore Costantino il Grande, incisa su una colonna miliaria (altezza m. 1,50; diametro m. 0,80) mutila nella parte inferiore, rinvenuta nel 1944 nel cortile di una casa rustica di proprietà Casazza di Abbiategrasso e con ogni probabilità appartenente alla strada romana che da Porta Vercellina arrivava alla Gallia transalpina.
Le colonne miliarie venivano poste ai bordi delle strade consolari ad ogni miglio (1500 m.) del percorso e riportavano iscrizioni laudative analoghe a questa, per celebrare il magistrato (l’imperatore in questo caso) che avesse fatto tracciare o riattivare la strada.
L’iscrizione, databile all’anno 326, in base all’indicazione degli anni delle cariche dell’imperatore Costantino, offre lo spunto per una riflessione sulla natura costituzionale dell’impero romano. Benché risalga ormai al quarto secolo dalla sua fondazione ad opera di Giulio Cesare Ottaviano Augusto, la celebrazione dell’imperatore avviene attraverso l’elenco delle cariche da lui rivestite: Pontefice Massimo, Tribuno della Plebe, Console, ecc. Da sempre gli storici si interrogano sulla definizione giuridica della costituzione augustea, approdando a diverse interpretazioni (città-stato, monarchia assoluta, diarchia) che, tuttavia, ruotano attorno allo stesso fatto, ossia che Ottaviano non eliminò le tradizionali magistrature repubblicane, riconoscendo l’indiscutibile pretesa dell’uomo romano di essere non suddito, ma cittadino. Certo le vecchie magistrature repubblicane acquisirono un significato diverso e, soprattutto, finirono accentrate in un’unica persona, Ottaviano che, forse proprio grazie a questa intuizione, trovò la soluzione vincente. Dopo la vittoria di Azio (31 a. C.), Ottaviano non si impose come un arrogante tiranno, ma si fece eleggere console con un collega dotato di poteri minori, minor (27 a. C.). Si fece attribuire dal Senato il titolo di Augustus (degno di venerazione”) e la carica di princeps senatus (da cui il termine principato”), grazie alla quale aveva il diritto di votare per primo, quindi di influenzare il voto degli altri senatori. Nel 23 a. C. si fece conferire i due poteri che gli avrebbero garantito la chiave delle decisioni politiche sia a Roma che nelle province: il tribunato della plebe (tribunicia potestas, che comportava il diritto di veto contro le deliberazioni del senato o le iniziative degli altri magistrati) e il proconsolato (imperium proconsulare maius et infinitum, che gli garantiva il controllo delle province).
Il cognomen di Augustus riveste particolare significato, perché, riconducendosi al verbo augere, accrescere”, aumentare”, trasmette l’immagine di chi lo porta come di colui che accresce” il dominio di Roma e la sua prosperità. Si tratta di un termine che si collega anche alla sfera sacrale: augure” è il sacerdote che offre presagi per favorire un’impresa, augurio” è il presagio favorevole. Non a caso Ottaviano assume anche la suprema carica religiosa, quella di pontifex maximus . Inoltre la divinizzazione di Cesare, da cui è stato adottato, lo rende Divi filius.
Titoli e cariche ricorrono nella nostra iscrizione, insieme ad altre espressioni laudative degne di nota, come pius e felix, che rimandano a significati più profondi di quelli assunti poi nella nostra lingua. Pius non significa semplicemente pio”, ma allude all’atteggiamento di devozione e rispetto per le tradizioni divine e umane compendiate nel termine pietas. La pietas verso i genitori e verso gli dei costituisce una qualità fondamentale dell’uomo romano (pius è epiteto di Enea). Felix non significa semplicemente felice” (che in latino è espresso piuttosto col termine beatus), ma indica il favore di cui si gode da parte degli dei. Felix è la persona amata dagli dei e, come tale, le sue imprese sono destinate al successo. Anche le ultime parole dell’iscrizione, Bono Rei Publicae Natus, apparentemente convenzionali (cos’altro si potrebbe dire di chiunque occupi una carica pubblica e, a maggior ragione, di un imperatore?), sono tuttavia retaggio della tradizionale mentalità romana, che individua la virtus, ossia la qualità per eccellenza del vir, dell’uomo, nel valore di costui, cittadino (civis) e soldato (miles) per la Res Publica, lo Stato.
Raffaella Ballerio