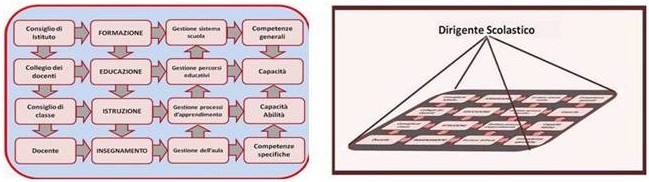Giovanni Ghiselli: professore di greco e latino
27 Gennaio 2019
Giusy
27 Gennaio 2019settimo capitolo
di Giovanni Ghiselli
VII capitolo. La mamma di Yväskyla e la mamma di Borgo Sansepolcro. Io non sono materia”.
Ecco la mamma”, pensai. E mi venne in mente la mamma mia, di occhi azzurri e di capelli nerissimi, quando durante il pranzo mi guardava fissamente, con aria ostile, poiché non le davo retta e non si sentiva amata abbastanza, o mal giudicata da me, o posposta alle sorelle sue. Io lamavo come non ho più amato nessun’altra donna in vita mia ma non riuscivo a farglielo capire, e lei si sentiva ingiustamente sottovalutata in favore delle zie, la Rina e la Giulia, dalle quali mi rifugiavo poiché, a mia volta mi sentivo non capito e non apprezzato da lei. Quando la Giulia che come la Rina non aveva figli, mi portava a Moena, in agosto, sentivo tanto la mancanza della mamma, il desiderio di una sua cartolina, che tutte le mattine aspettavo il postino, o addirittura gli correvo incontro, sperando di leggere parole di lei. Anche solo Saluti e baci. Mamma”. Ma queste quasi mai arrivavano, e io aspettavo il giorno seguente, agognavo il ritorno a Pesaro per provare di nuovo a piacerle, a conquistarne l’affetto, la stima, l’ammirazione..
Elena era una mamma, bella e bruna anche lei, e quella sera del 4 agosto 1971 avrei potuto farle pagare le frustrazioni subite dalla mamma mia quando era indifferente o furente perché non le obbedivo e non si sentiva amata da me. Elena però non era furente né indifferente, anzi aveva lo sguardo buono e infelice.
Anche la madre mia quando il dispetto le era passato, talvolta diventava affettuosa, allora mi accarezzava i capelli e diceva: Pipo, sei bellino, sei buono, a scuola sei il più brvo di tutti: io sono fiera di te. Ho sempre desiderato un figlio così; tu mi ripaghi di una vita tribolata. Hai occhi grandi e belli anche se non hai preso il mio colore di smeraldo, e si vede che sei intelligente. Una volta, quando eri piccino piccino, avevi forse tre anni, ti portai da un calzolaio troppo caro. Io volevo uno sconto e tu, che avevi capito tutto, per sostenermi, dicesti brutte ca”, brutte scarpe.
Eri e sei un bambino geniale. Mi aspetto molto da te. Vedrai che uomo diventi, vedrai quanto ti ameranno le donne! Quando mi fai arrabbiare, ti do qualche schiaffo, ma ti voglio bene lo stesso!”
Allora sentivo che quella donna mi capiva, mi apprezzava e mi amava. E fuggivo nel bagno per piangere, ma di consolazione e di gioia, poiché la madre mia contraccambiava il mio amore .
La mamma era l’unica donna che mi piaceva del tutto e mi emozionava, perché era bruna, di capelli nerissimi e occhi colore smeraldo, oppure, secondo la luce, men chiara o più chiara, azzurri, ed era sempre abbronzata, ben fatta, snella e formosa, elegante, e ancora di più la ammiravo poiché era capace di pensieri originali, di azioni sue, magari non tutte buone, però sue, non imitate da altri, e di giudizi acuti su un personaggio, un libro, un film.
Le zie erano state fascistizzate e pretificate; il nonno beveva e rimpiangeva le sue ex amanti; la sorella era ancora uninfante; la nonna gelosa faceva la guerra alla serva di casa, una poveretta scema, brutta e mezza vecchia, ma -ghiotta per quel porcaccione del tuo nonnaccio”- diceva. E per stornare le corna, d’inverno sputava nel fuoco del caminetto. Mia madre invece aveva un’anima: non sempre diritta e lucida invero, ma ce l’aveva. E io per questo lamavo, lamavo come non ho amato mai più, né mai più probabilmente amerò una femmina umana mortale, e la prendevo sul serio, e volevo correggere le sue distorsioni con un impegno che non avrei messo nemmeno con le mie figlie spirituali: mia sorella Margherita, Luciana, Nicoletta e le altre. Sbagliavo a volerla cambiare e soffrivo quelli che, con piccola e misera mente dogmatica, consideravo i suoi errori. Non erano errori. Era la sua natura, una natura non fiacca, quella che mi ha trasmesso oltretutto, e io gliene sarò grato per sempre.
Quando capivo che anche lei mi amava, piangevo di gioia; poi mi osservavo a lungo nello specchio, e notavo quanto le somigliavo nel volto bruno bruno, nell’espressione degli occhi tagliati a mandorla, seppure, ahimé, di colore diverso, nel naso pronunciato in modo nobile e bello. Antichi eravamo entrambi. Antichi etruschi di Sansepolcro eravamo. E nel mio volto vedevo la stessa sua irrequietezza, la stessa follia geniale, ispirata, che volevo rivolgere al bene, a creare qualcosa di buono, di bello, di grande. Ci sono manie divine, più sagge della saggezza del mondo.
Questo avveniva negli anni Cinquanta, verso la metà degli anni Cinquanta, quando avevo una decina di anni.
Il 4 agosto del 71, vicino ai ventisette, potevo evitare di opprimere una donna che mi aveva aiutato, risparmiandole uningiustizia dolorosa e umiliante. Avevo incontrato una persona che si era fidata di me, riconoscendo l’uomo tendenzialmente buono e intelligente che volevo diventare, che forse, ora a quasi 68 anni, mi avvicino a essere. Non dovevo tradire la sua fiducia. Elena però doveva aiutarmi poiché il mio animo, come la testa materna, era ambivalente, intermittente, incline alla seduzione attiva e passiva, allo thumós anche distruttivo, seppure non tanto quanto quello della madre furente immortalata da Euripide.
Lottobre scorso la mamma mia è morta, pochi giorni dopo avere compiuto novantotto anni. Eravamo del tutto pacificati e armonizzati da tanto tempo oramai. Ci eravamo riconosciuti del tutto. Ci fidavamo completamente l’uno dell’altro. Ci amavamo molto alla fine. Ne eravamo felici entrambi. La notte del giorno della sua morta pedalando sulla pista ciclabile tra Pesaro e Fano, lho sentita vivere nelle stelle, nellinnumerevole sorriso delle increspature del mare che rifletteva la luna, una l’una crescente piena di luce. Ho sentito la mamma viva nell’armonia della vita dell’Universo. E ho pianto di dolore ma anche di gioia, come quando ero un bambino davanti allo specchio. La mamma non era morta: era viva nel cosmo e viva dentro di me. Sono certo che rimarrà viva, e bella, e buona per sempre. La terra è in mezzo alle stelle e tu, mamma, sei dappertutto, nel sole che ci abbronza e ci rende più belli, nel vento che ci accarezza, nelle farfalle che volano sui fiori che ti piacevano tanto, negli uccelli del cielo, nei piccioni e nei passeri cui davi da mangiare. Ti ritrovo dovunque, sempre pronta a darmi il coraggio e la forza di diventare quello che sono, di fare le cose buone e belle che devo a me stesso e devo a te che mi hai dato la vita.
Ancora mi guardo allo specchio, e vedo il suo volto geniale, irrequieto, e gli dico: Tu sei la mia mamma, tu sei la mia mamma, e lo bacio”
Ma torniamo a Debrecen, alla sera del 4 agosto 1971. Mi scusai con la ragazzetta francese e andai dalla Sarjantola che aveva osservato e, probabilmente, compreso.
Ciao, come vanno la salute e l’umore?”, le domandai non senza imbarazzo.
Non bene”, rispose con serietà. Ti voglio parlare, ma non qui tra la gente e il chiasso. Andiamo a fare due passi”. Aveva visto e capito che ero stato lusingato e attirato dalle moine e dai vezzi di quella adolescente graziosa, spregevolmente, dopo tutti i giuramenti d’amore e di stima impiegati per convincere lei, la donna di un altro, di un uomo lontano, a venire a letto con me.
Le proposi di andare in collegio, in camera mia, dove si poteva parlare stando seduti e guardandoci in faccia. Sentivo anche io il bisogno di una spiegazione chiara e completa. Il collegio era deserto, la camera vuota. Ci sedemmo sul letto ordinato e casto di Fulvio.
Senti Gianni”, cominciò andando direttamente al centro della questione, se la mia presenza ti pesa, io posso tornare in Finlandia direttamente, domani”. Aveva gli occhi gonfi, rossi, cerchiati, e l’aria infelice. Ancora una volta, con la sua capacità di arrivare subito al nocciolo, con la sua calma, pur nel dolore, mi dava una lezione di intelligenza e di stile. La guardavo, pensando quanto era diversa dalla gente rozza assai, e affettata, che frequentavo di solito; quanto mi rendeva migliore. Riflettevo, esitavo a rispondere. Allora Elena si mise a piangere sommessamente. Finalmente parlai. Dissi: Elena, non piangere, ti prego, mi dispiace, non piangere. Fammi capire che cosa ti rende infelice. Io voglio aiutarti”. Si asciugò gli occhi, poi mi guardò con fermezza e disse: Mi dispiace di essermi lasciata andare ad amarti troppo presto. Ti ho creduto quando dicevi di amarmi, e mi sono sbagliata”.
Dai, che non è vero”, la confutai, ma senza la convinzione e la forza necessarie a lenirne la pena.
Allora disse: Non essere falso almeno. Ho visto quanto ti attirava la ragazzetta francese e quanto avresti voluto essere libero per lasciarti andare con lei. Ebbene, puoi farlo, o puoi continuare a farlo. Non preoccuparti per me: considerati libero, come se non mi avessi mai conosciuta; io adesso torno in camera mia e domani sparisco dalla tua vita”.
Si alzò dal letto e si diresse verso la porta. Allora capii. Capii di essere stato stupido, volgare e crudele; capii che quella creatura in attesa di un’altra creatura, non doveva subire ingiustizia, umiliazioni e dolori. Non da me. Ne avrei avuto rimorso per tutta la vita, forse anche oltre. E non solo per questo: io lamavo, lei mi aveva reso migliore, e siccome in sua presenza mi vergognavo di essere ingiusto, mi avrebbe reso ancora migliore. La terra è in mezzo alle stelle, e sulla terra ci sei tu amore mio. Mi alzai, le afferrai la mano sinistra e dissi: Scusa, Elena, aspetta. Ora devo parlare io a te. Ne ho bisogno. Ti prego”. Si fermò, mi guardò, poi sedette di nuovo. Questa volta sul mio, sul nostro letto, sul letto del nostro amore. Sospirai profondamente, le accarezzai i capelli nerissimi, folti, lucenti e la guardai con simpatia autentica. Elena era come me quando venivo vessato dai prepotenti: chiedeva giustizia a uno che aveva provato l iniquo impulso del tradimento e dell’oppressione.
Scusami, amore, hai ragione”, dissi. Prima stupidamente ho bevuto due o tre palinke e ho perso la testa. Poi ho ballato e ho sorriso sfacciatamente con quella francese. E vero, le ho fatto la corte, ma niente di più. L’ho abbracciata, come si fa quando si balla, le ho fatto qualche complimento, ma non lho baciata. Comunque mi dispiace, ora me ne vergogno. Io voglio te, ne sono sicuro, voglio stare con te, soltanto con te, finché tu mi vorrai. Voglio rispettarti come rispetto me stesso, perché tu sei la mia compagna e ancora di più perché ti amo. Tu devi essere sempre felice”.
Mi osservava, prima con sguardo dubbioso, poi capì e sentì che parlavo sul serio, con la testa e con il cuore, con tutto me stesso insomma. Infine mi sorrise convinta e mi accarezzò. Allora io, spingendole in basso una spalla, la stesi sul letto, quindi cominciai ad accarezzarle una coscia, sotto la gonna, con l’intento evidente di fare l’amore subito. Ma lei scostò la mano inopportuna e tutta la mia persona petulante, si rimise seduta, e disse: Aspetta”.
Perché aspetta ?” le domandai, fingendo di non capire o senza capire davvero. Non mi ricordo.
Perché voglio parlare ancora. Io non sono”. Disse in inglese una parola che non compresi. Le chiesi di ripeterla. In latin is materia” spiegò. Io non sono materia.
L’arrivo a Debrecen nel luglio del 1966.
Voglio ricordarti, lettore, quell’approdo a Debrecen dove giunsi da un mare tempestoso per farti vedere quanto possano una grande e buona volontà e un poco di buona fortuna nel cambiare in meglio la vita di un essere umano, di un ventenne già quasi caduto nella disperazione. Era una sera del luglio del 66, come ho già detto: avevo precisamente 21 anni e otto mesi quando, al tramonto del sole, arrivai nell’ignota cittadina dopo un viaggio inquieto con un veicolo vetusto e scassato, una Fiat 600 che, attraversando la puszta, aveva schiacciato migliaia di insetti brulicanti nell’aria della grande pianura.
Negli ultimi venti chilometri, precisamente da Hajdúszoboszló, avevo forzato la vecchia automobile per arrivare nella remota Università estiva prima che il sole, prossimo già al tramonto, sparisse, lasciandomi nel buio dell’immensa distesa, coltivata ma priva di alberi, popolata ma da poche persone distribuite in case isolate, in piccoli e radi borghi pressoché primitivi, dove oltretutto parlavano una lingua veramente straniera, uno strano idioma di cui, attraversando la terra magiara tutto quel giorno, mi ero accorto di non capire una sola parola. L’esame di lingua e letteratura ungherese dato a Bologna mi aveva fruttato un trenta e la borsa di studio ma non era bastato a mettermi in grado di dialogare nella lingua di quel paese. Qualche giorno più tardi, con lautomobile in panne, fui aiutato da un prete venuto in mio soccorso linguistico chiedendomi loqueris latina lingua?”
Loquor” risposi, così potei avere indicazioni utili.
Correndo dunque e facendo una strage di moscerini che avevano insanguinato il parabrezza della Seicento, ero riuscito a precedere il buio di pochi minuti. Quando arrivai alla periferia della città, il sole si era già immerso nella selvatica landa alle mie spalle, mentre dall’altra parte, la zona boscosa della Transilvania e dei selvosi Carpazi, vedevo arrivare le tenebre di una notte inquietante, popolata di spettri che mi mettevano in cuore strane emozioni: miste di presentimenti non tutti cattivi e di vaghe speranze. Ero molto giovane allora: quanto a esperienza di uomini, per non dire di donne, di rapporti umani comunque, ero quasi un bambino. Ero partito da Pesaro la mattina del 14 luglio, da solo. Avevo costeggiato il mare Adriatico e attraversato la pianura padana; poi erano apparse delle montagne: brutte però, tarlate, quasi informi; insomma molto diverse dai monti noti e amici, le dolomiti antropomorfe della valle di Fassa con le quali parlavo nei mesi di agosto degli anni Cinquanta. Mentre avanzavo tra catene montuose che stringevano l’orizzonte da tutte le parti, il cielo residuo prima si incoronava, poi si ingombrava di nuvole sempre più grosse, più spesse, più acquose, finché arrivarono a togliermi il conforto della luce del sole. Quindi cominciò a piovere sulle piante rade e scure di quelle montagne brulle, simili a cani rognosi, dal pelo tarlato. Non sembrava nemmeno più estate. Novembre sembrava. Ero tentato di tornare a Pesaro dove almeno la spiaggia coperta di ombrelloni e capanni mi assicurava che la stagione meno dolente[2] non era finita. Ma a Debrecen avevo un appuntamento con il destino. Un destino buono col senno del poi.
Allora, solo speranze incerte e tante paure.
Arrivai sul Tarvisio che Zeus pioveva, tuonava e fulminava[3].
Avevo dato gli esami di greco, tutta lOdissea e sette tragedie di Euripide. Ne avevo la testa infarcita.
Attirato da quei segni divini, decisi di proseguire. Prima però scesi dallautomobile e andai a cambiare denaro per mangiare e dormire in Austria: a Graz, se ci fossi arrivato a un’ora possibile, poiché cerano altri duecento chilometri ignoti da percorrere, probabilmente sotto la pioggia. Avevo un forte male di gola e molti timori imprecisati. Volevo capirli, determinarli, domarli.
Per questo dovevo procedere. Fata viam invenient [4], pensai. Avevo dato anche latino con tutta lEneide. La via era quella che portava alla mia identità, al diventare quello che sono[5].
Quando fui rientrato nellautomobile, vidi un lampo che illuminava l’Oriente, la parte di Graz e dell’Ungheria, poi sentìi tre volte il suono di un tuono strano: aveva qualche cosa di musicale. Aderitque vocatus deus [6], completai . Traevo auspici Sperare che la mia vita sarebbe cambiata in meglio non era difficile: in peggio non poteva cambiare. Guardai le creste dei monti che apparvero cosmetizzati, imbelliti dalla pioggia, e mi sembrò di vedere, mentre saltava di vetta in vetta[7], una donna o una dea luminosa, vestita di bianco: doveva preannunciare la creatura bella e fine che un giorno avrei incontrato e mi avrebbe amato se non mi fossi perduto d’animo e avessi ricominciato a progredire, cercandola. Allora era una figura eterea, una promessa quasi ultraterrena, ora che mi avvicino ai Settanta, iam senior, sed cruda viridisque senectus ” [8], posso chiamarla per nome, anzi grazie al mio Dio generoso con molti nomi, pollw`n ojnomavtwn morfh; miva[9], e ringraziare Zeus, o Apollo, o Priapo, o pure Gesù il Cristo, di avere mantenuto quella grande promessa lontana: di avermi fatto incontrare quella creatura celeste, incarnata in Helena Sarjantola, in Kaisa Häkkinen, in Päivi Janhunen, le finlandesi di Debrecen, e nelle italiane incontrate qua e là, in Luciana, in Nicoletta, in Olga, in Magda e in diverse altre. Non poche. Sempre grazie a Dio, chiunque egli sia[10].
Un poco confortato dunque, scesi dal passo Tarvisio tra i villaggi lindi dell’Austria: Villach e altri, in direzione di Klagenfurt. Cera qualcosa di simpatico, pulito, ordinato in quei paesini, mentre le nuvole sembravano diradarsi.
Invece, quando ebbi traversato Klagenfurt e ripresi a salire tra i monti, il cielo si annerò tutto di nuovo, poi ricominciò a piovere, infine la luce scomparve in un vapore esalato dagli stessi monti bagnati. Un dio mi inceppava il cammino. Avevo paura. Paura di non arrivare alla meta. Tra quelle montagne ignote non si vedeva più niente, tranne una decina di metri davanti allautomobile che procedeva con i fari abbaglianti accesi. Ma sì, potevo anche morire. Tanto della mia vita-pensavo- non importa niente a nessuno”.
Però poi reagivo a tanta cupezza. Sentivo che era eccessiva e pure un poco affettata. Quindi cambiavo registro
Dai-mi dicevo-, dai Gianni, devi farcela. Devi arrivare a Debrecen presto e trovare l’amore. Questo viaggio è il simbolo, la metà della tessera, della tua stessa esistenza: sei solo, sei coperto di nebbia, sei infelice e gravido di lacrime, ma ce la farai, poiché non sei stupido, né falso, né ostile alla vita. Ricordati come eri bravo e primeggiavi al liceo Mamiani di Pesaro. Allora non hai trovato l’amore perché impiegavi tutte le tue forze a essere il primo nellagonismo scolastico e ciclistico. In salita a dieci anni battevi i ventenni. In seconda liceo hai vinto un viaggio premio assegnato ai trenta studenti migliori d’Italia.
A Bologna finora hai dovuto cercare di adattarti a un mondo esterno sconosciuto e imprevedibile finché stavi in quel mortorio di Pesaro e in quell’ambiente domestico pieno di pregiudizi e risentimenti. Presto però ti rifarai! Soffrire in questi ultimi anni è stato destino, ma vedrai che splendore avrà la vittoria!”
Sceso dai monti, a un tratto, sulla sinistra, vidi una luce.
Per un momento credetti e sperai che fosse il sole sbucato di nuovo dalle nuvole occidentali. Invece era un lampione giallognolo, acceso contro il buio precoce. Saranno state sì e no le sette: in quel tempo lora legale in Austria non cera. Certamente dal sole, che ho sempre adorato come l’immagine visibile della mente divina e del Bene, avrei tratto maggiore conforto. Ma era pur sempre una luce.
Avanti-mi dissi-avanti, ché ce la puoi fare”.
Verso le otto arrivai a Graz sotto un’acquazzone violento e il cielo già buio del tutto.
Le lampade elettriche illuminavano lasfalto bagnato della circonvall’azione dove scura dai campi colava la terra disciolta e trascinata dalla forza dell’acqua.
Tutta la vita così”, pensai mentre assumevo un’espressione tragica. La tragedia greca mi è sempre piaciuta assai.
Sarà dura arrivare alla fine!”.
Ero di nuovo stanco e scoraggiato. Volevo trovare una camera dove passare la notte già cominciata.
Guardavo le case lungo la strada, ma il buio e la grande miopia mi rendevano difficile la ricerca dellubi consisterem notturno.
Finalmente potei scorgere un cartello con la scritta Zimmer frei attaccato alla porta di una casa a tre piani. Tutto quello che sapevo di tedesco.
Mi fermai, scesi dalla Seicento, suonai. Una finestra del secondo piano si schiuse: ne sbucò una testa bianca che richiuse subito i vetri senza dire parola. Aspettai un poco con la voglia di cercare più avanti, ma l’anziana venne ad aprire quasi subito. Zimmer frei?” chiesi. Quella disse: Passport” e tese la mano. Glielo diedi. La vecchia lo prese e guardò la fotografia confrontandola, sospettosa, con la mia faccia. Poi disse Eine moment!”. Quindi si mosse verso una piccola porta situata a metà del corridoio quasi buio che dall’ingresso menava a una scala. Aprì quell’uscio, disse qualcosa a qualcuno e tornò. Camminava piuttosto in fretta per la sua età. Subito dopo dallandito scuro arrivò un’altra donna anziana, somigliante alla prima, meno arcigna nel volto però. Al punto che mi sorrise. Me ne rincuorai. Parlarono un poco tra loro, mentre guardandomi di sbieco mi esaminavano. Infine capirono che non avevo intenzioni cattive. Forse hanno capito che non sono Raskolnikov”, pensai.
La meno aspra mi diede due chiavi: una della porta esterna che mi fece aprire e chiudere diverse volte per la paura tipica dei vecchi di non avere la casa serrata bene, l’altra della mia stanza, che mi indicò con un dito, al piano di sopra.
La più diffidente e dura, non condividendo, forse, l’atto, ritenuto incauto della sorella, si mise ad agitare entrambe le mani: con la sinistra, più arretrata, accennava a restituirmi il passaporto, ma con la destra, tesa quasi fino al mio volto, manifestava il desiderio di essere pagata in anticipo, sfregando rapidamente l’indice con il pollice e dicendo: Schilling, schilling“, più volte. All’epoca leuro non cera. Poi scrisse un numero. Un prezzo non esoso invero, e colazione compresa. Pagai, riebbi il passaporto, e salii nella camera. Era spaziosa, poco illuminata e fredda. Mentre sistemavo la roba, pensai cosa potessero significare quelle due donne che mi avevano dato ospitalità nella notte ma con diffidenza. Anche loro erano simboliche. Erano simboli delle mie zie, le sorelle maggiori di mia madre, la Rina e la Giulia.
Io dovevo fruire della loro ospitalità a Pesaro destate, e a Bologna nella casa che mi avrebbero comprato dopo la laurea, e dovevo ripagarle, ossia ricompensarle facendo un poco di carriera nella scuola: se fossi diventato professore di greco e latino nel miglior liceo di Bologna, loro due, ex maestre elementari, all’estero, tra l’altro a Budapest, quando cera il fascismo, poi in Italia, ne avrebbero avuto sufficiente soddisfazione. Dovevo rispettarle ed essere grato per l’aiuto che già allora ricevevo, però non dovevo permettere alle due zie anziane, più o meno fasciste e pretificate, di interferire nella scelta delle mie donne, del mio destino. Volevano che mi sposassi coon una brava collega”. Ossia una ragazza di famiglia borghese, vergine, che insegnasse, mi facesse da mangiare e tenesse ordinata la casa. Io invece non volevo una moglie tratta dalla sesquiplebe, ma unamante bella, intelligente, sensibile, colta, sportiva. Unartista, una della mia levatura potenziale. Diverse amanti possibilmente, magari una alla volta, una più speciale dell’altra. I luoghi comuni, la gente ordinaria mi davano noia. Mi mancava la compagnia di gente del mio stampo. Potenziale anche questo.
Uscii per mangiare in fretta e tornare presto in camera. Volevo alzarmi la mattina di buonora. Fuori pioveva sempre e faceva freddo. Mentre mangiavo, pensai che dovevo orientarmi cercando di capire il destino: cogliere e interpretare i segni del cielo e di Dio che, con la sua mente ordinata e magnanima, nulla lascia procedere a caso. E avverte con segni chi sa leggerli. Questi non sono sempre chiarissimi, ci vuole un animo attento e allenato per comprenderli. Io ci facevo caso fin da bambino.
Ricordai che Ammiano Marcellino commenta positivamente l attenzione del suo eroe, l’imperatore Giuliano Augusto per gli auspici che si traggono dagli uccelli: non che i volatili conoscano il futuro, sed volatus avium dir?git deus[11]
Pensando ai segni ricevuti quel giorno, mi addormentai.
All’una, fui svegliato da un campanello. Prima credetti di sognare quel suono, poi mi svegliai. Qualcuno suonava davvero e con insistenza. Nessuno andava ad aprire. Vecchie sorde o paurose. Ancella infingarda, se cera. Io? Non centravo, non mi sembrava il caso, poi avevo paura. Continuò per alcuni minuti. Maledetto. Ma no, forse era un altro segno benedetto, un segno sonoro. Rimasi sveglio una mezzora per interpretarlo.
Lo feci in questo modo: Non addormentarti, non rimanere nella casa di Pesaro. Non è l’ambiente dove puoi svilupparti. Svegliati, alzati, cerca nuove dimore, nuove esperienze, anche a costo di ferirti, di smarrirti nel mondo. Se resti là, sei perduto per sempre. A Debrecen, cerca di conoscere delle persone, delle donne soprattutto, prova a iniziare una vita nuova!”
Arrivai alla frontiera ungherese che cera il sole. Mi chiesero se avessi una fotografia per il visto. Non lavevo. Me ne fecero quattro dopo avermi messo seduto davanti a un muro. Me ne lasciarono una. La conservo. Ci vedo la faccia ombrosa di un ragazzo occhialuto, grasso, foruncoloso. Con un aspetto siffatto non sarebbe stato facile risalire la china. Dovevo modificarlo. Rimpastarmi, come diceva la madre mia benedetta. Sport ci voleva, abbronzatura, corse, bicicletta, nuoto e digiuni. Poi le lenti a contatto. Dovevo ritrovare il compiacimento e l’orgoglio di me stesso, quelli che avevo quando studiavo al liceo Terenzio Mariani e vincevo tutte le gare. Riprendere a primeggiare dovevo. Nello studio e nello sport. Dopo il liceo infatti mi ero degradato con il cibo, con la pigrizia e con le lamentele, querimonie plebee.
Ripartii consolandomi con il pensiero che in fondo avevo già dato parecchi esami e quasi tutti con ottimi voti. Questo non bastava: anche tanti imbecilli e ignoranti li prendevano da professori che erano a loro volta in non piccola parte ignoranti e imbecilli. Per farmi coraggio, pensai che il mio sovrappeso era di una decina di chili, non di trenta: non ero ridicolo, non mi indicavano a dito. Dunque potevo rifarmi. Il fondo oramai, il mio punto più basso lavevo toccato. Se non risalivo, morivo laggiù.
Arrivai a Budapest verso le due del pomeriggio. Mi fermai un’ora per mangiare. Non avrei dovuto. Più avanti sarei riuscito a saltare il desinare. Ancora non avevo assimilato il divieto, quel vetitum che sarebbe diventato il primo tabù del mondo occidentale, una volta caduta la proibizione del sesso. Poi sarebbe arrivata la diffusione del virus dellAIDS a ripristinarla in termini di nosofobia.
La città danubiana mi sembrò enorme e dispersiva, mentre di fatto è bella e magica ancora più di Praga. Ma avevo gli occhi offuscati da tante paure. Non trovavo la strada per Debrecen. Dovetti chiederla per una decina di volte. Finalmente riuscii a infilarla. Era, è la Üll?i út, la numero 4. Seguendola per 220 chilometri si arriva a Debrecen. La terra del mio riscatto. Erano passate le quattro. In quel momento prevaleva l’angoscia di non arrivare prima del buio. Il sole non era più tanto alto da rassicurarmi. Calcolai che il tramonto da quelle parti cadeva mezzora prima che da noi: entro le otto il dio sarebbe sparito alle mie spalle, entro le nove sarebbe stato buio pesto. Calcolare, conteggiare, riflettere mi è sempre servito a minimizzare l’angoscia, a difendermi dai colpi bassi della fortuna e dalle fregature dei farabutti.
Lanciai la povera, stanca Seicento verso la puszta, il deserto degli Ungheresi, coltivato del resto a girasoli, verdure, grano e foraggio.
Il grano era stato già mietuto. Pensai alla morte di Adone ucciso dal cinghiale[12], ma anche alla rinascita di ogni vita, comprese quella del grano e la mia.
I girasoli avevano le teste chinate a terra. Mi sembravano fanciulle timide. Mai quanto me, pensavo quel giorno. Più che timido allora ero goffo, insicuro, incapace di piacere a una donna, a chicchessia.
Ero imbruttito parecchio dagli anni buoni del liceo. Ero appassito anzi tempo. Ero un virgulto di ieri, di ieri l’altro. Inoltre mi vestivo male e mi lavavo poco, e non per imitare Socrate del quale all’epoca non sapevo che non curava l’igiene poiché non avevo letto Aristofane[13].
A metà strada fra Budapest e Debrecen, cominciò a piovere.
Avevo sonno e avevo paura di perdermi nella puszta infinita, o quanto meno di non arrivare in tempo per inserirmi tra gli altri.
Pioveva sui girasoli reclinati, sulle oche bianche, sui maiali neri che animavano quella grande pianura semideserta. Per vincere almeno il sonno, mi fermai in una bettola di un paese, Abony, a bere un caffè. Non prevedevo che in quel locale avrei fatto una sosta trionfale, più volte tornando da Debrecen, ogni volta con una donna diversa, ma sempre bella, fine e innamorata di me.
Sarebbe diventato un rito celebrativo di trionfi erotici.
Sperarlo allora sarebbe stata follia.
Quel pomeriggio del ’66, passate le cinque, avevo anzi paura di essere tagliato fuori dall’amore e dalla felicità. Troppo grasso, sfiduciato e malvestito. E gli occhiali grossi e spessi. E con diversi denti cariati. E pioveva. E non era presto. Né mi sbrigavo. In fondo al locale affumicato cera un pianista terribile e miserevole. Suonava Mezzanotte a Mosca in maniera atroce. Potrei fare una fine del genere”, pensai. Girare per taverne, soffrire le cimici[14], recitare Leopardi: O natura, natura, perché non rendi poi” Oppure: non compagni, non voli, non ti cal dallegria, schivi gli spassi” E via lamentandomi con parole non mie.
Invece anche quella melodia sgangherata prediceva un poco di bene: qualche giorno più tardi, a Debrecen, una ragazza russa cantò Mezzanotte a Mosca, poi, parlando con me, mi diede animo dicendomi parole buone. Forse cominciai a risalire la china aggrappandomi a quelle frasi benevole.
Mi rimisi in viaggio alquanto disanimato.
A cinquanta chilometri dalla meta però riapparve il sole.
Mi rianimai.
Nonostante la paura di fare tardi, mi fermai per chiedergli aiuto.
Se dopo tanta pioggia, sia pure intermittente, arrivo in un momento di cielo sereno, questo viaggio termina con un auspicio favorevole. Sono pronto a ricominciare. Aiutami Elio. Dio, non permettere che una tua creatura più buona che cattiva soffra tanto per tutta la vita”.
Dio mi esaudì. Quel viaggio nella terra dei Magiari, la Magyarország, era voluto dal Fato. Mi avrebbe emancipato e staccato dal mio passato, dai parenti disordinati, dall’ambiente meschino di Pesaro, e mi avrebbe messo in contatto con le cose belle che mi spettavano, per la mia natura prevalentemente buona e forte: con le lettere, con il meglio di questo mondo, con le idee iperuranie, e soprattutto con le donne belle e fini che mi erano predestinate. Avrei riformato il carattere che è l’orientamento.
Il carattere buono si orienta sulla stella polare del Bene, quello cattivo vede solo il male.
O primo fra tutti gli dèi[15]“” ripresi a pregare , tu ora, dopo la pioggia, mi appari fulgente e benedici il mio ingresso in questo nuovo mondo. Significhi che vuoi aiutarmi”.
Pensavo al sole e a Dio come a una una donna bella e fine, una mamma che mi avrebbe fatto incontrare le donne che mi spettavano e mi aspettavano.
Risalii nellautomobile. Il sole calava nella puszta, a sinistra. Non si vedevano uomini né alberi, ma girasoli dalle teste un poco risollevate, almeno così mi sembrò, gambi di spighe di grano, foraggio, verdure, pozzi strani, muniti di antenne lunghissime, oche e maiali muniti di candide zanne. Nel cielo volavano grandi uccelli bianchi dalle ampie ali[16], forse cicogne dal becco crepitante[17].
Arrivai a Hajdúszoboszló, un paese dal nome lungo e difficile”, pensai come lo vidi scritto. Un nome che per tanto tempo non seppi imparare e continuai a chiamare quel paese dal nome lungo alle porte di Debrecen”. Erano le sette passate. Il sole si era già posato sulla pianura come un uccello stanco del volo[18]. Grazie a Dio mancavano solo una ventina di chilometri. Feci un’ultima corsa e giunsi alla periferia di Debrecen quando Elio auriga[19] aveva già scolto i cavalli[20], ma solo da pochi minuti. Ci si vedeva ancora a bastanza. Entra nella via principale. Una strada larga e battuta dal vento che sollevava la polvere. Vi camminava gente malvestita. Anche gli edifici erano tenuti male. Il luogo mi si addiceva, messo male comero anche io. Mi guardai intorno, chiedendomi dove avrei potuto informarmi sullubicazione dell’Università. Vidi un locale con una scritta comprensibile: Hungaria. Ci entrai. Aperta la porta, mi affacciai su una grande sala piena di tavoli, quasi tutti occupati. Cera anche unorchestra piuttosto chiassosa che musicale. Le pareti erano parzialmente coperte di tende bianche e gialle tra le quali apparivano stucchi pompieristici, colonne corinzie e pilastri.
Mi avvicinai a un cameriere e gli domandai dove fosse l’Università che credevo parola internazionale. Loro invece dicono egyetem. Sicché non ci si capiva. Quello per giunta era assai affaccendato: nemmeno mi guardava mentre cercavo di farmi comprendere, invano. Quando vide entrare una brigata di anziani allegri, si allontanò senza avermi risposto. Ci rimasi male assai, mi sentii umiliato da quel servitore, ma gli andai dietro ripetendo la domanda in inglese e in italiano. Linsolente, seccato, gridò: Budapest!” accrescendo il mio sconforto. Lo lasciai andare. Ebbi paura che nell’immensa barbarie di quella landa remota non ci fosse alcuna università. Forse cera stato un equivoco colossale. Uscii con l’animo a terra. Oltretutto da Oriente arrivava la notte.
Nella via principale si vedevano, confuse tra loro, le ultime luci del giorno e le prime artificiali del paese assediato dal buio. Camminai nella direzione del cielo ancora rosso. Se avessi seguito la traccia lascita dal sole, le sue palpitanti vestigia per tre chilometri, sarei arrivato alla nyári egyetem, l’Università estiva, prima che il sole si fosse immerso del tutto.
Tu scaldi il mondo, tu sovresso luci:/saltra ragione in contrario non pronta,/esser dien sempre li tuoi raggi duci”[21]. Questi versi però allora non mi vennero in mente.
In fondo alla via cera il grande tempio della città, una chiesa calvinista, come seppi più tardi. Era giallo. Avrei saputo più tardi che era il simbolo di Debrecen che era stata, dicevano, la Roma calvinista”.
Il cuore della città e, per quanto mi riguardava, del mondo intero, era il tempio grande. Il tempio grande era talmente grande che non riuscivo a misurarlo con il metro della realtàLa sua facciata gialla terminava in un triangolo, le torri erano munite di occhi e bocca con i volti umani, non ho più visto in vita mia un edificio che palpitasse di tutta quella vita, sembrava persino che respirasse”[22]. Quella notte io vidi solo che era giallo e turrito.
Mi fermai un momento. Lì sembrava finire, anzi finiva il centro di Debrecen: al di là del Grande Tempio si vedeva una via deserta, alberata, buia oramai.
Nel crepuscolo della sera è l’oscurità a essere attiva”[23].
Sulla sinistra, rispetto a chi guarda il tempio, cera un altro edificio grande, e pure animato.
Un palazzo di sei o sette piani, sormontato da lunghi pinnacoli pseudogotici, quasi un castello, simile a quelli teatrali fatti costruire in Baviera da Ludwig, il l’unatico re sodomita.
Sopra il portone dell’ingresso formicolante, cera uninsegna fatta di pezzi disposti a formare un cerchio. Mi avvicinai. La semicirconferenza superiore era costituita dalle lettere H O T E L, lnferiore da quelle più piccole e fitte di una parola lunga e illeggibile. Mentre cercavo di leggere la scritta, questa si accese. La parola strana era Aranybika e la figura un toro. Significava toro doro” come seppi più avanti. Entrai nell’atrio che brulicava di gente diretta al ristorante con pista da ballo.
Andai dal portiere, un uomo d’aspetto civile. Gli domandai se parlasse italiano. Con mia sorpresa rispose di sì. Contento di tale successo, gli chiesi dove fosse l’università. Io era uno studente borsista. Mi rispose che di notte l’accademia era chiusa: potevo andarci la mattina seguente; lui mi avrebbe indicato la strada. Intanto potevo dormire nellhotel, per venti dollari.
Questo portiere dallambiguo sorriso, tira a fregare” pensai. Un collegio universitario dove gli studenti mangiano e dormono, non puà essere chiuso alle otto e mezzo. Però non ho scelta: in questo paese da solo non me la cavo.
Va bene”, dissi, prendo una camera”.
Gli diedi il passaporto e il denaro. Poi gli chiesi di spiegarmi comunque, subito, dov’era l’Università. Mi all’ungò la chiave, e con riluttanza disse che dovevo prendere il tram numero uno nella direzione del grande tempio. Cercai la camera per posarvi il bagaglio ma non la trovavo. Mi sentivo incluso in un labirinto di nuovo genere[24]. Dovetti tornare indietro per farmi indicare la stanza una seconda volta, Dopo lestorsione dei dollari, quel portiere di notte mi era diventato antipatico. Anzi, tutto l’ambiente di quellhotel pretenzioso e pitocco mi era antipatico. Non vi sarei rimasto per cena Sarei andato a mangiare piuttosto allHungaria dove il cameriere era più rozzo del necessario, e sgarbato, ma non truffaldino e ricattatorio.
Così al primo impatto lAranybika, il toro doro, mi diede un piccolo dispiacere. Provengo da gente parsimoniosa e lo sono anche io, ma più che per i venti dollari ero dispiaciuto per la truffa e il ricatto di quellambiguo guardiano, probabilmente un prosseneta.
Eppure non ero del tutto scontento: intanto avevo trovato una camera e un letto dove passare la notte. Tornato sulla strada anzi mi sentivo quasi contento. Forse antivedevo e pregustavo il futuro.
Infatti con il passare del tempo, anni di tempo, e nel lungo progresso della mia persona, proprio lì, nel grande hotel della città della puszta, avrei vissuto diverse ore piacevoli e importanti per la mia crescita, in compagnia di alcune delle donne belle e fini che dovevano stimolarmi a crescere, a diventare una persona non infelice, non brutta, non cattiva. Adesso il grande albergo di Debrecen è un monumento duraturo più della sua materia, edificato dentro l’anima mia. Contiene la memoria di alcune tra le ore più intense della mia gioventù, un ricordo che nei momenti difficili in quanto deserti di affetti, mi incoraggia a procedere verso tempi migliori che, come i peggiori del resto, ricorrono sempre.
Quella sera dellagosto del 1971 dunque tornai trionfalmente allArany bika, fiero della bella donna e delle mie prestazioni da atleta del sesso.
Cenammo e bevemmo il solito sangue di toro.
Parlammo anche molto. Ci soffermammo sul significato della parola cultura, come contrappeso al pur pregevole scatenamento istintivo del pomeriggio.
Lapollineo dopo il dionisiaco.
Cultura per me”-dissi- non è il sapere degli eruditi dall’anima gobba, ma è sapienza che sa di vita, ossia è potenziamento della natura. Questa formula lho imparata da Nietzsche, ma il fatto lho sperimentato nella prassi, anche con te. Non credo che saresti venuta a letto con me se non ti avessi attirata presto con alcune frasi belle prese a prestito dai miei autori. Non li ho derubati, poiché la bellezza delle parole per fortuna non è soggetta alla legge iniqua dell proprietà privata.
Cultura è conosci chi sei”, poi diventa chi sei”. Cultura è niente di troppo”. Se mi chiedi a che cosa serve, ti rispondo che serve ad amare, a fare l’amore come lo facciamo noi due”.
Cultura è rispetto e amore per la vita”, aggiunse Elena.
Alta cultura è l’amore nostro, l’amore tra noi due, il farlo tante volte, non esserne mai sazi. Io ti amo per il tuo aspetto bello che riflette un’anima bella e fine, come le tue parole”. Le dissi
Io ti amo perché sei buono, Gianni, e non giochi con il cuore delle persone, come fanno quei buffoni dei tuoi amici. Ti amo perché sai ascoltare, osservi con attenzione le persone e la natura, e sei naturale, non artefatto”
Osservo soprattutto te, amore mio, con enorme attenzione. La mia naturalezza comunque , se non proprio costruita, certo è stata educata, dai libri e dagli incontri buoni che ho fatto, in primis con te. Chi non viene corretto e motivato da buoni educatori, rimane vittima della pubblicità, o dei partiti che vogliono portare le teste all’ammasso, o resta schiavo dei luoghi comuni estranei alla realtà effettuale.
Noi due, con il nostro parlare e fare l’amore confutiamo in continuazione i pregiudizi degli imbecilli e le astute menzogne dei profittatori “.
Intanto gli zigàni suonavano musiche popolari ungheresi.
Si mangiava e si beveva bene, e tutta l’atmosfera ci infondeva certezza del nostro amore, sicurezza nei nostri ruoli, insomma felicità.
A un certo punto mi scusai e andai in bagno. Soprattutto per guardarmi allo specchio, osservare la mia faccia giovane, tutt’altro che brutta, e compiacermene. Ce l’hai fatta Gianni”, mi dissi. Ce l’hai fatta. Rendi grazia al Creatore, a Elena, alla mamma che ti hanno modellato così bene. E dopo tutto anche al padre tuo, e alle zie, la Rina, la Giulia, la Giorgia che ti hanno aiutato.
Questa donna ha trovato e raccolto i miei pezzi mentali ancora sparsi e confusi, e li sta mettendo insieme giusto in tempo per rimettermi in vita e in gioco, in questo gioco competitivo, terribile e bello che è la vita umana. D ora in avanti non voglio perdere più nemmeno una gara. Le sarò grato per sempre”.
Quindi tornai al nostro tavolo e ripresi a parlare con lei, ad ascoltarla, a osservarla e ammirarla. Più tardi facemmo ancora l’amore, nel grande bosco.
Il grande bosco è rimasto per sempre il bosco più bosco di ogni bosco, più suggestivo delle foreste del Caucaso o della Svizzera, forse perché crescendo su terre sabbiose forniva un esempio di tenacia che gli dava una vita, nonostante le sue misere risorse, piena di forza e di robustezza, che altrove non vedevo mai”[25].
Le cantai e tradussi una strofe della Canzone di Marinella di Fabrizio de Andrè, un altro dei miei educatori.
E cera il sole e avevi gli occhi belli,
io ti baciai le labbra ed i capelli.
Cera la luna e avevi gli occhi stanchi,
io misi le mie mani sui tuoi fianchi”.
Eravamo felici.
Giovanni ghiselli [email protected]>
-
leggi anche:
-
Helena Sarjantola, una storia d’amore tutti gli 8 capitoli in pdf, di Giovanni Ghiselli
-
Helena Sarjantola, una storia d’amore I capitolo – L’incontro nell’Università di Debrecen, di Giovanni Ghiselli
-
Helena Sarjantola, una storia d’amore – secondo capitolo Il giro nella puszta e il dialogo nel bosco dell’Università di Debrecen, di Giovanni Ghiselli
-
Helena Sarjantola, una storia d’amore – terzo capitolo Il picnic crepuscolare. Elena alla finestra, di Giovanni Ghiselli
-
Helena Sarjantola, una storia d’amore – quarto capitolo di Giovanni Ghiselli
-
Helena Sarjantola, una storia d’amore – quinto capitolo “L’annunciazione” di Giovanni Ghiselli
-
Helena Sarjantola, una storia d’amore – sesto capitolo “L’amore, la lettera di addio” di Giovanni Ghiselli
-
Helena Sarjantola, una storia d’amore – ottavo capitolo “L’alba nellorto botanico” di Giovanni Ghiselli
-