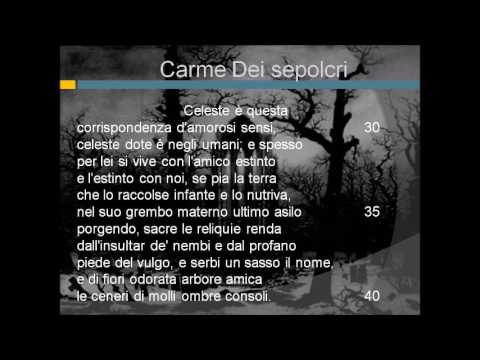Altri scritti letterari di Ugo Foscolo
28 Dicembre 2019
Introduzione al carme Dei Sepolcri di Ugo Foscolo
28 Dicembre 2019Nella prima parte del Carme dei Sepolcri di Ugo Foscolo, il poeta sviluppa una meditazione intensa sulla morte, sul valore dei sepolcri e sulla memoria come legame tra i vivi e i defunti.
Foscolo critica la legge napoleonica del 1804, che imponeva la sepoltura in cimiteri situati fuori dalle città, allontanando i morti dagli affetti dei cari. Foscolo esprime il timore che la perdita di questo legame simbolico e affettivo con i defunti porti a una società priva di radici morali e civili. Attraverso immagini suggestive e figure retoriche, il poeta ci porta a riflettere sul significato della morte, della memoria e dell’eredità affettiva, in cui la tomba diviene un simbolo di continuità e sacralità per l’intera comunità.
Testo e parafrasi
|
Testo All’ombra de’ cipressi e dentro l’urne Tutte cose l’obblio nella sua notte; Sol chi non lascia eredità d’affetti Pur nuova legge impone oggi i sepolcri Forse tu fra plebei tumuli guardi 70 Rapían gli amici una favilla al Sole |
Parafrasi:
All’ombra dei cipressi e dentro le urne bagnate di lacrime, forse il sonno della morte è meno duro? Quando il Sole non illuminerà più per me questa terra piena di piante e animali, e quando le ore future non mi faranno più sognare con le loro promesse, e non sentirò più il tuo verso, caro amico, e la triste armonia che lo accompagna, e non proverò più nel cuore l’ispirazione delle Muse e dell’amore, unico conforto della mia vita errabonda, quale consolazione potrà darmi una pietra che distingua le mie ossa dalle tante altre disperse dalla morte sulla terra e nel mare? È vero, Pindemonte! Anche la Speranza, ultima Dea, abbandona i sepolcri; l’oblio avvolge ogni cosa nella sua oscurità, e un’energia instancabile muove tutto di continuo; l’uomo e le sue tombe, e l’aspetto estremo delle cose e le reliquie della terra e del cielo, tutto viene trasformato dal tempo. Ma perché il mortale dovrebbe rinunciare in anticipo all’illusione che, anche dopo la morte, lo trattiene alla soglia dell’Ade? Non continua forse a vivere anche sotto terra, quando il suono del giorno gli sarà cessato, se può risvegliarlo nella mente dei suoi cari attraverso dolci ricordi? Questa corrispondenza di affetti è un dono divino, un dono celeste per gli uomini; e spesso, grazie a esso, si vive insieme all’amico morto e il defunto vive con noi, se la terra che lo accolse da bambino e lo nutrì gli offre come ultimo rifugio il suo grembo materno, rendendo sacre le sue reliquie, difendendole dalle intemperie e dalla profanazione dei passanti, conservando una pietra con il suo nome e una pianta profumata che protegga le sue ceneri con la sua ombra dolce. Solo chi non lascia eredità di affetti non trova alcun conforto nell’urna; e anche se potesse vedere, dopo la morte, il suo spirito vagare tra i lamenti dell’Ade o trovare rifugio sotto le grandi ali del perdono divino, la sua polvere rimarrebbe abbandonata alle ortiche di una terra desolata, dove nessuna donna amata prega né un passante ascolta il sospiro che dalla tomba manda la Natura. Ora, però, una nuova legge impone che i sepolcri siano collocati fuori dalla vista dei cari, e nega ai morti la consolazione del loro nome. E senza una tomba giace il tuo poeta, o Talia, che cantando per te, nel suo umile rifugio coltivava con amore un alloro e componeva corone per te; e tu abbellivi i suoi versi con il tuo sorriso, versi che criticavano il Sardanapalo lombardo, che trova piacere solo nel muggito dei buoi che, dai pascoli vicini e dal Ticino, gli portano ozio e cibo in abbondanza. O bella Musa, dove sei? Non sento più il profumo divino, segno della tua presenza, tra queste piante dove siedo pensando alla mia casa natale. Un tempo venivi e sorridevi a lui sotto quel tiglio che oggi, abbassando i rami, trema perché non copre più, o Dea, l’urna del vecchio a cui un tempo donava pace e ombra. Forse ora vaghi fra le tombe comuni, cercando dove riposa il capo venerato del tuo Parini? A lui la città, che seduce con i suoi piaceri i cantori decadenti, non ha riservato una tomba fra le sue mura, né una pietra né un’iscrizione; e forse le sue ossa, con il cranio mutilato, sono insanguinate dal ladro che ha lasciato i suoi crimini sul patibolo. Senti grattare fra le macerie e i rovi la cagna abbandonata che, affamata, vaga sulle tombe e ulula; e dal teschio, dove si nascondeva la Luna, esce l’upupa e vola tra le croci sparse nel cimitero, e col suo verso triste accusa le stelle, devote alle tombe dimenticate. Invano, o Dea, chiedi che la notte rugiadosa porti conforto al tuo poeta. Ahimè! Non fiorisce nessun fiore sui defunti se non è onorato dall’amore e dal pianto degli uomini. Dal giorno in cui matrimoni, tribunali e altari insegnarono agli uomini di essere compassionevoli verso se stessi e gli altri, i vivi sottraevano i miseri resti dei morti all’aria e alle bestie, che la Natura, attraverso cicli eterni, destina a nuovi scopi. Le tombe erano testimonianza di gloria, e altari per i figli; da esse provenivano le risposte degli spiriti domestici, e si temeva di giurare sulle ceneri degli antenati. Era una religione che, attraverso diversi riti, tramandava insieme le virtù civili e la pietà, di generazione in generazione. Non sempre le tombe pavimentavano i templi; né l’odore dei cadaveri avvolgeva i fedeli durante le preghiere, né le città erano rattristate da scheletri scolpiti: le madri, balzando spaventate dai loro sonni, tendevano le braccia sui loro bambini per proteggerli dai lamenti incessanti dei morti che chiedevano preghiere pagate ai loro eredi dal santuario. Ma cipressi e cedri, diffondendo nell’aria pura il loro profumo, proiettavano un verde eterno sulle urne, come simbolo di memoria perenne, e vasi preziosi raccoglievano le lacrime in segno di devozione. Gli amici portavano una scintilla di fuoco dal Sole per illuminare la notte della tomba, perché anche al momento della morte gli occhi dell’uomo cercano il Sole; e tutti inviano il loro ultimo respiro alla luce che se ne va. Le fontane versavano acque purificatrici, e amaranti e viole crescevano sul suolo funebre; e chi si sedeva per offrire latte e raccontare le sue pene ai cari estinti, sentiva attorno a sé una fragranza simile a quella dei Campi Elisi. Una pietosa illusione rende cari i cimiteri suburbani alle giovani inglesi, le quali si recano lì per amore della madre scomparsa, e pregano gli dèi che concedano un ritorno sicuro al marinaio che, dopo aver tagliato l’albero più alto della nave, se ne fece una bara. Ma là dove il valore delle gesta eroiche è dimenticato e il vivere civile si fonda solo sul lusso e sulla paura, sorgono cippi e monumenti di marmo come pompa inutile e con simboli funebri. I ricchi e i nobili, onore e intelligenza dell’Italia, trovano già da vivi sepoltura nelle corti dei potenti, con gli stemmi come unico vanto. A noi, invece, la morte offre un tranquillo rifugio, dove una volta per tutte la fortuna cessa di vendicarsi e l’amicizia lascia in eredità, non ricchezze, ma affetti e l’esempio di una poesia libera. |
Analisi delle figure retoriche e della stilistica del testo
- “All’ombra de’ cipressi e dentro l’urne / Confortate di pianto è forse il sonno / Della morte men duro?”
- Qui Foscolo inizia con una domanda retorica che introduce il tema centrale: il valore del sepolcro per chi è morto. La metonimia “confortate di pianto” fa sentire la presenza del ricordo e della partecipazione emotiva dei vivi.
- “Vero è ben, Pindemonte! Anche la Speme / Ultima Dea, fugge i sepolcri”
- La Speranza è personificata come l’Ultima Dea che, tuttavia, abbandona i sepolcri. Foscolo evoca una figura della mitologia greca e romana, aggiungendo solennità e sottolineando il senso di abbandono che caratterizza la condizione dei morti.
- “E involve / Tutte cose l’obblio nella sua notte”
- L’oblio è rappresentato come un’entità avvolgente e oscura, con una metafora che lo descrive come una “notte”. Questo termine trasmette l’inevitabilità del tempo, che oscura tutto ciò che esiste, inclusi i sepolcri e la memoria.
- “Celeste è questa / Corrispondenza d’amorosi sensi”
- La celebre metafora della “corrispondenza d’amorosi sensi” descrive il legame affettivo tra vivi e morti come un dono divino, rendendo sacro l’atto di ricordare. La parola “celeste” conferisce una dimensione spirituale al ricordo e al sentimento.
- “Lascia alle ortiche di deserta gleba / Ove nè donna innamorata preghi”
- Il sepolcro abbandonato alle ortiche è una metonimia per indicare l’oblio e la dimenticanza. Il contrasto tra il sepolcro desolato e l’assenza di una “donna innamorata” sottolinea la triste condizione dei morti senza affetti.
- “Non sento / Spirar l’ambrosia, indizio del tuo Nume, / Fra queste piante ov’io siedo e sospiro”
- L’assenza del profumo divino dell’ambrosia, simbolo della presenza della Musa, evidenzia l’isolamento dell’io lirico. Foscolo usa l’immagine dell’ambrosia per evocare la presenza divina e suggerisce la mancanza della Musa ispiratrice.
- “Senti raspar fra le macerie e i bronchi / La derelitta cagna ramingando”
- L’immagine della cagna abbandonata che raspa tra i resti è potente ed evocativa, una metafora del degrado e dell’abbandono della memoria dei defunti. La cagna diventa un simbolo della miseria e della solitudine delle tombe dimenticate.
- “Ahi! sugli estinti / Non sorge fiore ove non sia d’umane / Lodi onorato e d’amoroso pianto”
- Qui Foscolo esprime il concetto che la memoria e l’affetto sono necessari per dare un senso ai sepolcri, e usa una antitesi tra i “fiori” e il “pianto” per sottolineare la sacralità della memoria.
- “Testimonianza a’ fasti eran le tombe, / Ed are a’ figli”
- Le tombe erano luoghi sacri e testimonianze di valori per le generazioni future. Foscolo utilizza una antitesi fra “fasti” e “figli” per rappresentare l’eredità che le tombe lasciano alla memoria dei posteri.
- “Non sempre i sassi sepolcrali a’ templi / Fean pavimento”
- Foscolo critica il presente, in cui i sepolcri sono ridotti a “pavimento” per i templi, sottolineando il degrado dei valori e l’assenza di rispetto per i defunti. La metafora del pavimento rappresenta la perdita di sacralità del sepolcro.
Commento finale
In questi versi del Carme dei Sepolcri, Foscolo ci guida attraverso una riflessione complessa sul significato dei sepolcri e sul valore della memoria. La tomba non è solo il luogo di riposo per i defunti, ma anche il simbolo di un legame affettivo che unisce vivi e morti, creando una continuità fra passato e presente. La legge napoleonica di allontanare i cimiteri dalle città viene qui criticata da Foscolo perché, sottraendo ai vivi la possibilità di onorare i propri cari in un luogo accessibile, priva la società di un importante spazio di riflessione e ricordo.
La tomba, quindi, è anche un atto di responsabilità civile e morale: il ricordo e l’affetto dei vivi danno ai morti una sorta di immortalità simbolica. La memoria diventa, per Foscolo, un valore che trascende la vita stessa e che, grazie alla “corrispondenza d’amorosi sensi”, diventa quasi sacra.
L’opera si conclude con l’idea che i sepolcri dei grandi uomini possano ispirare le generazioni future, spronandole a compiere azioni eroiche e a costruire una società fondata sui valori di umanità e giustizia. Foscolo vede quindi nel sepolcro non solo il simbolo di un ricordo personale, ma un fondamento per la memoria storica collettiva che, se perduta, priva la società della sua essenza e dei suoi ideali più elevati.