
Canto trentatreesimo del Purgatorio
27 Gennaio 2019
Accordi tra le parti sociali che finalizzino quote di riduzione di orario alla fo…
27 Gennaio 2019Riflessioni sulla Rivoluzione francese sulla base della lettura del libro di Pierre Gaxotte, La rivoluzione francese, Milano, Oscar Mondadori 1989
Dal cap. 1: L’ANTICO REGIME
La Francia dell’Antico Regime era un edificio molto grande e molto antico costruito da cinquanta generazioni nel giro di oltre mille e cinquecento anni. Ciascuna vi aveva lasciato la propria traccia, sempre aggiungendo qualcosa al passato senza demolire o escludere quasi nulla. La pianta dell’edificio era pertanto confusa, gli stili disparati, irregolari le parti che lo componevano. Certe ali abbandonate minacciavano di crollare, alcune erano scomode, altre troppo fastose. Ma l’insieme era ricco, la facciata grandiosa, e ci si viveva meglio e più numerosi che altrove.
Le fondamenta più antiche erano opera della Chiesa. Nel corso di dodici secoli, essa vi aveva lavorato da sola o quasi.
Al tempo di Roma, in un mondo duro e freddo, la Chiesa aveva consolato dalle sventure, infuso il coraggio di vivere, l’abnegazione, la carità, la pazienza, la speranza in una vita migliore e più giusta. Quando l’impero si era sgretolato sotto i colpi dei barbari, essa era divenuta il rifugio delle leggi e delle lettere, delle arti e della politica. Aveva protetto nei suoi monasteri quanto si poteva salvare della cultura umana e della scienza. In piena anarchia, aveva organizzato una sua società viva e ordinata il cui spirito e la cui politica richiamavano i vecchi tempi tranquilli e ne suscitavano il rimpianto. Ma non solo: la Chiesa va incontro agli invasori, e li conquista, li rappacifica, li converte, ne incanala il flusso, ne limita la devastazione. Dinanzi al vescovo, rappresentante di un aldilà misterioso, il germano ha paura e si ritrae. Risparmia la gente, le case, le terre. L’uomo di Dio diventa il capo delle città, il difensore dei focolari e dei lavori, il solo protettore degli umili sulla terra.
Più tardi, passato il momento dei saccheggi e degli incendi, quando si dovrà ricostruire, amministrare, negoziare, le assemblee e i consigli apriranno le porte ai clerici, i soli in grado di redigere un trattato, di portare a termine un’ambasceria, di pronunciare un’arringa dinanzi a un principe.
Al rinnovarsi delle sventure, quando lo Stato carolingio si sfascia, nella notte del IX secolo piena del fragore delle armi, mentre nuove invasioni di ungari, saraceni e normanni si affacciano ai confini o sciamano per il Paese, mentre il popolo sparso fluttua senza una direzione, la Chiesa, ancora una volta, resiste. Essa riannoda le tradizioni interrotte, contrasta i tumulti feudali, regola le guerre private, impone tregue e paci. I grandi monaci Oddone, Odilone, Bernardo elevano, al disopra delle roccaforti e delle città, il potere morale della Chiesa, l’idea della Chiesa universale, il segno dell’unità cristiana. Predicatori, pacificatori, consiglieri di tutti, arbitri in ogni contesa, intervengono ovunque e in ogni problema, vere potenze internazionali cui i potenti della terra non resistono che tremando.
Intorno ai grandi santuari e alle sacre abbazie si annodano relazioni e viaggi. Lungo le piste di terra percorse dalle lunghe processioni dei pellegrini nascono le canzoni epiche. Indietreggiano le foreste, dissodate dai monaci. All’ombra dei monasteri, le campagne si ripopolano. Risorgono villaggi in rovina. Le vetrate delle chiese e le sculture delle cattedrali sono il libro d’immagini che istruiscono il popolo. Il papa è il dittatore dell’Europa. Ordina le crociate e depone i re. Dotazioni, ricchezze, onori, tutto viene messo ai piedi degli ecclesiastici, e l’eccesso di questi riconoscimenti attesta da solo la misurerà delle loro opere.
Ma già un altro artefice si era messo in azione: il signore feudale.
Quando lo Stato si indebolisce, gli individui meglio armati ne prendono il posto. Quando lo scettro di Carlomagno sfugge dalle mani deboli dei suoi successori, una generazione di soldati si leva a raccoglierne i pezzi.
Al pari del territorio, si sbriciola la sovranità. Una fitta germinazione di poteri locali ricopre il suolo. Funzionari imperiali, grandi proprietari, avventurieri che hanno fatto fortuna, briganti che hanno cambiato mestiere: questi nuovi reucci hanno mille origini. Violenze, soprusi, contratti, immunità, spartizioni. alienazioni. operanti secondo il capriccio delle circostanze: ecco le fonti instabili e incoerenti della loro forza. Tutte le mansioni del potere pubblico divise, frazionate, vendute, rubate. Chi s’impadronisce di un pedaggio, chi di un mercato. Non ci sono più eserciti, solo bande armate. La giustizia si spezzetta in mille giurisdizioni particolari: territoriale, personale, censuale, alta e bassa. Gli animi si dissolvono come i diritti. Un’unica forza permane: il valore, il coraggio, l’audacia, la brutalità dell’individuo.
L’insicurezza è generale. Ci si batte dappertutto. Le cronache non parlano che di assassini, di saccheggi, di incendi, di villaggi rasi al suolo, di donne violentate, di contadini massacrati. Per i deboli, la vita non è altro che un lungo terrore. Intorno al signore che ha un castello, dei soldati, un tesoro, corrono a raggrupparsi i contadini. In cambio della sua protezione e della sua giustizia, gli cedono parte del proprio lavoro e dei propri raccolti. I più sfortunati legano a lui la propria vita e quella dei propri discendenti. Costruttore del mulino, del forno e del ponte, egli è il padrone del traffico e degli scambi. Avvolge l’attività dei suoi clienti e dei suoi servi in una fitta rete di tasse e di monopoli. Ma cosa sono queste servitù in confronto alla vita che gli devono?
A una società smarrita, smembrata, dispersa, senza più leggi né guida, il feudalesimo ha dato delle strutture e dei capi. Per quanto anguste fossero le prime, sono riuscite a riunire la gente. Per quanto violenti fossero i secondi, essi hanno ristabilito le garanzie elementari senza le quali è impossibile sopravvivere. Il servizio che i signori richiedono è oneroso, i loro benefici eccessivi. Ma senza di essi, la situazione sarebbe ancora peggiore.
In seguito, il regime diventerà più mite, più umano. La Chiesa vi apporterà un po di ideali. Si aprirà uno spazio per i Comuni, che saranno simili a signorie borghesi e collettive. Con l’espansione a macchia dolio del movimento di emancipazione, i rudi baroni capiranno che i propri interessi coincidono con quelli dei loro protetti e che averne cura è ancora il mezzo migliore per trattenerli al proprio servizio.
Ai tempi di Luigi XII, in un Paese che non ha più bisogno della protezione dei signori e che fa già a meno dei loro servizi, essi conservano una così grande autorità nel villaggio che nulla si fa d’importante senza il loro parere e consenso. Sono oggetto di un rispetto familiare e di una riconoscenza spontanea. Li si invita alle feste di famiglia, ai banchetti di purificazione della puerpera, alle nozze e ai battesimi, ed essi vi fanno onore. Sono padrini dei figli e consiglieri dei genitori. Nell’antica fortezza ormai aperta verso l’esterno, interrotta da ampie finestre, senza più fossati né difese, la vita è simile a quella che si conduce nelle casupole intorno, uguali sono le preoccupazioni. Si pensa ai raccolti, al bestiame, alla pioggia, alle vigne, alla vendita del grano. Signori e villani si ritrovano alla fiera. Se la giornata è stata buona, trincano alla locanda, scambiandosi battute grossolane e gran pacche cordiali tra un bicchiere e l’altro. Al cader della notte, si vede rincasare il signore, fieramente piantato sul suo ronzino, con la spada al fianco e un pane sotto il braccio, e il suo fattore in sella dietro di lui.
Tutto questo non era però che una sopravvivenza del passato: le sovranità locali erano colpite a morte, e ormai da tempo era giunto il momento del re. (…)
pp. 11-14
La maniera in cui la nazione si era formata per annessioni successive sulle rovine della Francia feudale imponeva al potere regio, teoricamente senza limiti, caratteristiche e restrizioni che noi, cittadini di uno Stato burocratico, napoleonico e semi-nazionalizzato, stentiamo a comprendere.
L’autorità ci si presenta oggi sotto le sembianze di un funzionario seduto a una scrivania e investito dei più ampi poteri, tra cui quello di trasformarci in soldati e spedirci sui campi di battaglia a farci bersagliare dalle pallottole.
Questo personaggio è eterno, immutabile, identico a se stesso da un capo all’altro del Paese. In pianura e in montagna, nell’Ile de France e in Lorena, egli applica i medesimi regolamenti e percepisce le medesime imposte. E’ onnipotente perché la sua specie è numerosa, perché tutti hanno bisogno di lui, perché i suoi decreti sono sostenuti da una polizia attiva, una magistratura vigile e un immenso apparato coercitivo. Egli censisce, registra, spia. Calcola i nostri redditi e fa l’inventario delle nostre eredità. Sa se possediamo una radio, un cane o un’automobile. Egli istruisce i nostri figli e fissa il prezzo del nostro pane. Fabbrica i nostri fiammiferi e ci vende il tabacco. E’ industriale, armatore, commerciante, assicuratore e medico. Possiede quadri, foreste, ferrovie, ospedali, banche e officine. Gestisce la beneficenza. Se siamo di sesso maschile, ci convoca, ci pesa, ci misura, esamina il funzionamento del nostro cuore, dei nostri polmoni e della nostra milza. Non possiamo fare un passo o un gesto senza che egli ne sia avvertito, senza che trovi il pretesto per intervenire.
Senza contare le industrie nazionalizzate, almeno un milione di francesi sono al suo servizio, due o tre milioni ricevono pensioni da lui e gli altri aspirano a riceverle. Tutti brontolano, ma obbediscono, e quando uno dei suoi agenti viene mal-menato da un elettore scontento, una voce unanime si leva a deprecare quest’audacia, a chiedere prigioni e giudici per punire il sacrilegio.
Questo concetto di un governo burocratico servito da un esercito di funzionari, e che promulga un’unica legislazione per una nazione di amministrati, è forse quanto di più estraneo all’Antico Regime si possa immaginare. I più grandi riformatori, i più appassionati sostenitori dell’unità della nazione, Colbert, Machault, Maupeou, Lamoignon, non avrebbero potuto nemmeno immaginare una simile uniformità e docilità.
Napoleone, in seguito, ha costruito il suo nuovo edificio su un terreno livellato, a forza di decreti. Dopo di lui, i progressi nelle comunicazioni e nelle informazioni hanno rafforzato ulteriormente l’ombroso autoritarismo del potere centrale. monarchia invece, mediante imprese lentamente concepite e lentamente attuate, passo per passo, aveva riunito alla Corona vecchie province che avevano ciascuna la propria organizzazione e i propri costumi. Ed essa ne aveva rispettato le particolarità. Il regno era uno nella persona del principe, multiplo nelle sue istituzioni.
Nel 1668, dopo la prima conquista della Franca Contea, Luigi XIV firmò con i rappresentanti del Paese un capitolato il cui primo articolo dice:
«Ogni cosa rimarrà in Franca Contea nel medesimo stato in cui attualmente si trova, per quanto riguarda privilegi, franchigie e immunità».
clausola garantiva il rispetto delle leggi e degli editti in vigore sotto la dominazione spagnola; un’altra vietava l’introduzione di nuove imposte; un’altra ancora conservava a Besançon la sua Accademia. Dole otteneva di essere la sede delle riunioni degli Stati… e infine, l’atto terminava con questa dichiarazione:
«Sua Maestà promette e giura sui Santi Vangeli che Ella e i suoi augusti successori conserveranno e manterranno con cura e lealtà ogni e qualsivoglia loro privilegio, franchigia e libertà, antico possesso, usanza, costume e ordinamento, e che in generale Ella farà tutto ciò che un Principe e Conte Palatino di Borgogna è tenuto a fare».
Ampliate quest’esempio, raffiguratevi le province, le città, le classi, le associazioni, i mestieri, le cariche, tutti provvisti di carte, diritti, immunità, statuti di ogni entità e di ogni natura, e avrete un’idea di ciò che era la Francia di Luigi XV e di Luigi XVI, e del modo in cui poteva essere esercitata la volontà reale.
Nonostante l’immane sforzo di semplificazione compiuto sotto Luigi XIV, ad ogni decisione del governo continuava ad opporsi una massa di tradizioni, di contratti, di promesse, di diritti acquisiti di cui si era costretti a tener conto. Bisognava discutere, comporre, accordare delle riduzioni, degli esoneri e delle eccezioni. Anche gli ordini più formali finivano corretti ed emendati da questo insieme di pratiche contro le quali non cera nulla da fare e che, insieme alla successione al trono per ordine di primogenitura, costituivano propriamente quelle «leggi fondamentali» del regno, sempre invocate, sebbene mai scritte, mai presentate e mai promulgate. I ministri si lamentano continuamente delle difficoltà di governare uno Stato composto di organismi e dì cittadini così pronti a bloccare le iniziative del loro re: «Non si può muovere un passo in questo vasto reame» diceva Calonne «senza trovarvi leggi diverse, usanze contrastanti, privilegi, eccezioni, esenzioni d’imposta, diritti e pretese di ogni sorta», e, da ministro autoritario e riformatore, aggiungeva: «Questa dissonanza generale complica l’amministrazione, ne interrompe il corso, ne inceppa i meccanismi e moltiplica ovunque le spese e il disordine».
pp. 16-19
Dal cap. 2: LO STATO POVERO NEL PAESE RICCO
La miseria può suscitare sommosse, non sostenere rivoluzioni, che hanno cause più profonde; e comunque, nel 1789, i francesi non erano in miseria. I documenti più attendibili ci dimostrano, al contrario, che la ricchezza era notevolmente aumentata negli ultimi cinquant’anni, e che le condizioni materiali di tutte le classi sociali, tranne quelle della nobiltà rurale, erano sensibilmente migliorate.
regime corporativo, molte meno opprimente e generalizzato di quanto si dicesse, non aveva impedito la nascita e l’avvio della grande industria. (…) La meccanizzazione portata dall’Inghilterra favorisce la concentrazione di capitale, e già si disegna, almeno in alcuni dei suoi tratti permanenti, la fisionomia classica della Francia mineraria e manifatturiera. Nei Nord e alle falde del Massiccio Centrale si sfrutta il carbone e si creano officine metallurgiche (Le Creusot risale al 1781); a Lione sorgono le seterie; a Rouen e a Mulhouse si lavora il cotone; a Laval, il lino e la canapa; a Troyes nasce la maglieria; a Castres, a Sedan, a Abbeville e a Elbeuf si commercia la lana; in Lorena e nella bassa Alsazia, il ferro e il sale; a Marsiglia, il sapone; a Parigi nascono le concerie, l’industria del mobile e le industrie di beni di lusso. Ci si lamenta già della difficoltà di trovare mano d’opera qualificata e della scarsità di combustibile! (…)
Il personaggio moderno del grosso industriale che tratta milioni e comanda a centinaia di operai esiste, almeno in qualche caso, già prima della Rivoluzione (il re del ferro, Dietrich, dà lavoro a ottocento operai a Niederbronn), come esiste quello del finanziere, dell’intermediario, del sensale, del finanziatore e dell’agente dì cambio.
C’è una Borsa, ci sono banche, una Cassa di Sconto con cento milioni di capitale che emette biglietti simili a quelli dell’odierna Banque de France, un mercato a termine, un listino, l’aggiottaggio. Si specula sui cambi, sui titoli di Stato, sulle quote dell’Appalto generale che percepisce le imposte dirette, sulle azioni delle grandi compagnie: Compagnia delle Indie, Compagnia delle Acque e Compagnia delle Assicurazioni. (…) Dalla morte di Luigi XIV, il commercio con l’estero è più che quadruplicato. Nel 1788 tocca i 1.061 milioni, e questa enorme cifra non verrà più raggiunta prima del 1848. (…)
pp. 29-31
Ma qui si presenta un problema grave.
Questa brillante società ha le sue basi, com’è stato detto, sulla miseria? Sotto la schiera dorata dei borghesi arricchiti c’è una massa enorme di contadini affamati e senza risorse?
Molti l’hanno sostenuto, pronti a citare il celebre passo di La Bruyère: «Si vedono certi animali feroci, maschi e femmine… neri, lividi e tutti bruciati dal sole…», senza riflettere che questa pagina, vecchia di un secolo, non è che un pezzo di letteratura cesellato da un moralista amaro che, come tutti i suoi contemporanei, scambiava la deliziosa valle di Chevreuse per un deserto selvaggio.
Si è andati a scovare negli scritti di certi economisti descrizioni orrende della vita dei campi. Ma gli autori erano in genere uomini di studio che conoscevano la campagna solo dai libri, in un’epoca in cui era di moda celebrare l’ingenua virtù del lavoratore dei campi e versare torrenti di lacrime sulla scarsità di foraggio o sulla morìa dei montoni menino. Sono state citate testimonianze di viaggiatori, ma a fronte di ciascuna nota dolente si è potuto apporne un’altra che la contraddice. Come trarre d’altronde una conclusione generale da queste indicazioni fugaci? In un’ora di viaggio, si passa da una zona ridente ad una misera, da una terra grassa a un suolo ingrato. Basta un giorno di grandine per ridurre un villaggio alla disperazione. Un raccolto che si annuncia buono in giugno è misero in luglio. Una primavera di sole rimedia a un inverno durissimo. Tutto cambia da un anno all’altro. Tutto varia da una provincia all’altra. Sarebbe imprudente dare a fatti insignificanti strettamente localizzati, una portata che sorpassi i limiti del loro cantone.
E poi, va ricordato un fatto sostanziale e indiscutibile, e cioè che il sistema di imposte che gravava sul contadino rendeva l’APPARENZA della povertà una necessità quasi assoluta per lui.
L’imposta rurale per eccellenza, la taille, era un’imposta sul reddito suddivisa approssimativamente secondo i segni esteriori della ricchezza, da esattori scelti a turno tra gli stessi contadini.
Guai al contribuente esatto e sincero! Tutto il fardello ricadrà su di lui. Dovendo percepire una somma fissata globalmente in anticipo, desiderosi di sbarazzarsi al più presto del loro compito ingrato, felici di trovare un ingenuo in buona fede, una «pera» insomma, questi esattori «per forza» sono portati a raddoppiare o a triplicare la sua imposta, mentre trattano con maggior riguardo quelli da cui temono delle difficoltà: i furbi che hanno saputo dissimulare le proprie entrate, i tipacci che hanno fama di non lasciarsi intimidire, i querelanti incalliti che non temono le complicazioni e le grane.
E’ un dogma profondamente radicato nell’animo popolare che l’unico modo per non pagare per gli altri e non essere schiacciato da valutazioni ingiuste, consiste nel restringere le spese, apparire sprovvisti di mezzi ed esibire le forme della miseria più totale: «L’uomo più ricco del villaggio, scriveva nel 1709 il gran balivo dell’Ile de France, non oserebbe ora ammazzare un maiale che nottetempo, poiché, se ciò venisse fatto in pubblico, gli verrebbero aumentate le imposte». L’Assemblea provinciale del Berry constata anch’essa nel 1778 che il coltivatore, così «teme di mostrare le proprie risorse», e cioè il proprio reddito, che «ne rifiuta l’impiego in mobili, vestiti, cibo, in tutto ciò che cade sotto l’occhio degli altri…».
E’ il destino delle imposte arbitrarie, anche se modiche, di poter essere difficilmente riscosse. Il contribuente dell’Antico Regime è caparbio, astioso e dissimulatore in grado inimmaginabile. La sua cattiva volontà è senza limiti. Paga solo quando è ridotto agli estremi. Di solito, è in ritardo di due o tre anni. Chi ha del denaro nascosto, dice Boisguillebert, non si lascia strappare un soldo prima della quarantesima convocazione. Piuttosto di confessare il proprio benessere, pagando entro i termini, preferisce essere trascinato in giudizio e minacciato di pignoramento. Si assilla l’intendente con reclami e lagnanze. Si fa intercedere il signore, il giudice e il curato. Si geme, si piange, si protesta senza fine, e si fa a gara tra chi protesterà e piangerà più forte e più a lungo per non apparire più ricco né più arrendevole del vicino.
Un giorno Rousseau, che si era perso in montagna e vagava affamato, entra da un contadino e gli chiede di mangiare. L’altro rifiuta: non ha niente, gli hanno preso tutto. Non il minimo avanzo; cerchi pure, è tutto vuoto. Rousseau supplica, s’intestardisce. dice chi è. L’altro ascolta, si calma, si rassicura, apre tremando un nascondiglio, ne estrae con gran mistero pane, carne e vino, protestando che sarebbe un uomo rovinato «se si scoprisse che ha tali ricchezze».
La situazione dei contadini dell’Antico Regime è proprio questa: una grande ostentazione di miseria e, dietro a questa cappa di stracci, una vita comoda, spesso agiata e talvolta benestante.
Essi sono – c’è bisogno di dirlo? – uomini liberi. La servitù che si è conservata in quasi tutti i Paesi d’Europa non esiste più in Francia. Sopravvive solo, in forma meno dura, in qualche angolo del Giura e del Borbonese. Manca in questi casi la facoltà di fare testamento e vige quella che è detta la manomorta. Se il soggetto muore senza figli, viene considerato privo di eredi e i suoi beni sono incamerati dal signore. Il capitolo di Saint-Claude e l’abbazia di Luxeuil hanno ancora a quel tempo circa ventitremila persone soggette alla manomorta. Con un editto dell’8 agosto 1779, preparato da Necker, Luigi XVI abolisce le ultime tracce di servitù sulle terre della corona. Fu imitato da qualche proprietario terriero della Franca Contea, ma non dagli ecclesiastici.
I contadini sono per lo più, proprietari. Mentre in Inghilterra il regime delle recinzioni li risospinge nella dura condizione di servi o di giornalieri, in Francia essi approfittano del rincaro dei prodotti agricoli per migliorare la propria situazione. E’ certo che alla vigilia della Rivoluzione, salvo che nei dintorni immediati di Parigi e di Versailles, dove sono numerosi i castelli e le riserve di caccia, essi possiedono almeno metà del suolo. (…)
pp. 32-35
Ma questa proprietà contadina che va crescendo e migliorando è una vera proprietà nel senso pieno della parola, o piuttosto un semplice sistema di possedimento feudale, gravato da insopportabili servitù?
Il feudalesimo, che non esiste più come regime politico né come struttura sociale, sopravvive nel campo civile ed economico. Accanto al governo regio si vedono ancora i relitti dei sistemi che l’hanno preceduto e che, ormai spogliati delle proprie mansioni e avendo cessato di rendere gli antichi servigi, continuano ancora ad essere onerosi attraverso le imposte.
E’ certo, e del resto naturale e legittimo, che questi tributi, il cui motivo è ormai incomprensibile, fossero sopportati con insofferenza. E’ ovvio altresì che essi siano parsi tanto più vessatori quanto più si andava estendendo la proprietà contadina. Ma è assai dubbio che si trattasse addirittura di un peso insopportabile.
Innanzitutto, non dobbiamo lasciarci ingannare dall’incredibile numero di termini che servono a designare i balzelli feudali. Non c’è un altro settore della lingua altrettanto ricco di sinonimi.
Secondo i luoghi, secondo l’importanza del tributo e la natura delle terre, una medesima tassa poteva chiamarsi champari. terrage, agrier, agrière, parcière, tasque, tierçage, sixte, cinquain, vingtain. carpot. ecc. Ogni sostantivo ha sette o otto equivalenti e anche più, e, da questa infinità di appellativi, si è fatto presto a dedurre l’esistenza di un’imposizione fiscale multiforme e divorante, mentre in realtà tutto si riduceva a quattro o cinque canoni percepiti alcuni in natura, altri in denaro.
Le tasse in denaro erano state fissate una volta per tutte nel Medioevo. Come a dire che, in seguito alla svalutazione della moneta, esse sì erano ridotte a zero e non sussistevano che come pure formalità, dove poteva trovare soddisfazione la vanità del signore, ma certamente non la sua borsa.
Le tasse in natura erano più pesanti, ma venivano contestati i diritti a percepirle, e quindi, per negligenza o per paura delle difficoltà o per timore di provocare un’emigrazione, molti signori evitavano di esercitare con rigore i propri diritti. «Fate molto chiasso» prescriveva il duca di Cossé-Brissac ai suoi amministratori, «ma ricorrete alla costrizione solo nei casi urgenti e indispensabili.»
In molti posti. i contadini stavano correntemente venti o trent’anni senza pagare un soldo. In altri, avevano raggiunto degli accordi che riducevano di molto le vecchie tasse, oppure, comperando le terre, avevano automaticamente acquisito i diritti che gravavano su di esse. Centinaia di pedaggi erano stati soppressi dagli intendenti. Se il «censo» non aveva più ragion d’essere, le «banalità» erano ancora giustificate da una contropartita: la conduzione di un torchio, di un forno o di un mulino. La decima ecclesiastica implicava del pari che il clero si assumesse le spese del culto. educasse i bambini, assi-stesse i poveri e curasse i malati. (…)
In verità, il lato inaccettabile di questi residui feudali non sta nel loro peso, ma nel fatto stesso di essere resti d’altri tempi. con tutte le incertezze e i litigi che questo comporta: «Non c’è nient’altro di reale, nel feudalesimo, che i processi» diceva Le Trosne. E questo costituiva davvero un grosso problema. (…)
Questo infuriare di dispute non fece che aggravarsi nella seconda metà del secolo. Molti nobili che non risiedevano più sulle proprie terre o che desideravano liberarsi di queste beghe senza rinunciare a entrate regolari, avevano concesso in appalto la riscossione dei loro diritti a dei finanzieri o a dei commercianti che, non essendo legati agli abitanti del feudo da nessuna memoria familiare né da obblighi d’onore, si diedero semplicemente a ricavarne più denaro possibile. Spesso inoltre, non sentendosi più in possesso di documenti irrefutabili, in un’epoca in cui venivano sempre più attaccate le loro pretese, i signori si misero a far aggiornare, verificare e completare la registrazione delle proprie terre da giuristi specializzati in questo genere di lavoro, i feudisti, ai quali essi generalmente accordavano una percentuale sulle rendite recuperate. I feudisti riuscirono a ripristinare tributi caduti in disuso, ad elevare il tasso di quelli svalutati. E’ il fenomeno chiamato «reazione feudale». Proprio nel momento in cui il governo incoraggiava i pubblicisti a proporre l’abolizione degli antichi tributi, i contadini ebbero la sensazione che i signori tentassero di oberarli di nuove tasse e si ribellarono contro di essi con la disperazione di un naufrago che, già sul punto di toccare terra, incontra un ostacolo imprevisto.
Quest’odio era ingiusto. Di solito, i signorotti non erano gente cattiva. Arthur Young trova nel Rouergue certi piccoli nobili che raggiungono a stento una rendita di cinquecento lire. Un altro viaggiatore, Smollett, afferma che nella zona di Boulogne i gentiluomini non sono abbastanza ricchi da fare più di un pasto al giorno, minestra, bollito, pesce e insalata. Quando l’assemblea elettorale del Poitou si riunì nel 1789, sette nobili non furono in grado di pagarsi l’albergo. Raccontarono che le figlie facevano il pane in casa e portavano le mucche al pascolo. Sporchi e infangati come i loro contadini, ai «privilegiati» poveri non era rimasto, della loro signoria, che un albero genealogico, una piccionaia, un cane da caccia e una vecchia spada arrugginita. La loro ricchezza si era dissolta nella tempesta delle guerre di religione e il continuo aumento del costo della vita, provocato dall’afflusso dell’oro americano, non aveva permesso loro di riprendersi. Come il padre di Chateaubriand, che abitava con cinque domestici e due giumente in un castello che avrebbe potuto ospitare cento cavalieri col loro seguito e la muta di re Dagoberto, essi vivacchiavano miseramente nei loro manieri svuotati e cadenti. In genere, le poche terre rimaste erano ipotecate, e non è per capriccio che avevano affidato le proprie rendite ad affaristi che ne perseguivano il recupero con una durezza che non avrebbero mai saputo usare essi stessi. (…)
pp. 37-41
Insomma, per usare dei termini un po solenni, si può dire che nel 1789 la parte meno favorita della popolazione rurale era in virtuale rivolta contro la trasformazione capitalistica dell’agricoltura.
p. 43
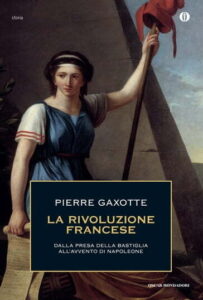
In questo Paese prospero, in questo Paese ricco, lo Stato era povero. Essendo ormai risaputo, questo paradosso non ci meraviglia più. Allora faceva scandalo: «Era straordinario» dice Besenval «vedere il Re prossimo alla bancarotta in un periodo in cui la Francia era così fiorente, la popolazione a un livello invidiabile, l’agricoltura e l’industria al massimo sviluppo, e Parigi che rigurgitava di denaro…».
A dire il vero, è impossibile tracciare esattamente il bilancio regio. La molteplicità dei bilanci speciali, il gran numero di casse particolari, l’intrico degli esercizi, la dispersione del controllo tra diversi tribunali, rendevano la contabilità difficile e complicata. Le esattorie e i monopoli non versavano integralmente al Tesoro le somme incassate: ne trattenevano al passaggio i diritti di esazione. Inoltre, per ridurre gli spostamenti del denaro liquido, era invalso l’uso di decurtare in loco certe entrate per saldare direttamente certe spese ordinarie, il cui ammontare quindi non appare più chiaramente. Le cifre fornite dai diversi controllori generali indicano degli scarti notevoli, e non ci sono validi motivi per sceglierne una piuttosto che un’altra. Il documento più esplicito è il «conto del Tesoro», redatto per il 1788 da quattro commissari nominati in virtù di un’ordinanza del Consiglio di febbraio. E’ servito come base per i calcoli di Braesch, in preparazione ai suoi studi sulla moneta e sulle finanze rivoluzionarie.
Le entrate sono la parte più chiara del bilancio: 504 milioni, dei quali 256 in imposte indirette. Per le uscite, nell’ipotesi più sfavorevole, si arriva a 629 milioni, e cioè a un deficit di 125 milioni per il 1789.
Di questi 629 milioni, 34 erano destinati ai palazzi reali e principeschi e 32 alle pensioni. E’ molto, è troppo. Di certo, somme notevoli venivano dissipate in favori, sinecure, gratifiche e donativi d’ogni tipo distribuiti a destra e a manca alla clientela brillante, ma famelica, che circondava il sovrano. Si sperperava per i cortigiani, come si sperpera oggi per gli elettori. (…) Era senz’altro possibile realizzare energici tagli; ma per quanto importanti, essi avrebbero apportato solo un modesto sollievo. Influendo su capitoli in definitiva secondari.
pp. 45-46
Dal cap. 4: LA CRISI DELL’AUTORITÀ
Prendiamo un esempio particolarmente tipico, quello di Malesherbes, direttore della Biblioteca. Contrariamente alla leggenda perpetuata nelle scuole, l’Enciclopedia godrà, da parte del potere, di una tolleranza quasi continua. Non è mai stata perseguita per articoli di carattere politico. Sono gli articoli religiosi (o anti-religiosi) che attirano su di essa i fulmini smorzati della Chiesa e della giustizia. In seguito alla censura, da parte della Sorbona, della tesi dell’abate di Prades, collaboratore del dizionario per la teologia, il Consigliere di Stato condanna i giudizi irriverenti dell’opera e dichiara «soppressi» i due primi volumi pubblicati; misura totalmente inefficace poiché essi sono già in mano ai sottoscrittori. Si prescrive inoltre di sequestrare i manoscritti dei prossimi volumi. Ma ecco come si svolsero le cose. E’ Madame de Vandeul, la figlia di Diderot, che ce lo racconta:
«Monsieur de Malesherbes preavvertì mio padre che il giorno dopo avrebbe dato l’ordine di portar via le sue carte e i suoi disegni. Quanto mi annunciate mi addolora terribilmente; non avrò il tempo di traslocare tutti i miei manoscritti, e poi non è facile trovare in ventiquattrore chi voglia incaricarsene. e che abbia una casa sicura.” Mandateli tutti a casa mia” rispose Malesherbes là non verranno a cercarli!” In effetti, mio padre fece trasportare metà del suo gabinetto da colui che ne aveva ordinato l’ispezione».
Il giorno stabilito Malesherbes, munito di un mandato, venne in gran pompa a sequestrare le carte di Diderot, e non le trovò. Questo tradimento non restò ignorato, poiché è menzionato nel «Journal» dell’avvocato Barbier. Ma di quale autorità può godere un governo servito così male? La pubblicazione dell’Encyclopédie prosegue, la tiratura aumenta, escono anche i due volumi «soppressi», e, nell’avvertenza al terzo, Diderot si dice «rassicurato dalla fiducia del pubblico ministero».
Durante la crisi del 1759, dopo l’attentato di Damiens e la pubblicazione di Esprit di Helvetius, il Parlamento se ne occupa. I sette volumi pubblicati vengono sottoposti all’esame di una commissione che non si riunirà mai, ne viene vietata la distribuzione, ma essa è già avvenuta; il Consiglio di Stato revoca il «privilège d’édition», il che non comporta la proibizione di vendere, ma il ritiro agli editori della proprietà commerciale. Viene loro comunque accordato ben presto un altro «privilegio» per i volumi di tavole e un permesso «tacito» per la stampa dei volumi di testo, a condizione che vengano registrati come stampati in Svizzera e distribuiti in blocco. Malesherbes si era fatto informatore di Helvétius. e in una sua lettera si trovano queste parole che sanno di complotto: «Dispensatemi dal firmare».
La sua duplicità è costante. A proposito di un libro di Voltaire che ha dovuto interdire e che deve venire sequestrato, scrive all’ispettore Hémery di cui teme la coscienza professionale (21 ottobre 1760): «Avrei desiderato non soltanto che gli esemplari non venissero sequestrati. ma che pervenissero a destinazione, provvedendo unicamente ad impedirne il pubblico smercio». Hémery risponde che tutto si svolgerà secondo i desideri di Malesherbes, purché i librai siano prudenti.
Con zelo ancora maggiore. Malesherbes fa da intermediario tra Rousseau e il suo libraio, lo consiglia per la redazione del contratto di Emile, gli invia per corriere speciale le bozze che avrebbe dovuto bloccare, e quando il ginevrino è in difficoltà col suo editore abituale. si intromette con solerzia per trovargliene un altro. Si reca persino a Montmorency per rassicurarlo, quando viene ritardata la pubblicazione del libro per il gran numero di correzioni.
Beninteso, sono i difensori dell’autorità che fanno le spese del suo liberalismo: Fréron non ha mai potuto ottenere l’autorizzazione per l’Année Iittéraire, e il suo giornale viene sospeso ogni momento perché ha osato criticare d’Alembert, Voltaire o persino Marmontel. Una volta viene biasimato per aver citato una frase dell’ordinanza del Consiglio del 1752 che condannava l’Encyclopédie. Nel 1758 sta per essere portato in tribunale per aver pubblicato il resoconto di un’opera ostile al l’Encyclopédie, e gli viene vietato di rispondere, sotto pena di azione giudiziaria, agli attacchi di cui è lui stesso l’oggetto. «Tutto è permesso contro Fréron» dice Brunetière «niente è permesso a Fréron» ed è quasi vero. Nel 1752, Malesherbes sopprime uno scritto di padre Geoffray ostile a Diderot. Nel 1754, egli fa criticare dal suo agente di Lione. Bourgelat, anch’egli collaboratore del l’Encyclopédie, un certo Padre Tholomas che si era azzardato a polemizzare contro la voce Collège del dizionario. Palissot e Gilbert saranno fatti segno alle stesse persecuzioni e Gilbert ne morirà. I filosofi gridavano alla tirannia. La vera tirannia era invece quella che essi esercitavano sulla letteratura.
I soci non erano affatto d’accordo su tutto. Voltaire scrive a d’Alemebrt che l’Encyclopédie è piena di espressioni declamatorie e di sciocchezze, che Le fils naturel di Diderot è brutto, che Diderot stesso è grossolano e scortese; ma di fronte al pubblico si fa blocco, si giura ammirazione reciproca, si proclama che l’Encyclopédie è un monumento immortale, il capolavoro dell’intelletto umano, lo strumento della più grande rivoluzione delle idee mai avvenuta: «E’ arrivata l’ora in cui tutti i filosofi devono unirsi… Fate corpo… Radunatevi, e sarete i padroni…»
Siccome però può essere pericoloso attaccare idee che ricevono appoggi autorevoli, si denigreranno gli individui; si fingerà di denunciarli non per quanto insegnano, ma per la pretesa indegnità della loro vita. E’ sempre Voltaire che scrive: «Dobbiamo screditare gli autori (che non la pensano come noi); dobbiamo abilmente infangare la loro condotta, trascinarli davanti al pubblico come persone viziose; dobbiamo presentare le loro azioni sotto una luce odiosa… Se ci mancano i fatti, dobbiamo farne supporre l’esistenza fingendo di tacere parte delle loro colpe. Tutto è permesso contro di essi… Deferiamoli al governo come nemici della religione e dell’autorità; incitiamo i magistrati a punirli». E raccomanda il segreto: «Colpite e nascondete la mano… I misteri di Mithra non devono essere divulgati…». Alla minima critica, alla minima replica, anche al più moderata, anche al più cortese, si grida alla calunnia, all’ingiuria, alla satira «atroce», alla personalità «infame»; ma poi si trattano gli avversari da infami, da birbanti, da sodomiti, da ingrati, da serpenti, da vipere, da pupazzi di melma, da furfanti, da evasi dalle prigioni, da ipocriti, da pazzi, da talpe della polizia…
pp. 63-64
Voltaire non cessava di fare appello all’autorità contro quelli che egli trattava da nemici, fossero essi Fréron, o Rousseau, o l’ispettore dell’Opéra o uno dei suoi librai. Ascoltiamo con che tono d’Alembert reclamava la protezione del potere per i suoi amici: «Apprendo, Signore, che nell’ultimo foglio di Fréron l’Encyclopédie viene definita un’opera scandalosa. So che questi fogli e i loro autori non hanno nessuna importanza, ma questo fatto non deve, a mio parere, autorizzare una simile licenza, né permettere a un censore di approvarla. Mancherei a me stesso e a tutti i miei colleghi se trascurassi di esprimervi il mio rammarico, pur risoluto a non perdere la calma se in seguito giustizia non ci venisse resa, per una mala sorte di cui non mi sentissi colpevole. Ho buon motivo, Signore, di sperare in Voi. Ne rispondono la vostra equità e l’onore che ho di essere vostro confratello…». Ci tocca vedere gli uomini del re correre in aiuto ai nemici del re! (…)
Moltiplichiamo questo esempio per mille e avremo un’idea di ciò che fu la politica interna della Francia tra il 1750 e il 1789: una progressiva abdicazione della monarchia.
pp. 78-82
Dal cap. 5: L’ANARCHIA
La notte dal 12 al 13 e la giornata del 13 luglio sono un incubo. Sembra di assistere alla decomposizione totale della società. I borghesi si barricano in casa. Le strade sono lasciate in balia della più vile e spaventosa plebaglia. Vengono forzati i magazzini. Gli elettori di secondo grado, riuniti all’Hôtel de Ville e terrorizzati dagli eventi, tentano di organizzare una milizia urbana alla quale si iscrivono i più noti cittadini, nobili in testa. Ma gli scatenati, che avevano saccheggiato il comando di polizia, si armano anch’essi e più in fretta. Svaligiano le botteghe degli armaioli, invadono la prigione della Force, liberano i detenuti che vanno ad ingrossare la loro torbida corrente.
Le bande si impadroniscono ovunque di picche e fucili. La mattina del 14 si gettano sull’Hôtel des Jnvalides, senza che Besenval, coi suoi tre reggimenti svizzeri e ottocento cavalieri alloggiati alla scuola militare, li contrasti minimamente. Un’ora più tardi, rifluiscono sulla Bastiglia. Il governatore de Launay avrebbe potuto difendersi senza fatica con la sua piccola guarnigione di svizzeri e di invalides, ma questo ripugnava alla sua filosofia. Parlamenta, ritira i cannoni, ostruisce le cannoniere, fa visitare la vecchia fortezza a un emissario dellHôtel de Ville e invita alla sua tavola due delegati degli assedianti. Queste attenzioni da uomo di mondo non impediscono a una torba furibonda, rinforzata da molti curiosi, di ammassarsi ai piedi delle mura, sparando ogni tanto e tentando di appiccare il fuoco ad una delle torri. Infine, due uomini armati di accetta, il carradore Tournay e il droghiere Pannetier, arrampicatisi sul tetto di un chiosco, riescono a spezzare le catene di un ponte levatoio che precipita con fracasso. Non è il ponte levatoio della fortezza. ma quello che dà accesso a un cortile esterno, su cui s’apre il piccolo alloggio del governatore. Viene invaso questo cortile, detto del governatorato, razziati i primi edifici, quattro cannoni vengono puntati sulla seconda porta. La guarnigione, dopo aver fatto segno agli assalitori di allontanarsi, si impaurisce. Istintivamente risponde al fuoco, ma perde la testa e, sentendosi ormai priva di un capo, costringe Launay ad arrendersi. Un sottufficiale al Comando delle guardie ribelli promette, sui proprio onore di soldato, che non sarebbe stato fatto del male a nessuno. Nonostante ciò Launay viene massacrato, e il suo corpo trascinato per le strade. Un garzone di cucina «che sapeva lavorare le carni», ne mozza la testa, la infila in cima a una picca, e, seguito da una muta selvaggia, la porta in giro fino a notte. Il maggiore, l’aiutante maggiore e un tenente vengono a loro volta uccisi. Due invalides sono impiccati, ad un altro viene mozzata una mano. La folla, ebbra di sangue, corre all’Hôtel de Ville. Il prevosto dei mercanti, Flesselles. va loro incontro. Attraversa la piace de Grève. Prima di arrivare alla Senna, viene ucciso e fatto a pezzi anche lui.
Nel frattempo, si esplorava la Bastiglia. Cerano sette prigionieri: quattro falsari. un giovane debosciato rinchiuso su richiesta della famiglia, e due pazzi. I falsari se la svignarono senza chiedere spiegazioni. Il discepolo del marchese de Sade fu ricevuto in gran pompa dalle società, dove pronunciò dei commoventi discorsi contro la Tirannia e il Dispotismo. I due pazzi, dapprima acclamati con uguale entusiasmo, furono condotti a Charenton il giorno dopo.
Vennero anche scoperte delle macchine sconosciute che Dussault avrebbe poi descritto all’Assemblea come orribili strumenti di tortura. Cera «un corsetto di ferro inventato per serrare tutte le articolazioni di un uomo e fissarlo in un’eterna immobilità»: si trattava di un’armatura medievale presa dal museo di armi antiche che si trovava nella vecchia fortezza. Cera pure «una macchina non meno distruttiva che venne esposta all’aperto, ma nessuno seppe indovinarne il nome o il vero uso»: era una pressa da stampa sequestrata nel 1786 a un certo François Lenormand. Furono infine trovate le tombe dei suicidi che non avevano potuto essere sotterrati nei cimiteri in terra consacrata: passarono per gli scheletri degli sventurati prigionieri giustiziati in segreto nelle celle. «I ministri sono stati imprevidenti,» tuonò Mirabeau «si sono dimenticati di mangiare le ossa».
La notizia dell’insurrezione giunse a Versailles durante la notte. L’assemblea aveva ancora la lucidità di capire che gli orrori successivi alla resa della fortezza avrebbero non solo giustificato i timori del re, ma anche avrebbero dato a Breteuil mille eccellenti ragioni per organizzare una repressione spietata, alla quale il parlamento avrebbe dato con gioia forma legale. Un vero re avrebbe agito ancor più rapidamente. Luigi XV sarebbe balzato in sella a qualsiasi ora, sarebbe entrato a Parigi con tutti gli uomini atti a combattere e, spuntato il giorno, sarebbe stato freneticamente acclamato da una borghesia che, dopo aver tanto protestato, temeva ormai per la propria vita e per i propri beni. Avrebbe fatto impiccare una dozzina di assassini alle finestre dellHôtel de Ville, rimesso una guarnigione alla Bastiglia, e sarebbe rientrato a Versailles ad accogliere le dichiarazioni dobbedienza di un’Assemblea umile e sottomessa. Come scrive Soreau, non sarebbe bastato questo per risolvere i difficili problemi che restavano da affrontare. Ma il re avrebbe potuto risolverli tramite la monarchia. I capi della sinistra conoscevano Luigi XVI, e si adoperarono senza indugi a trasformare in atti eroici i crimini di cui volevano coprire gli istigatori. La leggenda della Bastiglia nacque quattro ore dopo il fatto. Il 15, i borghesi parigini che si svegliavano vergognosi e inquieti per aver lasciato campo libero agli assassini, appresero che non cera mai stato nessun assassinio e che il popolo intero si era sollevato in difesa della Libertà, e che le uccisioni di Launay e di Flesselles erano la manifestazione sublime della sua giustizia sovrana.
pp. 127-130
2) Riflessioni sulla base della lettura del libro di François Furet, Critica della Rivoluzione francese, Roma-Bari, Laterza 1987 (titolo originale, più significativo: Penser la Révolution)
La Rivoluzione è caratterizzata da una situazione in cui il potere appare a tutti vacante, libero, intellettualmente e praticamente, al contrario che nella società del passato, in cui da tempo immemorabile era occupato dal re, non era mai libero, se non a prezzo di un atto eretico e criminale, ed era d’altronde padrone della società e arbitro dei suoi fini. Ed eccolo a un tratto non solo disponibile, ma addirittura proprietà della società, che deve prenderne possesso e piegarlo alle proprie leggi; e poiché è anche il grande colpevole dell’Ancien Régime, il luogo dell’arbitrio e del dispotismo, la società rivoluzionaria esorcizza la maledizione che gli pesa addosso mediante una sacralizzazione opposta a quella dell’Ancien Régime: il popolo è il potere. Ma si condanna di conseguenza a far esistere questa equazione soltanto attraverso l’opinione. La parola subentra al potere come unica garanzia che il potere appartiene soltanto al popolo, ovvero a nessuno; e contrariamente al potere, che ha la malattia del segreto, la parola è pubblica, e quindi soggetta a sua volta al controllo del popolo.
(…) Divenuta potere, l’opinione dev’essere tutt’uno col popolo: la parola non deve più nascondere degli intrighi, ma riflettere dei valori, come uno specchio. In questo delirio collettivo sul potere che regola ormai le battaglie politiche della Rivoluzione, la rappresentanza è esclusa o costantemente tenuta d’occhio; come in Rousseau, il popolo non può, per definizione, cedere i propri diritti a interessi particolari, giacché la sua libertà cesserebbe all’istante. La legittimità (e la vittoria) appartengono quindi a coloro che rappresentano simbolicamente la sua volontà e riescono a monopolizzarne l’istanza. Inevitabile paradosso, la democrazia diretta sostituisce alla rappresentanza elettorale un sistema di equivalenze astratte, mediante il quale la volontà popolare coincide sempre col potere, e l’azione è perfettamente identica al suo principio di legittimità.
Se la Rivoluzione francese vive così, nella sua pratica politica, le contraddizioni teoriche della democrazia, è perché dà origine a un mondo in cui le rappresentanze del potere sono il centro dell’azione, e il circuito semiotico è padrone assoluto della politica. Si tratta di sapere chi rappresenta il popolo, o l’uguaglianza o la nazione: è la capacità di conquistare questa posizione simbolica. e di conservarla, che definisce la vittoria. (…)
Poiché il popolo è l’unico che ha il diritto di governare, o che, se non può farlo, deve almeno rifondare costantemente l’autorità pubblica, il potere appartiene a chi parla in suo nome: appartiene cioè alla parola – giacché la parola, pubblica per natura, è lo strumento che svela ciò che vorrebbe restare occulto, e quindi nefasto – ed è al tempo stesso il costante obiettivo delle parole, sole qualificate per appropriarsene ma rivali nella conquista di un luogo evanescente e primitivo qual è la volontà popolare. Alla lotta degli interessi per il potere, la Rivoluzione sostituisce una competizione dei discorsi per il monopolio della legittimità il « mestiere » dei suoi leader non è l’azione, ma l’interpretazione dell’azione. (…)
Di questo potere ci sono gli specialisti gli esperti, quelli cioè che lo producono e che sono pertanto i detentori della sua legittimità e del suo significato, i militanti rivoluzionari delle sezioni e dei club.
L’attività rivoluzionaria per eccellenza consiste nella produzione della parola massimalista attraverso assemblee unanimi miticamente investite della volontà generale.
pp. 56-59
L’idea centrale di questo credo è naturalmente l’uguaglianza, vissuta come l’opposto dell’antica società e concepita come scopo e condizione del nuovo patto sociale. Quest’idea tuttavia non produce direttamente l’energia rivoluzionaria, che passa invece attraverso un relais ad essa strettamente abbinato, giacché è il principio contrario che dà origine al conflitto e giustifica la violenza: il complotto aristocratico.
Enumerate gli usi e le accezioni dell’idea di complotto nell’ideologia rivoluzionaria sarebbe un’impresa interminabile: si tratta infatti di una nozione fondamentale e multiforme, in base alla quale si concepisce e organizza l’azione; è questa nozione che mobilita l’insieme di convinzioni e credenze caratteristico degli uomini di quel tempo, e che inoltre consente ogni volta l’interpretazione-giustificazione di quanto è accaduto. La vediamo funzionare in questi due sensi sin dai primi avvenimenti della Rivoluzione francese, e invadere, unificandoli, tutti i livelli di cultura: i contadini della Grande paura corrono alle armi contro il complotto dei briganti, i parigini prendono la Bastiglia e successivamente il castello di Versailles per difendersi dal complotto di corte, i deputati legittimano l’insurrezione invocando i complotti che ha sventato. L’idea è fatta apposta per sedurre una sensibilità morale a sfondo religioso, usa a considerare il male come prodotto da forze occulte, e al tempo stesso la nuova convinzione democratica secondo cui la volontà generale, o nazionale, non può essere contrastata dall’opposizione pubblica degli interessi particolari; e, soprattutto, si adatta perfettamente alle configurazioni della coscienza rivoluzionaria. Essa opera quello stravolgimento dello schema causale per cui qualunque fatto storico è riconducibile a un’intenzione e a una volontà soggettiva; garantisce l’enormità del delitto, poiché esso è inconfessabile, e la funzione salutare della sua eliminazione; rende superfluo individuarne gli autori e precisarne le trame, perché è indeterminata quanto ai suoi attori, che sono occulti, e quanto ai suoi fini, che sono astratti. Il complotto, insomma, è per la Rivoluzione il solo avversario a sua esatta misura, perché è tagliato sul suo modello: è astratto, onnipresente come essa, ma occulto, mentre essa è pubblica; perverso, mentre essa è buona, nefasto, mentre essa porta la felicità sociale; è il suo negativo, il suo opposto, il suo antiprincipio.
L’idea di complotto è tagliato nella stessa stoffa della coscienza rivoluzionaria perché è una componente essenziale del sostrato medesimo di tale coscienza: un discorso immaginario sul potere. (…) Al pari della volontà del popolo, il complotto è un delirio sul potere, e insieme costituiscono le due facce di ciò che potremmo chiamare l’immaginario democratico del potere.
pp. 62-63
Robespierre è un profeta che crede in tutto quello che dice e che esprime tutto quello che dice nel linguaggio della Rivoluzione: nessun altro contemporaneo ha interiorizzato come lui la codificazione ideologica del fenomeno rivoluzionario. Il che significa che per lui non c’è alcuna differenza fra la lotta per il potere e la lotta per gli interessi del popolo, che coincidono per definizione. (…) Il problema pertanto non sta nel fatto ch’egli abbia avuto un’anima tenera e un cuore pietoso, o al contrario la passione della vendetta. Il rapporto di Robespierre col Terrore non è di carattere psicologico. Ciò che alimenta la ghigliottina è la sua predicazione sui buoni e i cattivi, ed è il tremendo potere di definite il popolo conferitogli da questa predicazione che riempie le prigioni.(…)
Ci sono due modi, in fondo, di non capir niente del personaggio storico di Robespierre, quello di detestarlo come individuo e quello, al contrario, di voler troppo innalzarlo. Indubbiamente è assurdo voler fare dell’avvocato di Arras un mostro usurpatore, un demagogo dell’uomo da tavolino, un sanguinano del moderato, un dittatore del sincero democratico. Ma che cosa si spiega del suo destino provando ch’era davvero incorruttibile? Il controsenso comune alle due scuole sta nel fatto di attribuire alle caratteristiche psicologiche dell’uomo il ruolo storico cui lo portarono gli eventi e il linguaggio che gli ispirarono. Ciò che fa di Robespierre una figura immortale non è il fatto d’aver avuto in pugno per pochi mesi la Rivoluzione, ma che la Rivoluzione parla con lui il suo linguaggio più tragico e puro.
pp. 68-70
3) Riflessioni sulla base della lettura del libro di Augustin Cochin, Lo spirito del giacobinismo, Milano, Bompiani 1989
Dall’Introduzione di Jean Baechler
1. La produzione dell’homo ideologicus
Homo ideologicus non è il risultato né di una mutazione casuale, di un incrocio accidentale, né di una manipolazione genetica: esso è il prodotto normale, automatico, non voluto, di una forma specifica di associazione che Cochin chiama la società di pensiero. Qui sta l’intuizione centrale di Cochin. L’ideologo non è mosso dalle passioni né spinto dagli interessi, i suoi atti e il suo modo di essere non sono il risultato di nessuna deliberazione. E’ ciò che e, di conseguenza, fa ciò che fa, non per perversione o per egoismo, ma perché è passato attraverso un’impastatrice del tutto particolare, sebbene perfettamente indolore e persino innocente. Che cosa sono in effetti, queste società di pensiero al momento della loro prima comparsa, intorno al 1750? Sono piccoli gruppi disseminati per tutta la Francia, in cui si conversa e in cui ci si riunisce solo per conversare. Conversare di che? Di tutto e di nulla, di scienza, di agricoltura, di economia, di politica, di letteratura, in breve di tutto ciò che vien chiamato filosofia dei lumi”. Conversare ha senso soprattutto in relazione a ciò che esclude, cioè l’azione. Queste piccole società e queste accademie non aspirano affatto all’azione. Non ci si riunisce per complottare, ci si riunisce, ancora una volta, per conversare. Ogni settimana, per qualche ora, i partecipanti – principalmente gli avvocati e coloro che gravitano intorno a essi, in genere tutti quelli che hanno a che fare con il diritto e che si basano sull’arte della parola, i piccoli lumi locali come i medici e il clero – lasciano i loro impegni quotidiani dove agiscono come tutti, cioè razionalmente e in contatto con la realtà e dove, quando occorre, parlano ma non conversano, per giocare al cittadino e al filosofo e gustare l’ebbrezza di rifondare il mondo senza la fatica di farlo davvero, visto che ci si limita a conversarne.
Questo specifico orientamento implica conseguenze inevitabili e, almeno all’inizio, impercettibili. La prima è legata al fatto che la realtà non è mai presa in considerazione, perché non deve esserlo. Questo non significa che si possa dire qualsiasi cosa, visto che si tratta spesso di gente colta e intelligente che non sopporterebbe sciocchezze troppo evidenti. No, la conseguenza è che le idee diventano idee pure. Non ci si occupa più, per esempio, delle libertà francesi, legare a una storia secolare, fondate su autonomie, privilegi, finanche usurpazioni, ma animate comunque dal sangue della vita che trascina con sé insieme all’ossigeno anche le impurità. Si conversa della Libertà con la L maiuscola, una pura astrazione con la quale si può entrare in contatto solo attraverso le parole, non nella realtà. Allo stesso modo, ci si disinteressa degli uomini e ci si appassiona per l’Uomo, si disprezza il popolo per esaltare il Popolo, e così via. La caricatura non sarebbe troppo calcata se si dicesse che la società di pensiero è una macchina per produrre maiuscole. La conseguenza è ineluttabile, anche se non è stata voluta da nessuno. Al contrario, come si dirà poi, se i partecipanti avessero potuto prevedere le conseguenze ne sarebbero stati sinceramente inorriditi. Il lato patetico della questione è che la causa del disastro è un fatto insignificante e innocente come la conversazione. Se si trattasse di difendere ed estendere le libertà, come hanno fatto gli inglesi nel secolo precedente e come continuano a fare nel secolo di cui parliamo, o come si apprestano a fare gli americani, bisognerebbe agire, entrare in contatto con la realtà, con la sua complessità, coi suoi ostacoli, i suoi inganni, i suoi tradimenti. Del Popolo, della Libertà, dell’Uguaglianza, dell’Umanità si può forse parlare nei discorsi ufficiali e nei programmi elettorali, non si può certo usarli nella lotta politica reale. Al contrario, finché ci si limita a conversare, l’ordine è rovesciato: non si incontrano che maiuscole e non si ha a che fare con la realtà.
Una seconda conseguenza dipende dal fatto che la conversazione di queste società non è la stessa dei salotti. In un salotto si deve brillare, e dunque distinguersi. Certo, su un fondo di identità determinato dalle regole del gioco accettate. Ma si tratta comunque di distinguersi. Qui, al contrario, si conversa per scoprire la verità, sia sul modo migliore di coltivare le patate sia sulle vie garantite della felicità universale. Ora, la verità è il contrario dell’errore, come il Bene è il contrario del Male. Ogni partecipante arde dunque dal desiderio di abbandonare l’errore per trovare la verità che non può essere che una. In una parola, una società di pensiero tende all’unanimità e non può fare a meno di considerare come un crimine ogni dissidenza e persino ogni dissenso. Un’associazione di matematici che discuta di matematica non potrebbe tollerare uno che sostiene che due più due fa cinque, lo tratterebbe da pazzo o da provocatore. Qui è lo stesso, con l’aggravante che si conversa di problemi vitali, di morale, di politica, di economia, sicché il dissenso verrà vissuto come perversione piuttosto che come malattia. Ebbene, se si cura la malattia, il Male lo si annienta”, come si dirà sotto il Terrore. Ma non siamo ancora a questo punto, dato che per annientare bisogna essere al potere. Intanto, la ricerca della verità, nel mondo reale, si basa anche su delle realtà, cioè su esperienze e difficoltà superate. Non è conversando che si risolve un problema di fisica, o di economia, ma formulando ipotesi e confrontandole con la realtà. La verità, direbbe oggi un popperiano, non è che una proposizione non ancora rifiutata. Essa non appare affatto sotto questo aspetto in una società di pensiero: la verità, qui, è la proposizione su cui tutti quelli che partecipano alla conversazione sono d’accordo. La verità è questione di opinione, non di esperienza. Ogni pensiero, ogni sforzo intellettuale qui esistono soltanto se oggetto di consenso. E’ l’opinione che costituisce l’essere. E’ reale ciò che gli altri vedono, vero ciò che dicono, bene ciò che approvano. Così l’ordine naturale è rovesciato, l’opinione qui è causa e non, come nella vita reale, effetto. L’apparire sostituisce l’essere, il dire, il fare” (p. 46). 0 ancora: Il fine è spostato: quello che conta ormai è l’idea distinta, quella che si autogiustifica verbalmente, non l’idea feconda che si verifica. O piuttosto è solo la discussione, l’opinione verbale, e non più la prova, quella che verifica e giudica” (p. 47). Dal momento in cui il vero sorge nel punto in cui i conversatori si trovano d’accordo, ci si può lasciare andare a tutti i piani, e di fatto non è possibile evitarlo. Basta in effetti che un progetto sia coerente, cioè che non contenga contraddizioni logiche, e che venga accettato dai propri pari, perché passi ipso facto per realizzabile. Nessuna obiezione può essere opposta dalla realtà, dal momento che la realtà è assente, né da argomenti tratti dall’esperienza, dal momento che si fonda un mondo nuovo; né da riferimenti alla natura umana conosciuta, giacché l’Uomo non ha natura, se non buona e corrotta dalle cattive compagnie. Il solo rischio per un piano è di imbattersi in un secondo piano, concepito nelle stesse condizioni, ma divergente. In questo caso l’unica soluzione è l’anatema reciproco, sicché le società di pensiero sono necessariamente sottoposte alle convulsioni e alla scissi-parità, e homo ideologicus all’epurazione. Finché le società non sono al potere, questi conflitti si limitano a ferire le vanità; al potere, faranno cadere le teste.
La terza conseguenza è probabilmente la più importante. Assai presto, le società di pensiero vengono sottoposte a un meccanismo di selezione, In effetti non tutti hanno le doti necessarie a diventare homo ideologicus. Ci vogliono una certa leggerezza di spirito, gregarismo, ignoranza… assai largamente diffusi ma non universali. Gli individui più competenti, più profondi, più colti si elimineranno assai presto da soli per incapacità di sopportare la conversazione degli imbecilli. Resteranno solo gli spiriti più conformi alla logica dell’istituzione: i giovani che mancano d’esperienza e possono illudersi che tutto sia possibile; gli uomini di legge, di penna e di parola, che amano parlare e vivono già in un mondo a parte; gli scettici, che sono vuoti; i vanitosi, giacché la conquista dell’opinione altrui corrisponde alla loro particolare passione, i superficiali perché sono superficiali. Avviene dunque una selezione negativa, puramente meccanica: Qui non c’è bisogno di un padrone che designi o di un dogma che escluda. Basta la forza delle cose, i più leggeri saliranno per conto loro in alto, i più pesanti e i più carichi di realtà cadranno a terra. E’ questione di procedimento, non di scelta” (p. 48). La selezione determina un fenomeno di polarizzazione. Ritrovandosi soli tra loro, i giovani, i vanitosi saranno ancor più distaccati dalla realtà, dal momento che non possono più avvalersi delle obiezioni di uomini solidi ed esperti. Ci si dirige inesorabilmente verso l’avvento di un certo tipo intellettuale e morale che nessuno ha previsto, che ognuno deplorerebbe e che tutti preparano” (p. 48). Ancora una volta le conseguenze non sono volute da nessuno ma risultano dalla logica della situazione che indica l’orientamento generale e seleziona gli attori capaci di collocarsi in tale prospettiva e attualizzare la logica con la loro azione. Un secondo corollario non è notato da Cochin ma è implicito nella sua riflessione. Dal momento in cui la selezione opera la separazione tra uomini e ideologi è inevitabile che i primi abbiano sempre la meglio nel campo del pensiero e della scienza, e perdano regolarmente quando si tratta di battersi. Sul primo punto, la loro superiorità deriva dalla loro capacità di piegarsi all’esperienza (…). Sul secondo punto, l’inferiorità degli uomini dipende per l’appunto dalla loro ripugnanza a coalizzarsi: se ne sono andati proprio perché non potevano sopportare ne Bouvard né Pécuchet. Se dunque le cose arrivano al punto in cui la critica cede la parola alle armi, gli ideologi vincono e si impadroniscono del potere. Da questo momento essi possono uccidere e far regredire il pensiero. (…)
Una quarta e ultima conseguenza viene notata, ma non spiegata, da Cochin. Le società si costituiscono necessariamente in una rete che tende a rinserrare le sue maglie su tutto il paese e persino sul mondo esterno. Bisogna innanzitutto notare che il grado di astrazione e d’irrealtà raggiunto dall’ideologia la rende adatta a venire accolta ovunque: la Libertà può sedurre un angioino come un cinese o un irochese, mentre le libertà francesi, o inglesi o ateniesi, non sono trasferibili. Spetta a ogni popolo ritrovare, attraverso i propri sforzi, le proprie lotte e le proprie sconfitte, la sua particolare interpretazione della libertà. Questa possibilità di universalità è colta in quanto corrisponde a un bisogno. Dal momento in cui ci si sente capaci, in seguito a una chiacchierata, di riformare una provincia, ci si sente subito altrettanto capaci di riformare l’universo. Anzi, si giunge a non far più distinzioni tra le province e l’universo, visto che si vive nel mondo delle maiuscole che ignorano i particolarismi. L’ideologia è per propria natura universale e gli ideologi sono in contatto diretto con l’universo che essi stessi hanno prodotto. Una società di pensiero non si richiude dunque su se stessa come una setta. Al contrario, prova il bisogno di prendere contatto con le società sorelle: e tra le società si stabiliscono delle corrispondenze, ci si incontra e ci si invita in occasione di spostamenti per ragioni di lavoro, e così via. Insistiamo ancora una volta sul fatto che non c’è nessun bisogno di supporre un coordinamento volontario e organizzato da un centro che peraltro non è affatto escluso, come proverà il 1793 – perché una consegna, una parola d’ordine o anche soltanto una nuova opinione si diffondano per tutta la rete alla velocità consentita dalle tecniche di comunicazione. Come il processo di selezione e di polarizzazione si è effettuato in ciascuna società locale, così tutte le società si ritrovano popolate da un personale omogeneo, altamente conduttore per le stesse idee. L’unanimità nazionale, e persino internazionale, viene così ottenuta meccanicamente senza costrizioni né volontà deliberata. Il risultato è tanto più importante in quanto, per le stesse ragioni, ma rovesciate, il resto della società non costituisce nessuna rete, ma si trova divisa in una miriade di unità separate. Di conseguenza, in caso di aperto conflitto tra le società e la società, è inevitabile che siano le prime a vincere, per quanto nulle e incredibilmente minoritarie; una coalizione ha sempre la meglio su nemici divisi in unità ognuna delle quali è di forza minore a quella della coalizione. Questa superiorità si nota in particolare nel fenomeno della claque, così nitidamente individuato da Cochin: (Il filosofismo) è in grado, grazie all’unione senza maestri né dogmi delle società, di mettere in moto un’opinione falsa, più appassionata, più unanime, più universale di quella vera. Il pubblico conclude che è dunque più vera” (p. 54). La claque, vale a dire il personale militante delle società, è così ben addestrata che diventa sincera, così ben disseminata nella sala da ignorare se stessa, mentre ognuno degli spettatori la scambia per il pubblico. Essa imita l’ampiezza e l’unità di un grande movimento di opinione, pur senza perdere la coesione e la sapienza della cabala” (p. 54). Ognuno si sottomette a ciò che crede approvato da tutti” (p. 54). E’ così che senza talento, senza rischi, senza intrighi pericolosi e grossolani, in virtù soltanto della propria unione, la Piccola Città fa parlare a piacimento l’opinione della grande, decide delle reputazioni e fa applaudire, se sono suoi, autori noiosi e libri cattivi” (p. 54).
Così, un punto di partenza insignificante e innocente conduce alla edificazione di una città delle nuvole – il riferimento ad Aristofane è di Cochin – non già al di sopra della città reale, ma mescolata a essa, come il virus invade un organismo sano. Una minoranza insignificante composta di personaggi insignificanti si trova in grado di pesare sui destini della maggioranza, ingannandola e manovrandola. Che cosa vuole? Inevitabilmente, in base a ciò che abbiamo detto, essa non può che tendere a una rifondazione generale della società secondo i principi astratti prodotti dalla conversazione. E’ come dire che non ci si può accontentare indefinitamente di conversare, a un certo punto si giunge a voler agire e ci si convince che si è in grado di agire per la maggior felicità di tutti. Perciò bisogna cominciare con l’occupare le posizioni strategiche a partire dalle quali si potrà procedere alla rifondazione: bisogna impadronirsi del potere politico.
2. Homo ideologicus alla conquista del potere
Come è stato possibile che questo partito di sognatori e di chiacchieroni sia riuscito a vincere e a conquistare la maggioranza agli Stati generali del 1789? Come è stato possibile, nonostante l’evidente limitatezza dei suoi effettivi, rispetto all’insieme della popolazione e nonostante lo scontro con una società in cui non mancavano i massi di granito” capaci di garantirne la stabilità? In una parola, come fu possibile la Rivoluzione? E’ una domanda che verosimilmente non avrà mai una risposta del tutto soddisfacente. Ogni evento, così come ogni vita, non può essere ricondotto ai fattori che lo hanno generato. C’è sempre una zona irriducibile alla spiegazione, ed è quella che corrisponde alla parte di libertà o di creazione che implica ogni azione umana, individuale o collettiva. Ma, fatte queste riserve, si deve dire senza esitazione che Cochin si è spinto più in là di chiunque altro nell’interpretazione della rottura rivoluzionaria. La sua forza consiste innanzitutto nel rifiuto di considerare l’evento come se fosse iscritto nei libri del destino, giacché ogni spiegazione fondata sul convincimento, implicito o esplicito, che la Rivoluzione fosse altrettanto inevitabile dell’avvicendarsi delle stagioni, si basa su una filosofia della storia che evita il problema. Per Cochin dunque, la Rivoluzione risulta dalla combinazione di tre fattori: la strategia e le tattiche del partito filosofico”; la novità del fenomeno, che non ha permesso alla società e al potere di difendersi in tempo e con efficacia: la società si è lasciata sorprendere giacché nessuno poteva subodorare il Terrore; infine, un regolamento elettorale contraddittorio nel principio stesso su cui si fondava, che dava automaticamente la maggioranza agli ideologi. Con spiegazioni di questo tipo, si resta esterrefatti o quanto meno perplessi: non più marce predestinate del Popolo verso la Libertà, non più il sollevamento unanime della nazione contro l’oppressione, non più lotta di classe o rapporti di produzione in contraddizione con le forze produttive. Invece, qualcosa di mediocre, da un lato capacità mediocri, dall’altro ignoranza e negligenza, e un ministro, Necker, complice o non molto astuto. Cochin, a ogni modo, è nel vero. Il secondo e il terzo saggio dovrebbero convincercene.
La campagna del Terzo stato dal novembre 1788 al marzo 1789, nasconde un mistero inquietante. Non si vedono capi, né quadri, né programmi, non c’è traccia di partiti nel senso attuale del termine. Il popolo sembra avere tutte le iniziative e tutti i poteri. Ebbene, questi milioni di francesi che per l’immensa maggioranza non avevano mai fatto politica né partecipato a una campagna elettorale, sembrano sviluppare manovre che fanno pensare a un’impeccabile concertazione. Nel novembre 1788 tutta la Francia reclama il raddoppio della rappresentanza del Terzo stato; nel gennaio 1789 è unanime nell’esigere il voto individuale; in marzo redige dei cahiers de doléances che ovunque sembrano usciti dalla stessa penna. Soltanto uno studio minuzioso condotto a livello locale consentiva di dissipare il mistero. L’analisi di Cochin è sufficientemente esplicita perché io mi dispensi dal parafrasarla. Mi limiterò dunque a utilizzarne le articolazioni principali, quelle di applicazione generale.
Il conflitto tra il re e i parlamenti si era concluso con la vittoria di questi ultimi, giacché il re, non contento di rinunciare a sopprimerli, aveva revocato Brienne e convocato gli Stati generali. Immediatamente si manifestano tre rivendicazioni del partito ideologico: elezione dei deputati per scrutinio, e non per designazione da parte degli ordini; raddoppio del Terzo; voto individuale. L’obiettivo era evidente: distruggere i due primi ordini, nobiltà e clero, almeno in quanto forze politiche; di conseguenza, imporre al re quella che più tardi si chiamerà una monarchia costituzionale, in cui la realtà del potere sarà nelle mani del Terzo, cioè dei suoi rappresentanti, cioè del partito ideologico. Il parlamento si oppone a queste tre rivendicazioni, considerandole in contrasto con leggi secolari. E su questo punto il partito ottiene una vittoria senza quasi combattere. In effetti, su consiglio di Necker, il re decide di consultare i notabili. Errore fatale, non tanto perché pareva mettere in dubbio la legittimità delle pratiche tradizionali, quanto per la debolezza che rivelava. Un potere che lascia credere di poter essere vinto lo è già a metà. In novembre si diffonde la voce che i notabili hanno votato contro il raddoppio del Terzo. Subito Versailles viene inondata di suppliche giunte da ogni parte della Francia, redatte negli stessi termini, che chiedono tutte la stessa cosa. E’ il primo episodio di una campagna permanente che condurrà alla presa della Bastiglia.
Una volta fissata la strategia, quella di far pressione sul re perché ceda all’unanimità, occorreva precisare la tattica. E questa sarà quella della macchia dolio, o dell’investire progressivamente. A Digione gli ideologi sono poco numerosi, appena una ventina di personaggi attivi. Il partito è composto da medici, da chirurghi, soprattutto da uomini di legge, avvocati, procuratori, notai, oscuri piccolo-borghesi, parecchi dei quali si faranno eleggere deputati del Terzo agli Stati, senza farsi un nome” (pag. 58). Gli agitatori cominciano con l’impadronirsi dell’ordine degli avvocati. Poi si rivolgono agli altri corpi e corporazioni della città, procedendo dai più ai meno sicuri: medici, procuratori del baliato, notai, procuratori al parlamento, procuratori alla corte dei conti, conciatori, scrivani, farmacisti, orologiai, speziali, parrucchieri. A ogni nuova vittoria la palla di neve si ingrossa, più che proporzionalmente, in virtù dell’argomento decisivo: Voi siete i soli a non…” Quando una ventina di corporazioni su cinquanta è conquistata, si riunisce finalmente l’organo dei magistrati della municipalità, che viene anch’esso conquistato, anche con mezzi fraudolenti.
Da questo momento gli obiettivi del partito diventano il voto liberamente espresso dal Terzo della città di Lione”, proposto a esempio alle altre città della provincia. La campagna, in effetti, si estende a tutta la provincia, in base alla stessa tattica dell’investimento progressivo dal più al meno sicuro, e dell’argomento costante: Voi siete i soli a non esservi ancora uniti al Terzo unanime”. Perché la gente tollera tutto questo? Semplicemente perché non ha nessuna ragione di opporsi alle tre rivendicazioni, sia per ignoranza, sia per l’evidente interesse del roturier. Quanto alle autorità locali, il sindaco, gli scabini, qualche notabile, essi sono indecisi e disorientati, privi di qualsiasi direttiva.
Almeno i privilegiati avrebbero dovuto intervenire apertamente, visto che era in gioco la loro sopravvivenza. E di fatto c’è un partito nobiliare che si forma e suona l’allarme. Ma è del tutto minoritario e, fatto ancor più curioso, parla lo stesso linguaggio del suo avversario. In effetti, è formato da uomini di legge che all’inizio dell’anno hanno condotto la campagna per il parlamento d’accordo con gli agitatori del Terzo. In altri termini, è gente che conosce il suo avversario e sa di che cosa è capace. Le due fazioni si affrontano in una battaglia che è soltanto la prima delle epurazioni che segneranno la Rivoluzione fino al 9 Termidoro. Il partito parlamentare fu battuto, per la buona ragione che i nobili e l’alto clero non lo sostennero, e non lo sostennero proprio per le battaglie del maggio-giugno 1788, che li presentano come personaggi un po loschi, niente affatto raccomandabili Finalmente, il 1 gennaio 1789 il re, sollecitato da Necker, pubblica una decisione del 27 dicembre che accorda il raddoppio del Terzo stato. Trascuriamo pure il seguito della storia, giacché a questo punto abbiamo già l’essenziale della spiegazione: una minoranza infima, ma risoluta in quanto ha davanti a sé un obiettivo chiaro, può vincere a condizione di poter raccogliere le masse attorno a rivendicazioni anodine o palesemente vantaggiose, e di non avere contro di sé altro che avversari divisi o screditati. Certo, non sono condizioni facili da realizzare. Ma nel 1788-89 non si disponeva di nessun precedente e non si potevano prevedere le conseguenze. Dal 1794 e, in definitiva, fino al 1914, il ricordo e la paura resero più vigilanti.
L’ordinanza reale del 24 gennaio 1789, che regolava l’elezione dei deputati agli Stati generali, è un esempio da manuale delle assurdità cui conduce l’ideologia distaccata dalla realtà, e delle catastrofi che ne possono derivare senza che nessuno le abbia volute o previste. La tradizione francese degli Stati si fondava sull’idea di una convocazione della nazione da parte del re. Ma si trattava della nazione organizzata nei suoi corpi tradizionali, definiti dalla razza, dagli Stati, dagli ordini, dalle cariche dello stato, un sistema assai complesso che ignorava il cittadino e l’individuo e riconosceva solo le forze sociali. La pratica inglese era diametralmente opposta, visto che si trattava di individui che eleggevano direttamente i propri rappresentanti al parlamento. In un sistema del genere ogni votante vale comunque un’unità, di chiunque si tratti. In altri termini, il voto si indirizza a individui astratti, irreali, in certo senso omogeneizzati e atomizzati. Ora, una massa inorganica non può deliberare e decidere, le servono parole d’ordine, programmi, politici di professione. In sostanza, la condizione di possibilità e di efficacia di un regime politico basato sullo scrutinio individuale è l’esistenza di partiti politici animati da dirigenti di professione. I due sistemi sono incompatibili e si doveva scegliere uno dei due. Ciò che stupisce è che Necker abbia rifiutato di scegliere. Da un lato, egli adotta un sistema a suffragio assai allargato, quasi universale, tagliato fuori da tutte le influenze e da tutti i notabilati, in sostanza un sistema all’inglese. Dall’altro lato egli vieta le candidature e i programmi. I cahiers de doléances dovevano essere redatti e deputati dovevano essere scelti spontaneamente da elettori che non si conoscevano tra loro e non sapevano neppure di che si trattasse. Tutto questo in pochi giorni. Per di più gli scrutini comportavano diversi gradi successivi, in modo che, ad ogni livello, bisognava di nuovo redigere e scegliere in base all’espressione spontanea dei lumi di un Popolo visitato da non si sa quale grazia. I poveri contadini venuti da venti o trenta leghe di distanza avrebbero dovuto riformare il regno e designare a volte parecchie decine di nomi, senza conoscere nessuno e con la proibizione di stilare in anticipo un programma o di preparare delle liste. Il regolamento del 24 gennaio poneva gli elettori nel vuoto, non nella libertà” (p. 91).
L’ordinanza era assurda – nel senso proprio di contraddittoria dal punto di vista logico – e inapplicabile. Invece venne applicata e, ovunque, i cahiers vennero redatti e i deputati eletti senza nessuna difficoltà. Non si trattò di un miracolo, ma del risultato di un meccanismo semplicissimo. In mezzo a una folla disorientata e atomizzata un pugno di individui può essere onnipotente, purché si accordi in anticipo sui programmi e sui nomi senza mettersi in luce. Le società di pensiero qui si trovavano come pesci nell’acqua. Il loro circolo interno – quello che oggi chiameremmo il gruppo dei funzionari – si riuniva prima di ogni riunione e si metteva d’accordo su tutti i punti in discussione. Nel corso delle riunioni i membri delle società, dispersi in mezzo alla folla, monopolizzavano la parola, isolavano a urla gli eventuali dissenzienti, si portavano dietro la massa sconcertata. In caso di difficoltà prolungavano i dibattiti finché la stanchezza costringeva i presenti a votare qualsiasi cosa. Dal momento che cerano gradi diversi, cera sempre la possibilità di correggere nell’assemblea di grado superiore le imperfezioni del risultato di quella precedente. Per coronare l’impresa, a livello di baliato l’ordinanza imponeva la riduzione” cioè che il numero di votanti venisse portato a duecento. Bisognava eliminare tutto ciò che era in soprannumero. Era l’occasione definitiva per sbarazzarsi dei dissidenti che avevano superato i filtri successivi, imponendo gli amici. L’impresa venne condotta perfettamente, senza mai violare la legalità. La maggioranza delegò una minoranza e appoggiò il suo programma in certa misura senza saperlo. Con un gioco di prestigio sconcertante per la sua facilità, il piccolo popolo delle società di pensiero si era sostituito al popolo reale e si presentava a Versailles come il suo legittimo rappresentante. (…) La volontà generale aveva trovato il suo organo. La sostituzione riuscì con tanto maggiore efficacia in quanto il partito aveva previsto ed eliminato tutti gli ostacoli. Essendo poco numerosi, gli ideologi rischiavano di essere sommersi e di scontrarsi con personalità e coalizioni avverse al loro partito. In effetti molti notabili” votavano col Terzo e occorreva dunque eliminarli in anticipo. Nel novembre 1788 venne lanciata una campagna che intendeva escludere dallo scrutinio i nemici naturali” del popolo, i privilegiati, gli ufficiali di giustizia, gli esattori delle decime o del censo, in sostanza tutte le autorità naturali la cui opinione contasse qualcosa, specie nelle campagne. La rivendicazione parve scandalosa e sollevò violente polemiche. Ma il partito insistette e vinse. Certo, anche molti dei suoi cadevano sotto i colpi dell’esclusione, visto che anch’essi erano notabili. Furono ammesse eccezioni a loro vantaggio e così la massa degli elettori fu passata attraverso un setaccio sottile che lasciò filtrare soltanto gente sicura e fidata insieme a una massa atomizzata. Scattava il meccanismo che doveva implacabilmente sviluppare i suoi effetti fino al 9 Termidoro, fino al momento in cui il popolo reale si sarebbe svegliato e avrebbe eliminato gli ideologi.
E’ il caso di insistere sul fatto che l’avventura non fu il risultato di un complotto organizzato su scala nazionale? Certo, le società corrispondevano tra loro e diffondevano le loro parole d’ordine. Ma uno stato maggiore generale non esisteva. Cera soltanto un tipo di uomo prodotto nei quarant’anni precedenti e a cui era stato procurato un ambiente dove agire senza ostacoli. Le pratiche sperimentate in piccole società separate, e le idee che in queste società erano nate vennero applicate e iniettate in tutto il corpo della nazione, come un moto naturale, irresistibile e inconsapevole. Non ci furono complotti, ma aggregazione meccanica di una miriade di azioni disperse che andavano tutte nello stesso senso, senza che nessuno l’avesse voluto o avesse potuto prevedere le ultime conseguenze. Sono stati i francesi a fare la Rivoluzione, essa non si è imposta loro come una decisione di Dio, del Destino o della Storia. I francesi hanno fatto la Rivoluzione, ma non lo sapevano.
3. Homo ideologicus al potere
Cochin è morto prima di riuscire finire la sua opera. Così, il periodo che va dal 5 maggio 1789 al 2 giugno 1793 (l’eliminazione dei girondini) non l’ha trattato, saltando invece direttamente all’interpretazione del governo rivoluzionario fino al risveglio di Termidoro (27 luglio 1794). Anche qui, i principi sono gli stessi: niente complotto, ruolo secondario delle singole personalità, effetti subordinati delle circostanze. L’essenziale è lo svolgimento meccanico di una logica implicita e inconscia che è quella di homo ideologicus. I testi sono abbastanza espliciti per consentirmi di metterne in rilievo soltanto i punti essenziali.
Giunto al potere, homo ideologicus impone necessariamente il terrorismo. Da un lato qualsiasi manifestazione di forza si trova a essere giustificata in anticipo, quale che sia il livello a cui può spingersi. D’altro canto, il contatto con la realtà moltiplica gli ostacoli insormontabili. Una volta che ci si è convinti di rappresentare adeguatamente il Popolo e di difendere i suoi interessi superiori, il risultato è che ogni provvedimento che vada nel senso degli interessi del Popolo interpretati dai suoi rappresentanti è automaticamente. giustificato, mentre all’inverso ogni provvedimento divergente è deplorevole. Dal momento che il Popolo è il sovrano assoluto, Dio incarnato – un’immagine che non è troppo forte – la sua volontà è il criterio supremo del Bene e del Male. Ma il Popolo è muto, non parla se non per il tramite dei suoi rappresentanti autodesignati. Appena giunti al potere, costoro fanno un’esperienza sconvolgente: il popolo non è il Popolo, gli accade anzi, frequentemente e addirittura sistematicamente, di non agire e di non pensare come farebbe il Popolo. Bisogna scegliere. L’ideologo ha già scelto, visto che tutto il processo di cui è il prodotto ha contribuito a staccarlo dal popolo per farlo accedere al Popolo. Decreterà, di conseguenza, che il popolo è corrotto e che bisogna costringerlo alla virtù con ogni mezzo. Di qui il senso del tutto particolare assunto dal termine rivoluzionario” e dai suoi antonimi, aristocratico” e così via… Si chiama rivoluzionario ogni atto e ogni decisione che emani direttamente dal sovrano (e in effetti dai suoi rappresentanti autodesignati). Essi sono, come tali, al di sopra di ogni legge, di ogni giustizia, di ogni morale convenuta.” In definitiva il governo rivoluzionario […] istituisce il regno personale del dio-popolo. E questa incarnazione ha per effetto di fondare una nuova morale il cui problema non è se un atto sia buono o cattivo, ma se esso sia rivoluzionario o no, cioè se sia conforme o no alla volontà presente attiva del Dio” (p. 125). Nel 1793 e nel 1794 la Francia stupefatta assiste alla fondazione di una teocrazia politica: Chi segue il nuovo dio, il Popolo giacobino, è virtuoso per definizione; chi lo combatte è un criminale” (p. 126). Dal momento in cui i titolari del potere – meno al centro che a livello locale, come vedremo – sono i portavoce del dio, lo statuto dei dissidenti cambia natura. Il potere non ha più avversari, ha soltanto nemici, ogni divergenza od opposizione viene a essere demonizzata: non si tratta col diavolo, lo si annienta”. Così, per sua propria natura, il regime ideologico è portatore di terrore – e del più estremo – proprio perché il più legittimo. Il terrore non si potrebbe evitarlo se non realizzando in ogni occasione l’unanimità. Ma l’unanimità non esiste certo nel Popolo, la cui natura è di essere diviso dalla diversità e dall’opposizione degli interessi, delle opinioni e delle ambizioni. Non esiste neppure tra gli ideologi. Abituati alle facili unanimità sui principi astratti, sulla Libertà, la Giustizia, la Felicità, il contatto con le realtà concrete reintroduce tra di loro le differenze di giudizio di finalità e di tattica. Ma il regime si fonda sulla finzione di un dogma puro e inflessibile: nessuna sfumatura può manifestarsi senza sembrare tradimento. Accade qui quello che accade nella vita privata, quando non ci si lascia scelta fuori di quella tra la realizzazione integrale dell’ideale e l’abbandono di ogni idealità. La conseguenza è la disperazione oppure il cinismo, dato che non si è voluto riconoscere che, posto un ideale, la sua realizzazione non può incontrare altro che approssimazioni più o meno lontane. Sul terreno politico questo rifiuto delle sfumature e delle approssimazioni si traduce necessariamente nel meccanismo delle purghe che si succedono le une alle altre, e in una rapidissima rotazione del personale politico. E’ una rotazione che non turba la marcia del sistema, al contrario la facilita. Basterebbe questo fatto a mostrare quanto gli individui siano qui subordinati a una logica che li scavalca pur potendosi realizzare soltanto grazie a loro.
Il potere costringe a scendere dalla città delle nuvole, dove i problemi svaniscono o trovano la loro soluzione immediata, per inoltrarsi invece sulla terra, dove i problemi sono reali e refrattari al regime ideologico. Ma il modo in cui homo ideologicus affronta la realtà è caratterizzato da due dominanti: l’irrealismo e il panico. L’irrealismo è la conseguenza diretta della formazione ricevuta, in cui si conversava senza pensare ad agire. In effetti, tutte le misure prese dalla Rivoluzione in materia economica o finanziaria si sono rivelate vere e proprie catastrofi. Se si volevano vuotare i mercati, la misura più efficace consisteva nel blocco dei prezzi e nelle vendite obbligatorie. E proprio questo si fece. Se si volevano vuotare le macellerie, bisognava imporre ai contadini la consegna di una bestia a data fissa: privo di cibo e di cure il povero animale moriva prima del tempo o si presentava al macello tutto pelle e ossa. E così di seguito. Le regole più elementari e sperimentate della vita economica vengono sistematicamente violate. Ma l’esperienza della catastrofe non serve a correggere nulla. Al contrario, suscita solo panico e fughe in avanti. Le catastrofi non vengono messe in rapporto alla stupidità delle misure prese, ma alla malvagità del popolo e soprattutto ai complotti della fazione nemica a cui vanno le attenzioni preferenziali del momento. Si tenta quindi di forzare la realtà rafforzando le misure prese e massacrando. In politica estera, l’irrealismo e il panico sono sempre gli stessi. Si dichiara guerra all’Europa intera senza aver misurato i rischi, e quando la guerra va male si proclama la patria in pericolo precipitandosi a “settembrizzare” degli innocenti. E’ questo processo che confuta la difesa che consiste nel giustificare il Terrore con la necessità di rispondere alla sfida delle circostanze. Da un lato, queste sfide sono spesso il prodotto delle misure stesse del Terrore, si pensi per esempio al problema dei rifornimenti alimentari; dall’altro lato affrontare i problemi non implica affatto il terrorismo, come mostrano i prussiani che superano le difficoltà provocate da Jena e i russi quelle dell’invasione napoleonica senza ricorrere alla ghigliottina. Sono invece implicite nella natura terrorista del regime ideologico sia la tendenza a provocare catastrofi del tutto evitabili sia quella a rafforzare il terrorismo per superarle. Non siamo nella logica razionale, siamo in quella ideologica.
Il lato più affascinante e insieme più sconvolgente del fenomeno è che il Terrore, in definitiva, funziona senza terroristi. Intendiamoci, sono sempre uomini quelli che attualizzano le virtualità di una situazione e di un regime politico. Ma dedurre dall’enormità dei crimini la statura gigantesca dei criminali sarebbe del tutto inutile. Persino i personaggi più esaltati e incensati dal mito rivoluzionario nato e sviluppatosi nell’Ottocento, Robespierre, Marat, Danton, Saint-Just, sono presi per quello che in effetti furono, incredibilmente mediocri e insignificanti. Ma c’è qualcosa di più grave ed è il fatto che il Terrore non viene dal centro, nasce alla periferia prima di essere adottato e generalizzato dal centro: La legislazione del Terrore è tanto poco opera di teorici isolati o di politici avvertiti che i decreti più importanti della Convenzione vengono assai spesso soltanto a consacrare il fatto compiuto: è il caso della legge dei sospetti (14 settembre 1793) applicata dalle società di Pontarvier il 10 settembre, di Limoges lo stesso giorno, di Montpellier il 17, reclamata da quelle di Valence il 3, di Castres il 17; è il caso delle leggi del maximum“ votare in tutte le società da più di un anno, e applicate precocemente dalla gran parte; e il caso della socializzazione dei mezzi di sussistenza allorché la Convenzione, nel novembre del 1793, copiò il piano tracciato il 9 ottobre dalle società del Midi” (p. 169). Si dà il caso che nel 1793, dopo una serie di purghe che si sono succedute l’una all’altra, le società locali sono in mano a un pugno di individui tutt’altro che particolarmente illuminati. Pure, essi non incontrano difficoltà a trovare le risposte o a recepirle da fuori quando per caso non le hanno già trovate. Il fatto è che homo ideologicus dispone di un ventaglio assai limitato di soluzioni, semplici, ricavate direttamente dalla stessa ideologia; l’ultimo degli imbecilli basta per decidere che se i maiali sono magri la colpa è dei contadini e che ghigliottinando i contadini i maiali ingrasseranno!
Altro sintomo dello stesso fenomeno è il fatto che l’organo essenziale del governo rivoluzionario non è il Comitato di salute pubblica, per non parlare ovviamente dei poteri ufficiali come la Convenzione o i ministri, ma è “l’ufficio di sorveglianza all’esecuzione delle leggi” creato nel luglio 1793. Sarebbe difficile immaginare un organismo più oscuro e insignificante. Gli sono state affidate essenzialmente tre funzioni: registrare la corrispondenza in arrivo, distribuirla ai servizi competenti, constatare in partenza la risposta data e la procedura seguita.
Tutto il lavoro consiste nel tracciare ‘stati di avanzamento, cioè tavole sinottiche che fissano per ogni decade il ‘grado di esecuzione di una determinata operazione nei diversi distretti, quando si tratta di una misura generale: e di tavole cronologiche suddivise per colonne che registrano la data, l’analisi, le conseguenze di ogni decisione, se si tratta di decisioni particolari” (p. 181). L’ufficio non è altro che una burocrazia anonima che maneggia esclusivamente carte. Ed è il centro reale del potere! Il sistema è vantaggioso per i governanti, i quali non hanno bisogno di talenti e neppure di popolarità. La macchina funziona da sola, animata da migliaia di mani anonime collocate in tutti i punti strategici; è implacabile per i governati, finché restano atomizzati. Ed è soprattutto da essi continuamente rafforzata. L’irrealismo delle misure prese fa sì infatti che il popolo, per sopravvivere alle catastrofi, sia costretto ad agire contro il proprio interesse e a vantaggio degli ideologi. In effetti, ogni provvedimento tende ad andare a vantaggio di coloro che lo violano e a danno di coloro che lo applicano. Così avviene per esempio con la legge del maximum. Il venditore che la rispetta perde del denaro e il consumatore che frequenta solo i pubblici mercati rischia di morire di fame. Al contrario, il venditore che non consegna il prodotto e alimenta il mercato nero ha buone probabilità di far fortuna, mentre il consumatore solvibile trova tutto ciò che mole su questo mercato parallelo. Lo stesso accade con gli assegnati: chi li conserva e li scambia al loro valore nominale si rovina mentre lo speculatore al ribasso si arricchisce. E così via. La rottura delle relazioni economiche normali e la produzione artificiale di due mondi economici sovrapposti hanno per risultato il fatto che ognuno diventa il nemico di tutti i suoi simili. Il sospetto e lo spionaggio reciproci si diffondono, alimentando la delazione al punto che l’intervento dell’esercito diventa inutile per tenere sotto controllo il paese. Ogni distretto e persino ogni comune, sconvolti dalla carestia o dalla paura della carestia, organizzano razzie tra i vicini per rifornire il mercato. Il potere ha solo da lasciar fare perché le misure terroriste vengano applicate senza il suo intervento. (…)
Augustin Cochin è morto nel luglio del 1916. Non ha dunque potuto conoscere i regimi ideologici del ventesimo secolo. Il lettore che abbia avuto la pazienza di leggere questa prefazione sarà rimasto colpito dall’attualità dell’analisi di Cochin. Mi è bastato modernizzare leggermente il linguaggio perché l’analisi si applicasse perfettamente anche ai nazisti e soprattutto ai bolscevichi. (…) C’è tutto: un’avanguardia che sostituisce il Popolo al popolo; uno stupefacente virtuosismo tattico e strategico fondato principalmente sulla violazione delle regole del gioco accettate dagli avversari; la mediocrità generale del materiale umano; e così via. Questa intuizione ha del miracoloso. Ma se Cochin ha capito perfettamente il bolscevismo, che non ha mai conosciuto, egli non ha capito nulla della democrazia liberale, che aveva sotto gli occhi. Si vedrà che a più riprese egli identifica i giacobini con la macchina” dei partiti americani o coi caucus men[1] inglesi. Se di fatto tra questi fenomeni esistono punti in comune di tipo tecnico, i regimi politici sono diametralmente opposti. Questo accecamento ha a che fare con le posizioni ideologiche personali di Cochin. (…) Per lui, il buon regime è quello dell’Ancien Régime, cioè quello in cui un potere centrale investito d’autorità era bilanciato da corpi costituiti radicati nella tradizione. Il fatto è che la sua visione dell’Ancien Régime è assolutamente errata. L’idea che egli se ne fa può aver avuto qualche realtà sotto Luigi XIV, ma è stata definitivamente spazzata via dalla centralizzazione e dalla burocratizzazione imposte proprio da questo monarca e proseguite nel corso di tutto il Settecento. In quanto storico, Cochin avrebbe dovuto leggere Tocqueville. Con una omissione inspiegabile, se non in base ai presupposti ideologici di Cochin, questi non cita né discute mai Tocqueville, il cui nome appare nei suoi scritti soltanto una volta, se il mio conto è giusto. L’omissione è tanto più curiosa in quanto sul piano strettamente scientifico le due opere si completano a vicenda in modo ammirevole. Tocqueville ha totalmente e volontariamente trascurato la rottura rivoluzionaria, per concentrarsi esclusivamente sui risultati della rivoluzione, mostrando come essi portino a compimento un lavoro già largamente svolto dalla monarchia. Al contrario, Cochin si appassiona alla rottura in quanto tale, visto che la sua ideologia personale gli fa considerare proprio il periodo 1788-94 come qualcosa di assolutamente nuovo, come una soluzione di continuità. Hanno entrambi ragione, visto che la rivoluzione francese nello stesso tempo porta a compimento la centralizzazione e la burocratizzazione della Francia e produce un fenomeno nuovo che dominerà il ventesimo secolo. (…) E’ stata la deformazione ideologica a consentire a Cochin di ritrovare nella Rivoluzione francese le premesse del totalitarismo. Ma tutto si paga. Cochin ha pagato interdicendo a se stesso la possibilità di spiegare la genesi dell’homo ideologicus. Supponendo ch’esso sia il prodotto meccanico delle società di pensiero, Cochin non ci dice mai a loro volta da dove vengano queste società. Sembrano cadere dal cielo verso il 1750, in una società equilibrata che non sapeva che farsene. L’ipotesi più generale e più verosimile che si possa formulare su questo problema è che il filosofismo” sia appunto un ricorso o una compensazione prodotti dalla decomposizione di una società tradizionale sotto i colpi della centralizzazione, della burocratizzazione e della razionalizzazione volute dalla monarchia. In altri termini, l’origine del fenomeno deve essere messa in rapporto con la scomparsa di un ordine tradizionale. (…) Una volta fatta questa riserva, però, resta da dire che l’analisi svolta da Cochin sul problema della rottura rivoluzionaria è di gran lunga la migliore di cui si disponga a tutt’oggi. Perché il lettore dotato di senso del comico possa convincersene, vorrei che si ponesse una domanda molto semplice: Perché c’è stata una rottura rivoluzionaria, nella Francia della fine del Settecento?” Il lettore legga sistematicamente tutte le prefazioni, le introduzioni, e tutti i capitoli I delle storie della Rivoluzione francese. Rimarrà sconvolto constatando che la maggior parte di esse non si è neppure posta la questione, e le altre non hanno risposto. C’è una sola eccezione, Augustin Cochin.
pp. 22-38
4) Riflessioni sulla base della lettura del libro Alexis de Tocqueville, L’Ancien Régime e la Rivoluzione, Milano, Rizzoli 1989 (prima edizione francese 1856)
Meno di un anno dopo l’inizio della Rivoluzione, Mirabeau scriveva segretamente al re: «Confrontate il nuovo stato di cose con l’Antico regime; da questo confronto nascono il conforto e la speranza. Una parte degli atti dell’assemblea nazionale, ed è la parte maggiore, è palesemente favorevole a un Governo monarchico. Non vi sembra nulla essere senza Parlamento, senza paesi di Stato, senza gli Ordini del clero, della nobiltà, dei privilegiati? L’idea di formare una sola classe di cittadini sarebbe piaciuta a Richelieu: questa superficie tutta eguale facilita l’esercizio del potere. Parecchi periodi di governo assoluto non avrebbero fatto per l’autorità regia quanto questo solo anno di rivoluzione».
Era questo un capire la Rivoluzione da uomo capace di guidarla.
Poiché la Rivoluzione Francese non si proponeva soltanto di cambiare un antico governo, ma di abolire la vecchia forma della società, essa dovette attaccare contemporaneamente tutti i poteri costituiti, distruggere tutte le influenze riconosciute, cancellare le tradizioni, rinnovare i costumi, gli usi, e, in un certo senso, vuotare lo spirito umano di tutte quelle idee sulle quali si erano basati fino ad allora il rispetto e l’obbedienza. Da ciò il suo carattere così particolarmente anarchico.
Ma scartate questi residui e scorgerete un potere centrale immenso che attira e assorbe nella sua unità tutte le particelle di autorità e di prestigio disperse prima fra innumerevoli poteri secondari, ordini, classi, professioni, famiglie e individui, e quasi sparpagliati in tutto l’organismo sociale. Dalla caduta dell’impero romano, non si era visto nel mondo un potere simile. La Rivoluzione ha creato questo potere nuovo, o piuttosto esso è sorto, quasi spontaneamente, dalle rovine da essa prodotte. I governi che ha istituiti sono più fragili, è vero, ma cento volte più potenti di tutti quelli che ha rovesciati; fragili e potenti per una stessa causa, come dirò altrove.
Questa forma semplice, regolare, grandiosa, Mirabeau la intravedeva già attraverso la polvere delle antiche istituzioni a metà demolite.
pp. 45-46
Per quanto sia stata radicale, la Rivoluzione ha tuttavia innovato meno di quanto si suppone in genere: dimostrerò in seguito che è stata molto meno novatrice di quanto si crede. E vero invece che essa ha distrutto interamente, o è in via di distruggere (perché dura ancora), tutto quanto nell’antica società derivava dalle istituzioni aristocratiche e feudali, tutto quanto vi si riallacciava in qualche modo, tutto quanto ne portava, fosse pure minima, l’impronta. Del vecchio mondo, ha conservato solo quanto a tali istituzioni era estraneo, o poteva esistere senza di esse. Perché la Rivoluzione è stata tutt’altro che un avvenimento fortuito. Ha colto il mondo alla sprovvista, è vero; ma è il compimento di un lungo lavorio, la conclusione improvvisa e violenta di un’opera, alla quale avevano lavorato dieci generazioni di uomini. Se non fosse avvenuta, il vecchio edificio sociale sarebbe egualmente caduto, qui più presto, là più tardi; soltanto, avrebbe continuato a cadere pezzo a pezzo, invece di sprofondare di colpo. La Rivoluzione ha compiuto bruscamente, con uno sforzo convulso e doloroso, senza transizione, senza precauzioni né riguardi, quanto si sarebbe compiuto a poco a poco, da sé e in molto tempo. Fu questa, la sua azione. (…)
«Volevate correggere gli abusi del vostro Governo », dice lo stesso Burke ai francesi; « ma perché fare delle novità? Perché non ritornare alle vostre antiche tradizioni? Perché non vi siete limitati a riprendere le vostre antiche franchigie? O, se vi era impossibile ritrovare la offuscata fisionomia della Costituzione dei vostri padri, perché non avete volto gli occhi dalla nostra parte? Vi avreste ritrovato l’antica legge comune all’Europa ». Burke non si accorge di avere sotto gli occhi la Rivoluzione che deve precisamente abolire questa antica legge comune all’Europa; non scorge affatto che lo scopo è proprio questo e non altro.
p. 58-59
L’Antico regime, sebbene sia ancora molto vicino a noi, tanto che ogni giorno incontriamo uomini nati sotto le sue leggi, sembra già perdersi nella notte dei tempi. La rivoluzione radicale che ce ne separa ha prodotto l’effetto di secoli offuscando tutto quanto non ha distrutto. Poche persone, dunque, possono rispondere con esattezza a questa semplice domanda: « Come si amministravano le campagne prima del 1789?». Infatti non si potrebbe dirlo con precisione e nei suoi particolari senza avere studiato, non i libri, ma gli archivi amministrativi del tempo.
Spesso ho sentito dire: «La nobiltà, che da lungo tempo non prendeva parte all’amministrazione dello Stato, aveva conservato sino alla fine l’amministrazione delle campagne; il feudatario governava i contadini». Anche in questo vi è molta parte di errore.
Nel diciottesimo secolo dirigevano tutti gli affari della parrocchia un certo numero di funzionari che non erano più gli agenti del feudo e non erano più scelti dal feudatario; gli uni venivano nominati dall’intendente della provincia; gli altri erano eletti dai contadini stessi. Toccava a queste autorità ripartire le imposte, restaurare le chiese, costruire le scuole, radunare e presiedere l’assemblea della parrocchia. Vegliavano sui beni comunali, ne regolavano l’uso, e intentavano e sostenevano i processi in nome della comunità. Non soltanto il feudatario non dirigeva più l’amministrazione di questi piccoli interessi, ma non la sorvegliava. Tutti i funzionari della parrocchia erano sotto il governo, o sotto il controllo, del potere centrale, come dimostreremo nel capitolo seguente. Inoltre, non si vede quasi più il feudatario agire come rappresentante del re nella parrocchia, come intermediario fra lui e gli abitanti. Egli non è più incaricato di applicarvi le leggi generali dello Stato, di raccogliervi le milizie, di imporre le tasse, di rendere noti gli ordini del principe, di distribuire i suoi soccorsi: tutti doveri e diritti che spettano ad altri. Il feudatario è ormai solo un abitante che alcune immunità e alcuni privilegi separano ed isolano da tutti gli altri; la sua condizione è diversa, non il suo potere. Il feudatario non è che il primo abitante, hanno cura di specificare gli intendenti nelle lettere ai loro sottodelegati. (…)
Quando la nobiltà non possiede soltanto privilegi, ma il potere; quando governa e amministra; i suoi diritti particolari possono essere maggiori e nello stesso tempo meno visibili. Nei tempi feudali si considerava la nobiltà pressa poco come oggi si considera il governo: si sopportavano i gravami che imponeva, in grazia delle garanzie che dava. I nobili avevano privilegi incomodi, possedevano diritti. onerosi; ma assicuravano l’ordine pubblico, amministravano la giustizia, facevano osservare le leggi, soccorrevano i deboli, dirigevano gli interessi comuni. A mano a mano che la nobiltà vien meno a queste sue funzioni, il peso dei suoi privilegi sembra aumentare e la loro stessa esistenza finisce con l’essere incomprensibile.
pp. 67-68
Nelle sue Memorie, il marchese d’Argenson racconta che un giorno Law gli disse: «Non avrei mai creduto quanto ho visto quando ero controllore delle finanze. Sappiate che il regno di Francia è governato da trenta intendenti. Voi non avete né Parlamento, né Stati, né governatori; vi sono trenta referendari impiegati nelle province, dai quali dipendono il benessere o la infelicità, l’abbondanza o la carestia di queste province».
Questi potenti funzionari erano però eclissati da quanto restava dell’antica aristocrazia feudale e come sperduti nello splendore che ancora ne emanava, di modo che, anche al loro tempo, si notavano appena, sebbene la loro mano fosse già dappertutto. In società, i nobili avevano su di loro il vantaggio del rango, della ricchezza e della considerazione che è sempre legata alle cose antiche. Nel governo, la nobiltà circondava il principe, ne formava la corte; comandava le flotte, guidava gli eserciti; faceva, in una parola, tutto ciò che colpisce gli occhi dei contemporanei e troppo spesso arresta gli sguardi dei posteri. Proporre a un gran signore di nominarlo intendente sarebbe stato un insulto; molto spesso, anche il più povero gentiluomo di razza avrebbe sdegnato di esserlo: ai suoi occhi, gli intendenti rappresentavano un potere intruso, uomini nuovi, preposti al governo dei borghesi, dei contadini.
Eppure questi uomini governavano la Francia, come aveva detto Law e come vedremo.
pp. 77-78
In Francia la libertà municipale è sopravvissuta al feudalismo. Quando già i feudatari non amministravano più le campagne, le città conservavano ancora il diritto di governarsi. Fin verso la fine del diciassettesimo secolo se ne trovano ancora che continuano a formare piccole repubbliche democratiche, nelle quali i magistrati sono eletti liberamente dal popolo e responsabili di fronte a lui, e dove la vita municipale è pubblica e attiva, e la città pare ancora orgogliosa dei propri diritti e gelosissima della propria indipendenza.
Le elezioni furono abolite generalmente per la prima volta solo nel 1692. Le cariche municipali furono allora costituite in uffici, vale a dire che in ogni città il re vendeva ad alcuni abitanti il diritto di governare in perpetuo tutti gli altri. (…)
E, cosa degna di tutto il disprezzo della storia, questa grande rivoluzione fu compiuta senza nessuna mira politica. Luigi XI aveva limitato le libertà municipali perché il loro carattere democratico gli faceva paura; Luigi XIV le distrusse senza temerle. Lo prova il fatto che le restituì a tutte le città che poterono ricomprarle. In realtà non voleva tanto abolirle, quanto mercanteggiarle, e, se le abolì davvero, fu per così dire senza pensarvi, per puro espediente finanziario; e, cosa strana, lo stesso giuoco continuò a ripetersi per ottant’anni. Sette volte, durante questo periodo, è venduto alle città il diritto di eleggere i propri magistrati, e, quando esse ne hanno di nuovo goduto il vantaggio, si toglie loro per rivenderglielo. Il motivo del provvedimento è sempre lo stesso, e sovente è confessato. «I bisogni delle nostre finanze», dice il preambolo dell’editto del 1722, «ci obbligano a cercare i mezzi più sicuri per rimediarvi». Il mezzo era sicuro, ma rovinoso per coloro sui quali cadeva quella strana imposta. «Sono colpito dall’enormità delle somme pagate in tutti i tempi per riscattare gli uffici municipali», scrive un intendente al controllore generale nel 1764. «L’ammontare di questa somma impiegato in lavori utili si sarebbe volto a profitto della città, la quale, al contrario, ha sentito soltanto il peso dell’autorità e dei privilegi di queste cariche». Non vedo particolare più vergognoso di questo nella struttura dell’Antico regime. (…)
Nel quindicesimo secolo, l’assemblea generale si componeva spesso di tutto il popolo; quest’uso, dice uno dei memoriali dell’inchiesta, si accordava con lo spirito popolare dei nostri antichi. Era il popolo tutto intero, allora, ad eleggere i suoi ufficiali municipali; era consultato qualche volta e ad esso si rendeva conto. Tutto ciò s incontra ancora, talvolta, alla fine del diciassettesimo secolo.
Nel diciottesimo secolo non è più tutto il popolo che forma l’assemblea generale; questa è quasi sempre rappresentativa, e, come bisogna ben considerare, non è più eletta in nessun luogo dalla massa del popolo e non ne ha in sé lo spirito. Dappertutto essa si compone di notabili; alcuni ne fanno parte per diritto proprio; altri vi sono mandati da corporazioni o da compagnie e ognuno vi adempie un mandato imperativo che gli è stato affidato da quella piccola società particolare. (…)
Nel diciottesimo secolo il governo municipale delle città era dovunque degenerato in una piccola oligarchia. Alcune famiglie amministravano secondo intenti particolari, lontano dagli sguardi del pubblico e senza essere responsabili di fronte ad esso; è una malattia che ha colpito l’amministrazione della Francia intera. Tutti gli intendenti la segnalano; ma non sanno immaginare altro rimedio se non l’asservimento sempre maggiore dei poteri locali al governo centrale.
Era difficile tuttavia riuscirvi meglio di quanto era già stato fatto; indipendentemente dagli editti che di tempo in tempo modificano l’amministrazione di tutte le città, regolamenti del Consiglio non registrati, emanati su proposta degli intendenti, senza un’inchiesta preliminare e qualche volta senza che gli abitanti della città lo dubitino, sconvolgono le leggi particolari proprie a ciascuna.
«Questo provvedimento», dicono gli abitanti di una città che è stata colpita da un simile decreto, «ha meravigliato tutti gli Ordini della cittadinanza, che non si aspettava nulla di simile».
Le città non possono né stabilire un dazio, né riscuotere un contributo, né ipotecare, né vendere, né stare in causa, né affittare i propri beni, né amministrarli, né usare l’eccedenza delle somme riscosse, senza che su rapporto dell’intendente intervenga un decreto del Consiglio. Tutti i loro lavori sono eseguiti su piani e secondo preventivi approvati con decreto dal Consiglio, aggiudicati in presenza dell’intendente o dei suoi sottodelegati, e di solito chi li dirige è l’ingegnere o l’architetto dello Stato. Ecco di che sorprendere molto quanti pensano sia tutto nuovo quel che si vede in Francia. (…)
Attraverso la corrispondenza dell’intendente con i suoi sottodelegati si vede infatti che il governo ha la mano in tutti gli affari, grandi e piccoli, delle città. E consultato su tutto e il suo parere decide di tutto; regola perfino le feste. E’ il governo, in certi casi, a ordinare le manifestazioni di allegrezza pubblica, a far accendere i falò e illuminare le case in segno di festa. Trovo un intendente che mette un’ammenda di 20 lire ai membri della guardia borghese perché non sono intervenuti ad un Te Deum. Perciò gli ufficiali municipali hanno il senso esatto della loro nullità. «Umilissimamente vi preghiamo, Monsignore», scrivevano alcuni di loro all’intendente, «di accordarci la vostra benevolenza e la vostra protezione. Cercheremo di non rendercene indegni con la nostra sottomissione agli ordini della Grandezza Vostra». «Non ci siamo mai opposti alla vostra volontà, Monsignore», scrivono altri, che si chiamano ancora pomposamente Pari della città
Così la classe borghese si prepara al governo e il popolo alla libertà.
pp. 84-89
Quanto ho detto delle città e delle parrocchie deve essere esteso a quasi ogni società che avesse un’esistenza a parte e una proprietà collettiva.
Sotto l’Antico regime, come ai giorni nostri, non vi era in Francia città, borgo, villaggio, né piccolo casale, ospedale, fabbrica, convento o collegio, che potesse avere una volontà indipendente nei propri affari privati, né amministrare a piacer suo i propri beni. Allora, come oggi, l’amministrazione teneva dunque tutti i Francesi sotto tutela, e se l’insolenza della parola non era ancora stata introdotta, per lo meno si aveva già la cosa.
pp. 93-94
5) Riflessioni sulla base della lettura del libro di Francesco Mario Agnoli, L’epoca delle Rivoluzioni, Rimini, Itaca – Il Cerchio 1999
Se si assumono come paradigmi storicamente realizzati della categoria rivoluzione” o, se si preferisce della possibile sottospecie rivoluzione contemporanea”, quella borghese-giacobina della Francia o quella sovietica della Russia (ma storicamente la caratteristica è forse comune a tutte le ‘vere rivoluzioni), alla base si scoprono un progetto (elaborato quasi sempre a tavolino, in circoli ristretti di intellettuali e politici di avanguardia – le cosiddette élites rivoluzionarie” -) di carattere tendenzialmente universalistico, e comunque la volontà di pervenire ad una palingenesi totale della società e alla rigenerazione dell’intera umanità o quanto meno di un determinato popolo, alla costruzione di un vero e proprio uomo nuovo.
Come bene hanno dimostrato lo storico francese François Furet e i suoi allievi, dal momento che questi risultati debbono essere realizzati nella storia, divenuta l’unico spazio nel quale si giocano i destini dell’umanità” (il Furet, cogliendo l’essenza del pensiero e, più ancora, dello spirito rivoluzionario, arriva a scrivere che la storia prende il posto di Dio nell’onnipotenza sui destini dell’umanità”), la rivoluzione attribuisce alla politica una dimensione totalizzante e perciò richiede tutte le energie a disposizione: dalle fisiche alle intellettuali e alle spirituali”; la politica acquisisce così una funzione messianica e diviene ambito religioso laicizzato e come tale intende riscrivere ex novo il contratto sociale e creare un uomo nuovo”.
Ne discende una pressoché assoluta incompatibilità della rivoluzione con qualunque forma di religione trascendente, dal momento che la prima ha i suoi déi, gelosi e vendicativi quant’altri mai: accanto alla Storia, che rappresenta il Principio primo, ma in certo senso anche remoto, che rivela il proprio mistero soltanto ai suoi sacerdoti, un dio più vicino e presente, il principe di questo mondo, lo Stato, che, inteso come la sostanza dell’umanità, come il fattore coagulante e totalizzante della vita dei singoli e dei popoli”, non solo si pone, con sua maestà al centro dell’ordinamento socio-politico, ma diviene per tutti unico o comunque decisivo punto di riferimento anche etico. (…)
Potrà senza dubbio sembrare che la definizione di rivoluzione fin qui delineata, più che stabilire una generale ed astratta categoria rivoluzionaria, faccia eccessivo riferimento a concrete esperienze storiche (in particolare alla rivoluzione francese), il che è senza dubbio vero, ma anche inevitabile, soprattutto quando si intenda collocare il fenomeno rivoluzionario nell attuale contesto storico, dal momento che la rivoluzione francese, indubbiamente evento fondante dell’età contemporanea e della società nella quale viviamo, non può non essere assunta come il paradigma di ogni rivoluzione degli ultimi due secoli almeno fino allo scoppio della rivoluzione bolscevica, che, del resto, molto significativamente ha fin dal primo momento rivendicato il proprio ruolo non solo di sua diretta e legittima erede, ma di evento capace di condurre a termine il grandioso disegno da quella non completato e che per questo nell’immaginario degli intellettuali e delle masse di sinistra compie la promessa di universale rigenerazione dell’umanità contenuta nell’evento rivoluzione dal 1789 in poi”.
E’, difatti, nella rivoluzione francese che si tenta per la prima volta di realizzare quella trasformazione politico-sociale che costituisce il nucleo essenziale del programma rivoluzionario, espresso, assai più che dalla famosa triade, peraltro intimamente contraddittoria, Liberté, egalité, fraternité, dall’insistente richiesta di eliminazione di tutti quei corpi intermedi” (associazioni, corporazioni di arti e mestieri, confraternite, comunità locali titolari di privilegi” di vario genere ecc.) che nella società organica dell’ancien régime, nella quale non esisteva paese per quanto piccolo o gruppo sociale per quanto misero che non fosse titolare di proprie intangibili ed inalienabili prerogative, costituivano ad un tempo uno strumento di partecipazione continua del cittadino alla vita comunitaria e uno scudo contro l’eccessiva ingerenza statale.
Come noto, a seguito della richiesta del deputato bretone (di Rennes) Isaac René Guy Le Chapelier (peraltro confinato dagli sviluppi rivoluzionari fra i moderati da estremista che era all’inizio) di estirpare definitivamente tutte queste idee di corpi e ordini che rinascono senza posa”, inclusi gli stessi club e le cosiddette società popolari (antenati degli odierni partiti politici), l’Assemblea costituente varò dapprima (14 giugno 1791) una legge che privava i lavoratori del diritto di associazione, poi (29 settembre 1791) un nuovo provvedimento, che proibiva a tutte le società di avere sotto qualunque forma un’esistenza politica”, in quanto anch’esse in contrasto col fondamentale dogma rivoluzionario della coincidenza totale fra Stato-Nazione e cittadini, essendo il primo, attraverso la volontà generale”, l’espressione giuridica (ma anche la regola etica) dei secondi, il che rende non solo inammissibile, ma addirittura assurda e inconcepibile l’esistenza di diaframmi o intermediari fra l’uno e gli altri.
Di conseguenza, nel sistema giacobino dell’assoluta sovranità popolare lo Stato-Nazione ha di fronte a sé unicamente una massa uniforme e indifferenziata (e, quindi, informe) di esseri uguali sì, ma, più che per la nativa eguaglianza dello stato di natura, perché ugualmente inermi ed indifesi di fronte alla forza schiacciante della volontà generale incarnata dalla Nazione (che in futuro, nell’Unione Sovietica e nella Germania nazista, diverrà lo Stato-Partito) cioè, di fatto, dell’onnipotente Leviatano statale anticipato da Hobbes.
Da una simile situazione sociale, sia stato o no l’ulteriore sviluppo previsto e voluto dai padri della rivoluzione” (siano questi semplicemente i philosophes illuministi e roussoiani e i loro successori hegeliani e marxisti e i politici che hanno voluto realizzare nella storia i sistemi da loro immaginati, o i componenti di quelle sette e di quei circoli più o meno occulti che, secondo alcune tesi, tanto contrarie quanto favorevoli alla rivoluzione, avrebbero lucidamente progettato l’intero processo rivoluzionario e continuerebbero ancora oggi a darvi impulso in forme diverse), derivano, difatti, come logica ed inevitabile conseguenza, il regime totalitario e la divinizzazione dello Stato, fenomeno del tutto sconosciuto all’universo pre-rivoluzionario.
Scrive a questo proposito il Furet, riportando le opinioni della tedesco-statunitense (di origine ebraica) Hannah Arendt sulle rivoluzioni del XX secolo (nazismo e comunismo), che l’esistenza duna ampia popolazione di sradicati, privi di diritti, sottoposti all’arbitrio assoluto del potere e trattati come oggetto di sperimentazione sociale è il tratto distintivo delle società totalitarie, che non sera mai visto nella storia… La sua culla è la democrazia moderna, o piuttosto, quella forma degradata della democrazia in cui la società non è che un aggregato d’individui isolati gli uni dagli altri, privi non solo di un legame civile, ma della solidarietà di classe, ai quali non resta altro che la pura forza del numero per unirsi attorno a emozioni elementari, investite su un demagogo. E’ il termine patologico dell’individualismo borghese, trasformato in violenza antiborghese… La dittatura totalitaria, una volta instaurata dalle masse, consolida il terreno sul quale si è innalzata, privando la società di tutto ciò che potrebbe conservare come strumenti d’autonomia. Hitler ha distrutto i Länder, i partiti, l’aristocrazia, le associazioni indipendenti, sovrapponendo a quello che non ha distrutto l’apparato del partito unico. Stalin invece, erede di un regime dal quale è bandita la proprietà privata, ha potuto liquidare persino il mondo contadino, per non parlare delle classi, dei partiti e del resto: il Partito bolscevico regna sovrano su una plebe universale d’individui atomizzati”.
pp. 6-11
Nota:
[1] Nella vita politica inglese e americana, i caucus sono i comitati locali dei partiti politici, spesso convenuti per designare candidati a elezioni o congressi




