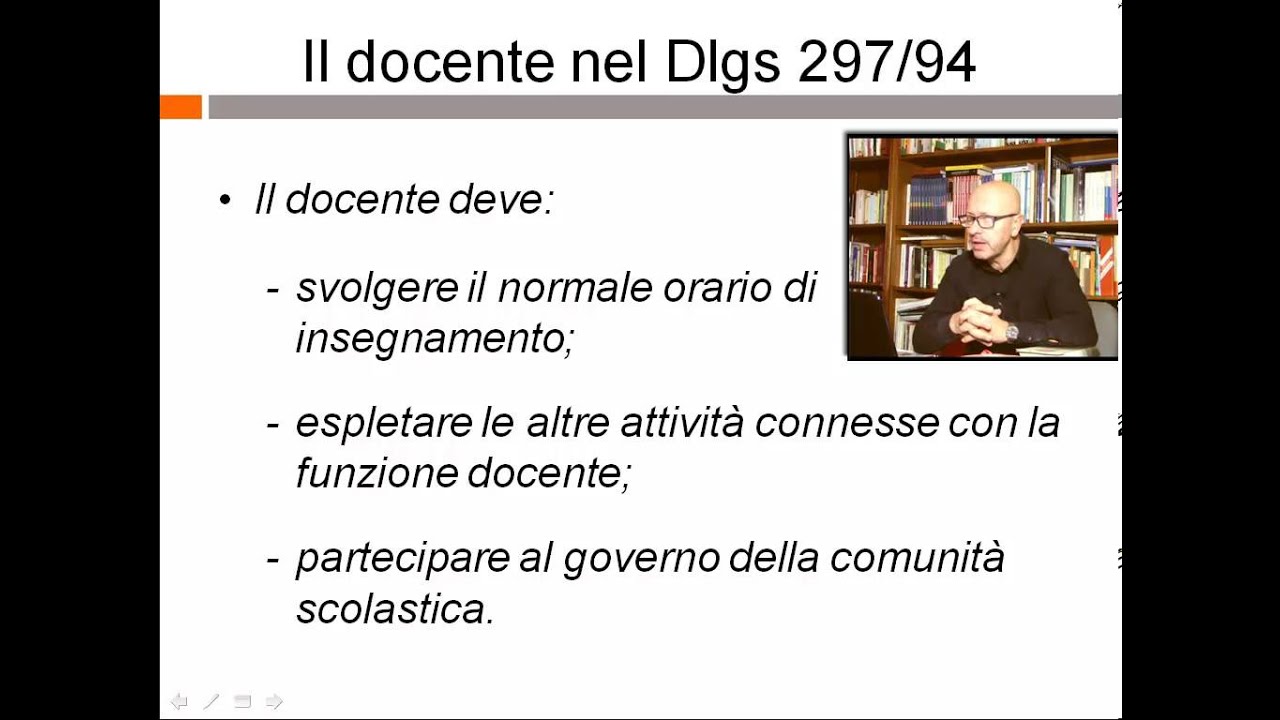Think Different
27 Gennaio 2019
Programmazione didattica classe quarta primaria di Arte e Immagine
27 Gennaio 2019
Relazione critica XXXIII canto dell’Inferno di Antonio Afeltra
Il XXXIII canto dell’inferno viene inquadrato nella cornice della fame e del mistero. Il linguaggio di Dante è freddo, con tratti di pietà e invettiva. Il canto si apre in modo diverso dagli altri, di solito il poeta iniziava con una digressione al canto precedente, proprio a voler portare l’attenzione del lettore sui due visitatori dell’inferno, questo canto inizia, invece, con una terzina che trae l’attenzione de lettore su una scena molto particolare. Infatti nella prima parte del canto, Dante non parla mai, lascia il posto ad Ugolino e alla sua rabbia verso Ruggieri.
La storia struggente che narra il Conte, viene a porsi come sfondo di tutto il canto, incorniciata come per la peste nel Decameron, dalla fame. Dante riesce a imprimere nelle parole tutto il dolore e la crudeltà della vicenda, adoperando un linguaggio scarno e essenziale.
Ci troviamo nell’Antenora, dove sono condannati “coloro che tradirono quelli che in loro tutto si fidavano, e coloro da cui erano stati promossi a dignità e grande stato”: riprendendo qui i Pisani e Genovesi.
I peccatori sono qui puniti con atroci sofferenze, conficcati fino al collo nel ghiaccio scontano la pena eterna fino al giorno del giudizio; il contrappasso è un vortice di genialità e ingegno: come in vita hanno tramato contro il prossimo raggelando il loro animo privandolo del calore della carità, così all’inferno saranno raggelati nel ghiaccio cocito.
Le due figure principali in questo canto sono il Conte Ugolino della Gherardesca, uomo potentissimo a Pisa, accusato di avere consegnato a Lucca ed a Firenze alcuni castelli pisani, fu fatto prigioniero dai Ghibellini e fu lascito morire di fame insieme a due figli e due nipoti. L’altro è l’arcivescovo Ruggeri degli Ubaldi, alla cui frode e alla cui crudeltà egli dovette la cattura e la fine orribile. Ambedue traditori scontano la colpa nello stesso luogo, ma la punizione non è uguale, Ruggeri oltre al tormento del gelo eterno ha quello che gli infligge la rabbia del suo nemico; Ugolino al dramma della dannazione si aggiunge l’ira e la sete inesausta di vendetta contro il suo nemico.
Il canto si apre con il famosissimo endecasillabo “la bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator forbendola a’capelli” una scena macabra, il Conte Ugolino che divora il cranio dell’Arcivescovo Ruggieri e si pulisce le labbra con i suoi capelli, raccapricciante, ma evidenzia tutta la drammaticità della situazione, in queste poche parole si può già delineare il profilo del Conte, un uomo consumato dalla rabbia, ma allo stesso tempo contrito dal dolore. Il canto prosegue con le parole dolorose del Conte Ugolino, un linguaggio altissimo e umilissimo.
Antecede la narrazione della sua storia con una premessa, parlerà per il solo scopo di far conoscere la sua storia, e portare infamia all’arcivescovo. In queste tre terzine si percepisce anche il pensiero politico di Dante e il suo odio per le fazioni nella sua città. Ma essendo nato da una famiglia appartenente ai guelfi, ha dentro di se un intrinseca pietà per Ugolino e una crescente rivalità contro i ghibellini.
Possiamo quasi immedesimare Dante nella figura di Ugolino, infatti il poeta vuol far conoscere la sofferenza che sta provando a causa della sua città: “ma fiorentino mi sembri veramente quando io t’odo” , le parole rivolte a Dante dal conte e che Dante rivolge a Firenze; il verso, infatti, ci chiarisce che Ugolino vuol far conoscere soprattutto a Firenze la sua storia, per fargli capire quanto sia stata dura la sua punizione.
Dopo la descrizione della torre della Muda, che per lui è l’emblema della fame e della sofferenza, continua, il Conte, raccontando un sogno premonitore della sorte che di li a poco li avrebbe colpiti. “quand’io feci l’mal sonno che del futuro mi squarciò il velame” questo verso sembra ergersi a muro tra gli edecasillabi precedenti, dove ancora non si può avere una chiara visione, e quelli che verranno, ed è proprio qui che il conte si accorge di essere in grave pericolo.
Un sogno semplice, ma di significato arduo, l’Arcivescovo che caccia con cagne magre e addestrate, un lupo con quattro lupicini, con i capi ghibellini Gualandi, Sismondi e Lanfranchi, dopo poco si accorge che il padre e i figli sono stanchi, si noti la personificazione adoperata, ad immedesimare se stesso con i figli. Segue un verso che è quasi un onomatopea, “mi parea lor veder fender li fianchi”, l’utilizzo in sequenza della lettera R conferisce al verso il suono raccapricciante della carne dilaniata.
Da questo punto in poi ad ogni terzina sembra si accresca il dolore del Conte Ugolino, le parole sembrano più lente e dolorose.
L’enjabament che si collocano in questa terzina:
“e io senti’chiavar l’uscio
All’orribile torre; ond’io guardai
Nel viso a’mie’ figliuol senza far motto”
Accelerano la lettura del testo creando uno suspens che da la percezione che qualcosa sta per cambiare di colpo. Ora nella narrazione di Ugolino compaiono i suoi figli, Anselmuccio e Gaddo. La particolarità di queste terzine è il loro modo di trasmettere il silenzio e il dolore che adesso non è solo del Conte ma anche dei suoi figli che domandano del pane. L’endecasillabo più toccante è:
“Padre, assai ci fia men doglia
se tu mangi di noi: tu ne vestisti
queste misere carni, e tu le spoglia”.
Ugolino essendosi accorto della situazione drammatica e sentendosi impotente davanti al dolore dei figli, si morde le mani, proprio ad esorcizzare il dolore del cuore con il dolore fisico, ma i bambini nella loro ingenuità e amore verso il padre, pensano che lo faccia per fame, e offrono loro stessi pur di non vederlo soffrire, pronunciando una frase terribile ma allo stesso tempo impregnata d’amore, gli propongono di mangiarli, lui li ha creati e lui li può anche distruggere. Ugolino ripensando a quel momento grida: “ahi dura terra, perché non t’apristi?” un grido di liberazione e sfogo, di rabbia, mondo crudele e infame apriti e inghiottimi, ma non farmi vedere i miei figli soffrire a causa mia.
E ancora c’è un intercalare di silenzio, leggendo con attenzione questi versi, si ha la sensazione di essere presenti nella torre con il conte e i figli e di essere partecipi al loro calvario. Gaddo con una voce sferzata dalla fame si getta ai piedi del padre e chiede aiuto: “Padre mio, ché non mi aiuti?”, dopo aver detto questo muore, e in qualche modo si viene a rompere quell’equilibrio che si era creato con quegli spazi di silenzio, di colpo la situazione si ribalta, in soli due giorni, muoiono il resto dei figli di Ugolino.
La terzina che segue è forse una delle più famose della Divina Commedia:
“già cieco, a brancolar sovra ciascuno,
e due dì li chiamai, poi che fur morti.
Poscia, più che ‘l dolor, poté ‘l digiuno”
Questi tre versi si possono analizzare in due differenti modi: non considerando la cornice di fame del canto possiamo interpretare che: essendo passati 8 giorni senza cibo, vengono a mancare la vista e la lucidità celebrale, considerando anche la pressione psicologica del Conte Ugolino, la pazzia e la solitudine aumentano il suo dolore, il Conte chiama i suoi figli anche sapendo che sono morti. In questo contesto l’ultimo verso si colloca in modo perfetto, la fame non potè nulla contro il dolore e la pazzia, e anche lui si lasciò morire. Infatti Alcuni documenti dell’epoca, tramandano che quando fu aperta la torre dopo 9 giorni i corpi vennero trovati intatti; la tesi che Ugolino sia morto di fame viene avvalorata dal fatto che se si fosse cibato dei suoi figli sarebbe vissuto più di 9 giorni.
Ma non bisogna dimenticare che l’intero canto è incentrato sul mangiare e sulla fame, se non fosse stato così, non saremmo mai arrivati alla conclusione che Ugolino possa aver mangiato i suoi figli.
Una risposta a questo dilemma si può trovare anche analizzando i tratti psicologici che si evincono dal canto del Conte: un uomo potente in vita, audace e ribelle, ma dotato di grande affetto verso i suoi cari, il dolore che prova è sicuramente sincero, traendo spunto dal sogno che fa nella torre, possiamo accorgerci, che le cagne sono il simbolo della fame, che attaccano tutti i lupicini, compreso il padre,e che anche essendo stanchi, i lupicini, non vengono divorati dal padre.